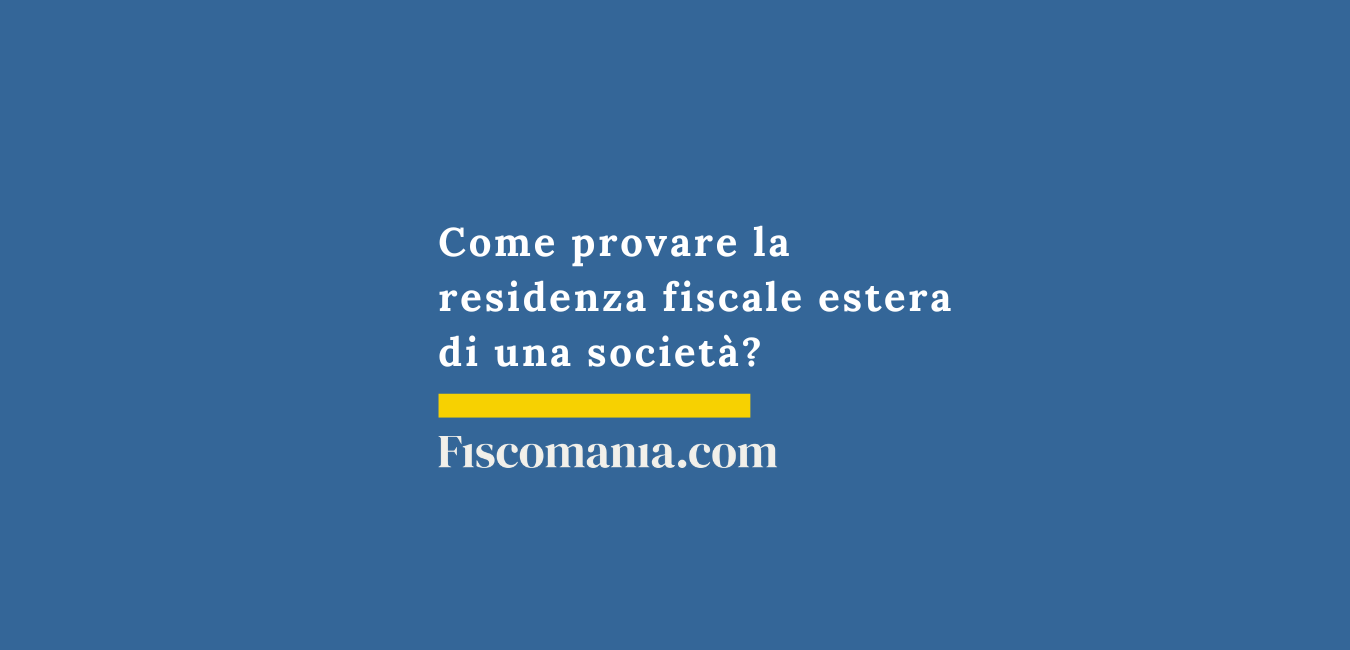La prova della residenza fiscale di una società costituita all’estero tra motivazione ed elementi fattuali in grado di giustificare il collegamento con il Paese estero di insediamento. Come l’Agenzia delle Entrate effettua accertamenti sulla residenza delle società.
Determinare correttamente la residenza fiscale di società ed enti in Italia è indispensabile al fine di pianificare l’imposizione worldwide e prevenire contestazioni di esterovestizione, oggi alla luce dei criteri aggiornati dell’art. 73 TUIR e degli standard OCSE 2017 sulla dual residence degli enti diversi dalle persone fisiche.
L’articolo illustra in modo operativo i criteri vigenti per il 2025, la centralità della “sede di direzione effettiva”, la “gestione ordinaria in via principale”, l’interazione con le Convenzioni contro le doppie imposizioni e le presunzioni legali relative contro l’esterovestizione, con check-list, esempi e difese probatorie.
Indice degli argomenti
- I criteri nazionali per la residenza fiscale (art. 73 TUIR)
- Il contrasto all’esterovestizione: le presunzioni legali relative
- La residenza fiscale degli enti nel diritto internazionale: Le Convenzioni OCSE
- Un focus sul trust: residenza e presunzioni specifiche
- Il trasferimento della sede nel corso del periodo d’imposta: il requisito temporale (split year)
- Il nesso tra esterovestizione e disciplina CFC (art. 167 TUIR)
- Risoluzione dei conflitti internazionali: il ruolo della MAP
- L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
- Consulenza fiscale online
I criteri nazionali per la residenza fiscale (art. 73 TUIR)
La residenza fiscale delle società e degli enti soggetti ad IRES è definita dall’articolo 73, comma 3, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Una società (o un ente) si considera residente nel territorio dello Stato se, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 o 184 giorni), ha alternativamente:
- La sede legale: indicata nell’atto costitutivo o nello statuto;
- La sede dell’amministrazione: il luogo ove viene svolta l’attività di gestione, da desumere da dati concreti quali, ad esempio, l’esistenza di uffici amministrativi o l’indicazione su documenti o fatture;
- Gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato: si identifica nel continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso, così che si possa dar rilievo al day-to-day management.
È cruciale notare che queste tre condizioni sono tra loro alternative. È sufficiente che si verifichi uno solo di questi criteri di collegamento con il territorio italiano affinché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia. Tale principio si applica anche alle società di persone e ai soggetti equiparati.
La sede legale
La sede legale è l’elemento giuridico “formale” per eccellenza, identificandosi con la sede sociale specificata nell’atto costitutivo o nello statuto.
La sede dell’amministrazione
Se la sede legale non è in Italia, si deve valutare la sede amministrativa. Questo è un criterio di effettività sostanziale. La sede dell’amministrazione è il luogo in cui si prendono le principali decisioni strategiche relative alla gestione o al perseguimento delle finalità dell’ente. Questa nozione coincide con la “sede effettiva” (di matrice civilistica) e con il concetto internazionale di “sede di direzione effettiva” (place of effective management).
Per determinare la sede effettiva, si valuta dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione, dove si convocano le assemblee e dove si accentrano gli organi e gli uffici societari. Non coincide necessariamente con il luogo di residenza degli amministratori.
Ai fini di questa valutazione di fatto, l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza valorizzano un complesso di fattori:
- Il luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale e la politica generale della società.
- Il luogo di riunione dell’organo gestorio della società. Può trattarsi del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo;
- Il luogo in cui i dirigenti esercitano le funzioni di gestione e direzione quotidiana (day-to-day management), che traducono in pratica le direttive programmatiche.
N.B. per i gruppi multinazionali: In un gruppo, l’attività di direzione e coordinamento strategico della capogruppo italiana verso una controllata estera non è sufficiente a radicare la sede amministrativa in Italia. Rileva il luogo in cui si esercita la funzione amministrativa quotidiana e continuativa della controllata stessa.
Gestione ordinaria in via principale
La “gestione ordinaria in via principale” orienta il baricentro operativo dove si realizza la governance day‑to‑day, con rilievo al personale direttivo, ai processi amministrativi e ai rapporti continuativi con terzi e istituti finanziari.
Anche questo è un requisito di carattere sostanziale. Si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Se tali atti mancano in forma pubblica o autenticata, si fa riferimento all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
Per le società con attività transnazionale, la localizzazione può essere complessa. Si deve considerare:
- Il principale mercato di destinazione (dove si realizza la maggior parte del fatturato o dei punti vendita);
- Il mercato di approvvigionamento (per alcuni settori);
- Paese in cui è impiegato il maggior numero di dipendenti o l’ammontare maggiore degli investimenti.
Per le Holding di gestione, l’oggetto principale si trova nel luogo dove vengono poste in essere le attività di direzione, coordinamento delle partecipate o servizi ausiliari (tesoreria, finanziamento), a prescindere dalla collocazione della sede delle controllate
Il contrasto all’esterovestizione: le presunzioni legali relative
Il legislatore, per contrastare la c.d. esterovestizione — la fittizia localizzazione della residenza fiscale all’estero, spesso in Paesi con regimi fiscali più vantaggiosi, al fine di sottrarsi al regime nazionale — ha introdotto specifiche presunzioni relative di residenza.
L’Amministrazione finanziaria si ispira al principio della substance over form (sostanza sulla forma) per valorizzare gli elementi di effettività.
Le presunzioni per società ed enti (art. 73, co. 5-bis)
Ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, si presume l’esistenza della sede dell’amministrazione in Italia (salvo prova contraria) quando una società o ente non residente detiene direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti e ricorre alternativamente una delle due seguenti condizioni:
- Controllo indiretto da parte di soggetti residenti: Il soggetto estero è controllato, anche indirettamente, da soggetti fiscalmente residenti in Italia. Il concetto di controllo richiamato è quello definito dall’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile (controllo di diritto, di fatto o influenza dominante). Rileva anche il controllo congiunto familiare;
- Amministrazione in prevalenza da soggetti residenti: L’ente estero è amministrato da un Consiglio di amministrazione o altro organo di gestione composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia. Questa condizione deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta.
Queste circostanze fattuali rendono ragionevole ipotizzare che le decisioni fondamentali di gestione siano assunte in Italia.
La prova contraria: come vincere la presunzione
La natura di queste presunzioni è relativa, il che significa che il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria per dimostrare l’effettiva non-residenza in Italia.
Per superare la presunzione e dimostrare la fittizia localizzazione, il contribuente deve fornire argomenti adeguati e convincenti che attestino il concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero.
Gli elementi di prova, che devono essere valutati caso per caso, non si limitano ai dati formali (come l’atto costitutivo) ma devono includere elementi di fatto concreti e sostanziali. Tra questi rientrano:
- Svolgimento effettivo delle riunioni: Prove del regolare e periodico svolgimento delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci presso la sede sociale estera (es. delibere formalmente prese all’estero, biglietti aerei, ricevute alberghiere degli amministratori residenti in Italia);
- Autonomia gestionale: Effettiva titolarità e concreto esercizio dei poteri decisionali da parte degli amministratori esteri, con adozione di atti volitivi (progetti, interventi per migliorare le performance);
- Struttura operativa estera: Effettività degli insediamenti produttivi/commerciali all’estero e un grado di autonomia funzionale (organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile) della società estera rispetto alla capogruppo italiana;
- Certificati di residenza fiscale esteri: Sebbene rilevanti ai fini della prova della non-residenza, non sono sufficienti da soli per rigettare la presunzione; necessitano di ulteriori elementi di prova di natura fattuale.
Per le Holding passive (di mera detenzione di partecipazioni), la prova contraria è particolarmente complessa a causa della mancanza di una struttura organizzativa apprezzabile, e deve vertere sull’inesistenza della sede dell’amministrazione in Italia e sulla localizzazione estera della stessa.
Effetti in caso di mancata prova contraria
Se la prova contraria manca, la società estera si considera, ad ogni effetto, residente nel territorio dello Stato e sarà soggetta a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali previsti dall’ordinamento italiano, incluso il pagamento dell’IRES su tutti i redditi ovunque prodotti (tassazione mondiale). Il tutto, con l’applicazione di sanzioni amministrative sulle imposte non versate e con responsabilità eventuali a carico degli amministratori, compresi qulli di fatto.
La residenza fiscale degli enti nel diritto internazionale: Le Convenzioni OCSE
Quando un soggetto è considerato residente in due Stati diversi in base alle rispettive legislazioni interne (caso di doppia residenza), subentrano le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI), basate generalmente sul Modello OCSE.
Le CDI mirano a risolvere i “conflitti” di residenza. La maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia sono conformi al Modello OCSE 2014. La versione 2014 attribuiva rilevanza automatica al criterio della “sede della direzione effettiva” (place of effective management – POEM) come regola risolutiva (tie-breaker rule). Se una persona diversa da una persona fisica era residente in entrambi gli Stati contraenti, era considerata residente soltanto dello Stato in cui si trovava la sede della sua direzione effettiva.
Il POEM è definito come il luogo dove sono prese le decisioni fondamentali di natura gestionale e commerciale necessarie per la gestione dell’impresa nel suo complesso.
L’evoluzione post-BEPS (Modello OCSE 2017 e MLI)
Il Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ha portato significative modifiche. La nuova formulazione dell’Articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE 2017 e l’Articolo 4 della Convenzione Multilaterale BEPS (MLI) hanno abbandonato il criterio automatico del POEM.
La risoluzione dei casi di doppia residenza per le entità diverse dalle persone fisiche è ora rimessa al comune accordo (mutual agreement) delle Autorità competenti dei due Paesi contraenti (case-by-case approach).
I fattori che le Autorità devono considerare includono:
- La sede di direzione effettiva (POEM);
- Il luogo in cui è stata registrata o costituita;
- Ogni altro fattore rilevante (luogo delle riunioni del CdA, sede centrale, luogo in cui i dirigenti esercitano l’ordinaria amministrazione, ecc.).
Importante: Se l’accordo tra gli Stati manca, la società dual-resident non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale previsto dalla Convenzione.
È importante ricordare che l’Italia ha esercitato la riserva per la disapplicazione integrale dell’Articolo 4 della Convenzione Multilaterale BEPS. Tuttavia, i trattati più recenti stipulati dall’Italia (come quelli con Colombia, Uruguay e Cina) seguono già il nuovo schema del mutual agreement.
Un focus sul trust: residenza e presunzioni specifiche
Anche il Trust è considerato un soggetto passivo IRES (tra gli enti non commerciali) e la sua residenza è determinata secondo i criteri generali dell’art. 73, comma 3, del TUIR (sede legale, sede amministrazione o oggetto principale). Ai fini pratici, rilevano soprattutto la sede dell’amministrazione (che può coincidere con il domicilio fiscale del trustee) e l’oggetto principale (l’ubicazione dei beni vincolati).
Le Convenzioni OCSE considerano il trust una “persona” (body of persons), rientrando nella categoria di “persona diversa da una persona fisica“.
L’Art. 73, comma 3, TUIR disciplina inoltre specifiche presunzioni per i trust istituiti in Paesi non cooperativi (Paesi con i quali non è attuabile lo scambio di informazioni, al di fuori della c.d. white list):
- Trust con collegamenti soggettivi in Italia: Se almeno uno dei disponenti (settlor) e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
- Trust con collegamenti oggettivi immobiliari: Se, successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettua a favore del trust un’attribuzione (trasferimento di proprietà o diritti reali) di beni immobili situati in Italia.
Anche in queste ipotesi, la presunzione è relativa, e il contribuente può fornire la prova contraria per dimostrare l’effettiva residenza fiscale all’estero del trust
Il trasferimento della sede nel corso del periodo d’imposta: il requisito temporale (split year)
Un aspetto spesso sottovalutato, ma critico per la pianificazione fiscale, riguarda la gestione del trasferimento della sede sociale (o degli altri elementi di collegamento) durante l’esercizio finanziario.
La verifica della residenza fiscale, in base all’Art. 73, comma 3, del TUIR, deve accertare la permanenza di uno dei criteri di collegamento (sede legale, sede amministrazione, oggetto principale) per “la maggior parte del periodo d’imposta“. L’Amministrazione finanziaria definisce tale periodo come almeno 183 o 184 giorni.
Le conseguenze fiscali del trasferimento dipendono dalla continuità giuridica dell’ente:
- Trasferimento dall’Italia all’estero (in continuità giuridica): L’ente risulterà residente in Italia per l’intero esercizio se il trasferimento si è perfezionato dopo che sia decorso un numero di giorni superiore alla metà del periodo d’imposta. A tal fine, rileva la data di cancellazione dal Registro delle imprese dello Stato estero;
- Trasferimento dall’Estero in Italia (in continuità giuridica): Il periodo d’imposta non si interrompe e l’ente risulterà residente in Italia per l’intero esercizio se il trasferimento si è perfezionato prima che sia decorso un numero di giorni pari alla metà del periodo d’imposta.
Questo approccio, basato sulla residenza per l’intero anno, differisce dalla configurazione asimmetrica di molti ordinamenti esteri che prevedono lo “split year” (interruzione istantanea dello status di residente/non residente), generando potenziali ipotesi di doppia imposizione o doppia esenzione.
Il nesso tra esterovestizione e disciplina CFC (art. 167 TUIR)
Nella fiscalità internazionale, la presunzione di residenza per esterovestizione (Art. 73, co. 5-bis) ha implicazioni dirette sulla disciplina delle Società Controllate Estere (Controlled Foreign Companies – CFC) di cui all’Art. 167 del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, se un soggetto residente controlla una società localizzata in un paradiso fiscale, e questa controllata estera viene riconosciuta come esterovestita (e quindi residente de facto in Italia):
- Inoperatività CFC: La presunzione di residenza dell’art. 73 rende inoperante la disciplina CFC (art. 167). Non potrà essere imputato al controllante residente il reddito della controllata esterovestita, poiché quest’ultima, in quanto residente in Italia, sarà tenuta a dichiarare tale reddito in Italia direttamente.
- Prova contraria: Qualora, invece, il contribuente riesca a fornire la prova contraria che l’effettiva sede dell’amministrazione è all’estero, la controllata resterà non residente ma sarà comunque attratta alla disciplina CFC (art. 167), se ne ricorrano i presupposti, e il relativo reddito verrà imputato per trasparenza al controllante italiano.
Risoluzione dei conflitti internazionali: il ruolo della MAP
Nello scenario post-BEPS e con l’introduzione del Modello OCSE 2017, la risoluzione dei casi di doppia residenza per le società (dual resident entities) ha abbandonato il criterio automatico del Place of Effective Management (POEM) in favore di un approccio basato sul comune accordo (Mutual Agreement) tra le Autorità Competenti.
In assenza di tale accordo, la società/ente dual-resident non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale prevista dalla Convenzione.
La Procedura Amichevole (MAP), disciplinata dall’Art. 25 del Modello OCSE, rappresenta lo strumento cruciale per risolvere tali conflitti. Il contribuente può ricorrere a tale procedura se ritiene di subire un’imposizione non conforme alla Convenzione. L’istanza può essere avanzata non appena è probabile la doppia residenza, e comunque entro tre anni dalla prima notifica della misura fiscale contestata (se la singola Convenzione non prevede termini più brevi). Questa procedura è fondamentale per ottenere una determinazione concordata e garantire i benefici convenzionali.
L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria
Dato questo quadro accertativo relativamente complesso è necessario ricordare che l’Amministrazione deve condurre adeguata e complessa indagine su:
- Business activity test: Si tratta del controllo sull’esistenza effettiva di attività imprenditoriale (industriale commerciale o di servizi). Attività svolta dalla società estera partecipata dal soggetto italiano nel luogo in cui questa è incorporata;
- Organization test: Si tratta del controllo sull’esistenza effettiva di un’organizzazione di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della predetta attività di impresa;
- Motive test: Si tratta del controllo in merito alla valutazione delle ragioni economiche che hanno indotto il soggetto controllante italiano a svolgere attività di impresa all’estero costruendo specifiche entities. Si tratta dell’elemento legato alla valida ragione economica che ha spinto l’impresa italiana a costituire una società controllata estera.
Le predette indagini andrebbero condotte sulla base, in particolare, degli elementi di carattere sostanziale, oltre che formale, sopra richiamati. Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha posto particolare importanza a questi elementi all’interno delle verifiche effettuate sulla residenza fiscale delle società costituite all’estero.
I tre test che sopra ho indicato rappresentano il banco di prova di ogni società costituita all’estero, e per questo è opportuno che le società interessate ed i gruppi multinazionali coinvolti si preparino in anticipo verso il superamento di test come questi. Farsi trovare impreparati in caso di accertamento, infatti, potrebbe non essere una mossa favorevole, soprattutto se si vuole incentivare una chiusura rapida e positiva del controllo.
La documentazione probatoria da esibire
La prova della residenza fiscale estera della società deve sempre essere adeguatamente documentata. Per questo motivo la società può predisporre una opportuna documentazione probatoria da esibire in caso di possibile accertamento fiscale.
Si, tratta in particolare di lasciare traccia dei seguenti elementi indicatori:
- Elemento soggettivo;
- Elemento oggettivo;
- Risultato raggiunto.
Elemento soggettivo
Dal punto di vista soggettivo rileva indiscutibilmente l’intenzione che ha guidato il comportamento del contribuente. Vale a dire il fatto che lo stesso sia o meno ispirato fin dall’inizio dall’intento (esclusivo o prevalente) di ottenere un risparmio di imposta, ottenibile attraverso una specifica “costruzione” del gruppo imprenditoriale.
Quello che deve essere documentato è che l’obiettivo di fondo della creazione del gruppo multinazionale e della società estera (su cui viene accertata la residenza) non è stato creato per il solo fine del risparmio dell’attenuazione del carico fiscale a livello consolidato.
L’attitudine al minor sacrificio possibile è un fenomeno naturale. Nei sistemi fiscali avanzati la propensione del contribuente ad evitare esposizioni al sacrificio tributario si manifesta non tanto con azioni di contrapposizione alle disposizioni fiscali. Piuttosto mediante comportamenti definibili di elusione fiscale.
Ne consegue che, ove la scelta imprenditoriale sia guidata da apprezzabili intenti, non potranno essere accettate contestazioni. L’Agenzia delle Entrate, in tal caso, non ha la possibilità di sindacare la scelta economica del contribuente che ha deciso di operare con una società controllata estera. In altri termini, il contribuente ha la possibilità indicare, sulla base di dati di fatto:
- Le motivazioni che lo hanno guidato nella scelta territoriale. Vale a dire il luogo di locazione degli enti giuridici che compongono il gruppo societario;
- La presenza di una concomitante scelta funzionale. Si tratta di una scelta di specializzazione delle singole entities;
- Infine, le ragioni imprenditoriali del gruppo. Ragioni che si esplicano nella gerarchia sottesa ai rapporti partecipativi che presiedono alla funzione svolta da ciascuna società nel gruppo.
In ottica negativa il primo indice sintomatico di una artificiosa residenza all’estero delle società controllate è l’assenza di una apprezzabile interesse economico e gestionale. Interesse che dovrebbe essere teso alla costituzione di società estere e non alla possibilità di sottrarre redditi allo stato di effettiva residenza delle stesse.
È per questo motivo che, quando mi chiedono una consulenza legata all’internazionalizzazione d’impresa, la prima domanda che pongo sempre è: “per quale motivo stai realizzando questo progetto di internazionalizzazione?“. Quando la risposta a questa domanda non è precisa e circostanziata, ma piuttosto vaga e generica il rischio di non superare accertamenti fiscali legati all’esterovestizione è rilevante.
Elemento oggettivo
Sotto il profilo oggettivo il più rilevante indice rivelatore di residenza in Italia dell’ente giuridico estero è rappresentato dall’assenza di autonomia. Mi riferisco all’assenza di stabile autonomia sotto il profilo organizzativo, amministrativo, finanziario e contabile della società estera. Con riguardo alle circostanze atte a dimostrare l’effettiva residenza all’estero degli enti giuridici controllati, costituiscono oggetto di prova della residenza:
- L’esistenza in Italia di attività di direzione e coordinamento all’interno del gruppo;
- L’essenza nel territorio dello Stato estero delle sede di direzione amministrativa della società partecipata.
Pertanto, oltre a dedurre elementi idonei a rappresentare l’effettiva sussistenza della sede amministrativa nel Paese di residenza, è opportuno dare evidenza agli elementi di fatto che integrano gli impulsi direttivi da parte della capogruppo italiana onde ricondurli al concetto di direzione e coordinamento del gruppo.
Al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza all’estero della sede dell’amministrazione della partecipata estera, sarebbe necessario fornire prova sull’assenza di un “attendibile collegamento territoriale con l’Italia“. In altri termini si devono considerare i seguenti elementi di fatto:
- L’attività del consiglio di amministrazione e le assemblee dei soci sono rivolte con regolarità;
- Le riunioni del consiglio di amministrazione sono tenute presso la sede sociale (eventualmente con riunioni in tele/videoconferenza). E la partecipazione dei diversi consiglieri è opportunamente consigliata (biglietti di viaggio, prenotazioni alberghiere, etc);
- La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è costituita da persone fisiche residenti in loco, effettivamente coinvolte nella gestione sociale. Si deve evitare che vi sia potere di firma sulle decisioni da parte di consiglieri di amministrazione esteri;
- La gestione operativa effettuata sul posto e le deleghe rilasciate a soggetti terzi residenti in Paesi diversi da quello ove è localizzata la sede della società hanno contenuti limitati.
Elemento organizzativo funzionale
Sotto il profilo organizzativo funzionale si evidenza l’opportunità di offrire prova di residenza attraverso una documentazione volta a provare:
- Effettività degli insediamenti produttivi/commerciali all’estero e delle ragioni imprenditoriali sottese agli stessi;
- Presenza di soci di minoranza nella catena di controllo ed esistenza di accordi parasociali;
- Modello organizzativo e funzionale del gruppo di imprese del quale le società estere fanno parte. Con evidenza della specializzazione di queste ultime, sia in senso geografico che economico;
- Descrizione dei flussi informativi e contrattuali intercompany. Flussi dai quali potrebbe desumersi la totale indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding;
- Esistenza o meno di sistemi di tesoreria centralizzata (“cash pooling“), rilevanti ai fini della dimostrazione dell’autonomia finanziaria delle società estere rispetto all’ente controllante;
- Grado di autonomia gestionale dei soggetti preposto all’attività di impresa all’estero (c.d. “country manager“). In termini di organizzazione del personale ed in termini di spesa.
La sezione internazionale
Sul piano del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale l’Amministrazione finanziaria pone sempre maggiore attenzione. In particolare nei confronti delle operazioni economiche aventi rilevanza internazionale. Ne è prova il fatto che all’interno della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate sia stata istituita la struttura “Sezione Internazionale“. Si tratta di una struttura che ha lo scopo di incrementare i controlli fiscali a livello transnazionale. Obiettivo, questo, che può essere raggiunto attraverso:
- Un esaustivo e tempestivo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi;
- La collaborazione tra i funzionari dei diversi Stati membri dell’UE;
- L’effettuazione di controlli simultanei bilaterali e/o multilaterali;
- Infine, l’assistenza alla notifica degli atti emessi nei confronti di soggetti non residenti o di contribuenti italiani che abbiano trasferito la propria residenza in altri Stati membri UE.
Tradizionalmente, i fenomeni rilevanti ai fini di evasione ed elusione fiscale internazionale sulla residenza fiscale si legano a due tipologie di condotta:
- Trasferimento della residenza ai fini fiscali da parte del contribuente (persona fisica o giuridica). Si realizza mediante il posizionamento strumentale del soggetto in uno Stato in cui la pressione fiscale risulta più favorevole rispetto a quella di origine;
- Trasferimento, in tutto o in parte, del reddito imponibile, che può realizzarsi sia mediante l’allocazione strumentale delle fonti di produzione del reddito stesso. Vedi dividendi e royalties.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo molto probabilmente vuoi risolvere dei dubbi riguardanti la residenza fiscale di una società estera. Come avrai capito si tratta di un aspetto molto specifico che richiede particolare attenzione, competenza, ed esperienza. Classico caso è quello della persona fisica residente in Italia che costituisce una società estera o una holding estera di partecipazioni da lui gestita direttamente dall’Italia. Questa ipotesi è sicuramente la principale casistica di esterovestizione che, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 73, commi 3 e 5-bis del TUIR, viene contestata oggi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Accanto a questa casistica vi sono poi tutti i casi legati alla costituzione di subsidiary estere da parte dei gruppi multinazionali italiani. In questi casi, tuttavia, le casistiche di contestazione diminuiscono considerata l’attitudine dei gruppi multinazionali ad investire in questo tipo di operazioni. Per questo motivo la maggiore attenzione su questi aspetti deve essere posta da parte di PMI, azienda familiari e privati, che pensano che costituire una società all’estero sia ancora oggi la panacea di tutti i mali per ridurre il carico fiscale. Oggi la costituzione di società estere se non accompagnata da una adeguata attività di advisory legata alla prevenzione di possibili accertamenti (con la costituzione di appositi fascicoli documentali sulla residenza), comporta l’esposizione ed accertamenti fiscali.
Per questo motivo se stai cercando un commercialista esperto in questi ambiti e che possa affiancarti su questo aspetto siamo a disposizione. Compila il form di contatto seguente per metterti immediatamente in contatto con noi. Ti risponderemo nel più breve tempo e ti forniremo il nostro supporto tramite preventivo.