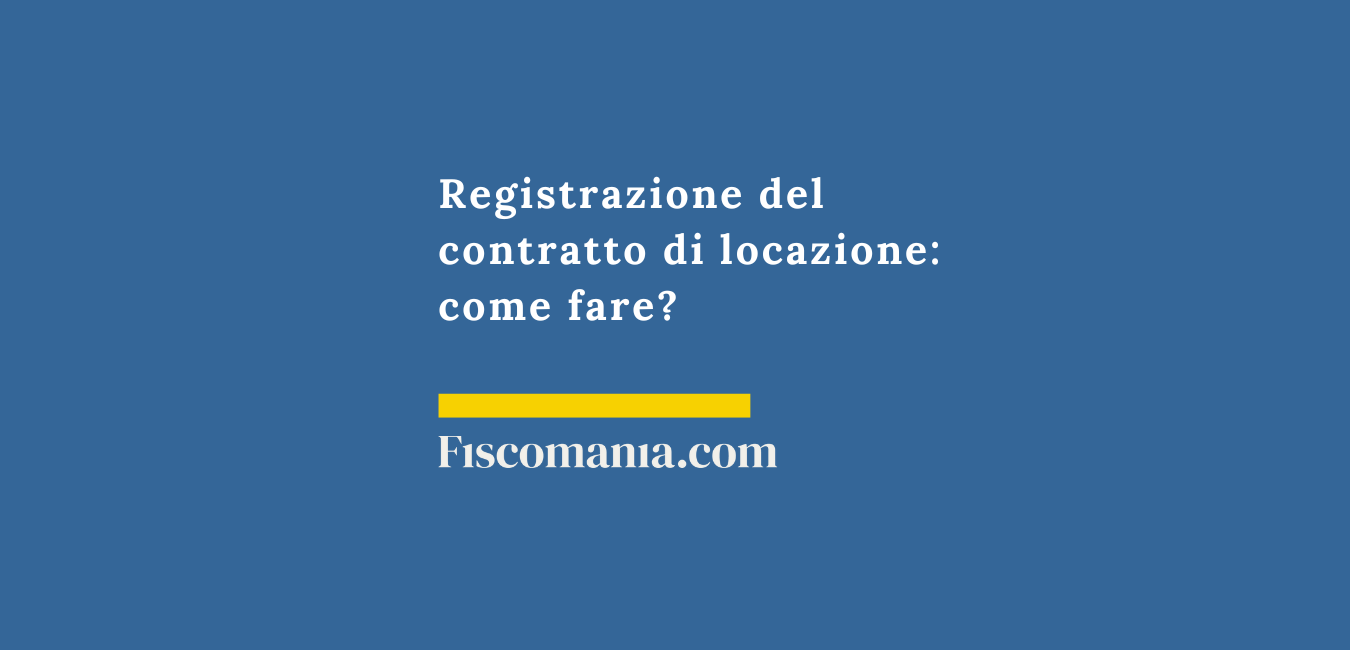Guida completa alla registrazione del contratto di locazione: procedure, costi, modello RLI e cedolare secca. Tutte le informazioni per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.
Quando si stipula un contratto di locazione immobiliare, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio obbligatorio che molti proprietari e inquilini affrontano con incertezza. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di un adempimento fiscale che genera precisi effetti giuridici e tributari, incidendo sulla validità stessa del contratto e sulla posizione fiscale delle parti. La mancata o tardiva registrazione può comportare conseguenze significative, dalla nullità del rapporto locatizio fino a sanzioni amministrative rilevanti. Comprendere quando scatta l’obbligo, quali modalità operative scegliere tra procedura telematica e cartacea, e come gestire correttamente gli aspetti fiscali legati all’imposta di registro o alla cedolare secca diventa quindi essenziale per evitare errori che potrebbero costare caro.
Indice degli argomenti
- L’obbligo di registrazione del contratto di locazione
- Chi deve provvedere alla registrazione
- Il modello RLI: cos’è e come funziona
- La procedura di registrazione telematica con RLI-web
- L’allegazione del contratto in formato digitale
- Il calcolo delle imposte: registro, bollo e cedolare secca
- I dati da indicare nel modello RLI
- Il pagamento delle imposte
- La cedolare secca: quando conviene
- Disciplina Iva sulla locazione abitativa
- Imposta di registro sul contratto di locazione immobiliare
- Le sanzioni per omessa o tardiva registrazione
- Gli adempimenti successivi alla registrazione
- Consulenza fiscale online
- Fonti
L’obbligo di registrazione del contratto di locazione
La normativa impone la registrazione di tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili la cui durata complessiva superi i 30 giorni nell’arco dell’anno solare. Questo obbligo vale indipendentemente dall’importo del canone pattuito e si applica sia agli immobili ad uso abitativo sia a quelli strumentali, includendo anche i fondi rustici e i contratti stipulati da soggetti passivi IVA.
L’elemento temporale dei 30 giorni deve essere calcolato considerando la durata complessiva annua per conduttore, non quella di ogni singolo contratto. Immaginiamo un proprietario che affitta il proprio appartamento al mare per due periodi di 20 giorni ciascuno allo stesso conduttore nello stesso anno: in questo caso, sommando le durate (40 giorni totali), scatta l’obbligo di registrare il secondo contratto. Le cosiddette locazioni brevi turistiche, purché non superino complessivamente i 30 giorni annui, restano quindi esenti dall’obbligo di registrazione, anche se il reddito percepito deve comunque essere dichiarato.
Il termine per adempiere all’obbligo è fissato entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. Se un contratto viene firmato il 15 gennaio 2026 ma ha decorrenza dal 1 gennaio 2026, il termine per la registrazione scade il 31 gennaio 2026, calcolato dalla data di decorrenza che risulta anteriore. Questa regola tutela l’inquilino, garantendo che il periodo di effettivo godimento dell’immobile sia coperto fin dall’inizio dalla registrazione.
La registrazione del contratto di locazione entro i termini previsti rappresenta il primo presidio contro contestazioni future. Un contratto non registrato è civilmente nullo per il periodo anteriore alla registrazione, con conseguente obbligo di restituzione dei canoni eventualmente percepiti. Su un contratto con canone mensile di 800 euro, la mancata registrazione per sei mesi comporterebbe la restituzione di 4.800 euro, oltre alle sanzioni fiscali che possono arrivare fino al 120% dell’imposta dovuta.
Chi deve provvedere alla registrazione
Dal punto di vista formale, l’obbligo di registrazione grava sul locatore, ovvero il proprietario dell’immobile. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti chiarito che la responsabilità primaria ricade sul soggetto che percepisce il canone. Tuttavia, sia il locatore che il conduttore sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta di registro dovuta, e ciascuno può autonomamente richiedere la registrazione qualora l’altra parte non provveda.
Questa solidarietà implica che l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi indifferentemente a entrambe le parti per riscuotere quanto dovuto. Nei rapporti interni tra locatore e conduttore, solitamente le spese di registrazione vengono ripartite al 50 per cento, salvo diverso accordo contrattuale. Nella prassi, molti proprietari preferiscono gestire direttamente l’adempimento per mantenere il controllo sulla procedura, ma l’inquilino conserva sempre il diritto di registrare il contratto autonomamente se il locatore risulta inadempiente.
In caso di pluralità di locatori o conduttori, è sufficiente che uno solo di essi effettui la registrazione. L’importante è che i dati di tutte le parti vengano correttamente indicati nel modello RLI, in modo che l’Agenzia delle Entrate possa identificare tutti i soggetti coinvolti nel rapporto locatizio.
Il modello RLI: cos’è e come funziona
Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) costituisce lo strumento ufficiale attraverso cui richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili presso l’Agenzia delle Entrate. Approvato con provvedimento del 19 marzo 2019, numero 64442, e aggiornato da ultimo il 14 ottobre 2025 e il 20 ottobre 2025, questo modello ha sostituito il precedente modello 69 per tutte le operazioni relative ai contratti di locazione.
Il modello RLI serve non soltanto per la prima registrazione, ma anche per comunicare tutti gli adempimenti successivi che possono intervenire nel corso del rapporto: proroghe contrattuali, risoluzioni anticipate, cessioni del contratto, subentri di nuovi conduttori, rinegoziazioni del canone. Inoltre, attraverso questo modello è possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca o revocarla, comunicare i dati catastali dell’immobile e segnalare eventuali variazioni rilevanti.
La compilazione del modello RLI può avvenire in due modalità distinte. La prima è la procedura telematica, accessibile tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (RLI-web) utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Questa modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e per i possessori di almeno 10 unità immobiliari, mentre rimane facoltativa per tutti gli altri contribuenti abilitati ai servizi telematici. La seconda è la presentazione cartacea del modello presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di recarsi specificamente presso l’ufficio competente in base al domicilio fiscale.
La procedura di registrazione telematica con RLI-web
Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS, il contribuente può utilizzare il servizio RLI-web senza installare alcun software sul proprio computer. Dopo l’autenticazione, è sufficiente selezionare dalla sezione Servizi la categoria Fabbricati e terreni, quindi Contratti di locazione, e cliccare su Nuova richiesta per avviare la compilazione guidata del modello.
Il sistema richiede innanzitutto di specificare se la registrazione viene effettuata per sé stessi oppure per conto terzi, ad esempio in qualità di rappresentante legale o intermediario abilitato. Successivamente occorre inserire una descrizione libera del contratto, elemento obbligatorio per l’identificazione della pratica, evitando di lasciare spazi tra le parole. Il passaggio successivo prevede la selezione della tipologia di richiedente e della tipologia di contratto tra le numerose opzioni disponibili, che spaziano dalle locazioni abitative a canone libero o concordato fino agli affitti di fondi rustici.
La compilazione prosegue con l’inserimento dei dati generali del contratto: l’ufficio territoriale presso cui si intende registrare l’atto, la data di stipula e di decorrenza, la durata concordata, l’importo del canone annuo. Per i fabbricati abitativi l’imposta di registro ammonta al 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero di annualità, mentre per i fondi rustici la percentuale scende allo 0,50 per cento. Nei contratti a canone concordato relativi a immobili situati nei Comuni ad elevata tensione abitativa, la base imponibile si riduce del 30 per cento, calcolando l’imposta sul 70 per cento del canone pattuito.
La scelta tra cedolare secca e regime ordinario richiede un’attenta valutazione della situazione reddituale complessiva del locatore. Per contribuenti con redditi elevati che superano il terzo scaglione IRPEF, la cedolare secca al 21 per cento risulta quasi sempre conveniente, evitando di far cumulare il reddito da locazione con quello già elevato e scongiurando il salto di scaglione. Al contrario, per chi ha redditi molto bassi, al di sotto della soglia di esenzione fiscale di 8.500 euro annui, aderire alla cedolare comporterebbe il pagamento dell’imposta anche su redditi che altrimenti non sarebbero tassati in regime ordinario.
L’allegazione del contratto in formato digitale
Quando si utilizza la procedura telematica tramite RLI-web, in determinati casi è obbligatorio allegare la copia digitale del contratto di locazione. Il file deve essere in formato TIF, TIFF o PDF/A (specificamente PDF/A-1a o PDF/A-1b) e contenere sia il contratto sottoscritto dalle parti sia eventuali documenti allegati come scritture private, inventari, mappe o planimetrie.
L’obbligo di allegazione non sussiste quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- La locazione riguarda immobili ad uso abitativo;
- Il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione;
- Il numero di locatori e di conduttori non supera tre per ciascuna parte;
- Il contratto ha ad oggetto una sola unità abitativa e un numero massimo di tre pertinenze;
- Tutti gli immobili risultano censiti con attribuzione di rendita catastale;
- Il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione senza ulteriori pattuizioni.
Se anche solo una di queste condizioni non si verifica, l’allegazione del contratto diventa obbligatoria.
Prima di procedere al caricamento, il sistema permette di validare il formato del file attraverso uno specifico servizio di verifica e conversione disponibile nell’area Assistenza. Questo strumento consente di controllare che il documento rispetti i requisiti tecnici richiesti, evitando errori di caricamento che bloccherebbero l’invio della pratica.
Il calcolo delle imposte: registro, bollo e cedolare secca
Al momento della registrazione occorre versare l’imposta di registro, calcolata secondo le aliquote previste in base alla tipologia di immobile. Per gli immobili abitativi l’aliquota è del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto, con un minimo di 67 euro per la prima annualità. Se un contratto quadriennale prevede un canone di 10.000 euro annui, l’imposta di registro ammonta a 800 euro (2 per cento di 10.000 euro per quattro anni), da versare interamente alla registrazione oppure annualmente nella misura di 200 euro per anno.
Per i fabbricati strumentali le percentuali variano: l’1 per cento se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA, il 2 per cento negli altri casi. I fondi rustici beneficiano dell’aliquota ridotta dello 0,50 per cento sul corrispettivo annuo moltiplicato per le annualità.
Oltre all’imposta di registro, è dovuta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni quattro facciate scritte del contratto, comunque ogni 100 righe. Se il contratto si compone di sei pagine, occorrono due marche da bollo da 16 euro ciascuna, per un totale di 32 euro. L’imposta di bollo si assolve mediante l’utilizzo di contrassegni telematici (le moderne marche da bollo digitali) da acquistare con data non successiva a quella di stipula del contratto.
Scegliendo la cedolare secca, il locatore persona fisica che affitta immobili abitativi può beneficiare di un regime sostitutivo che esonera dal pagamento sia dell’imposta di registro sia dell’imposta di bollo. Le aliquote della cedolare secca per il 2025 sono tre: 21 per cento per i contratti a canone libero, 10 per cento per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa, 26 per cento per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile affittato nell’anno. Il primo immobile destinato ad affitti brevi può ancora beneficiare dell’aliquota del 21 per cento.
I dati da indicare nel modello RLI
La sezione Soggetti del modello RLI richiede l’inserimento dei dati identificativi di tutti i locatori e i conduttori, compresi codice fiscale, dati anagrafici completi e domicilio. Per ciascun soggetto va specificato se si tratta di persona fisica o giuridica, e nel caso di società o enti occorre indicare la denominazione sociale e la sede legale.
Nel quadro Immobili devono essere riportati i dati catastali di ogni unità immobiliare oggetto del contratto: Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno, categoria catastale e rendita. Se il contratto riguarda un immobile principale con pertinenze, è importante indicare prima l’unità abitativa principale e immediatamente dopo le relative pertinenze, mantenendo l’ordine corretto per consentire al sistema di associare automaticamente gli immobili.
Particolare attenzione merita la compilazione del quadro Dati generali, dove oltre alle informazioni sul contratto occorre indicare eventuali casi particolari. Si tratta di quelli legati ai seguenti codici:
- 1 – segnala la presenza di canoni diversi per una o più annualità, situazione frequente nei contratti che prevedono aumenti programmati del canone nel tempo;
- 2 – identifica i contratti di sublocazione;
- 3 – si utilizza quando si vuole versare l’imposta di registro per tutte le annualità pur avendo canoni variabili.
Il pagamento delle imposte
Per la registrazione telematica tramite RLI-web, il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente o all’intermediario abilitato. È necessario indicare nel modello le coordinate IBAN del conto su cui effettuare l’addebito, verificando che la banca o la posta aderiscano alle convenzioni con l’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, si può utilizzare il modello F24 Elementi identificativi, compilandolo con i seguenti codici tributo: 1500 per l’imposta di registro dovuta per la prima registrazione, 1501 per le annualità successive. Nel caso di registrazione tardiva, occorre calcolare e versare anche le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1507 per le sanzioni e il codice 1508 per gli interessi.
Il versamento minimo per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Se il calcolo dell’imposta di registro risulta inferiore a questa soglia, occorre comunque versare l’importo minimo. Questo limite non si applica invece alle annualità successive, per le quali si versa l’importo effettivamente dovuto anche se inferiore a 67 euro.
La cedolare secca: quando conviene
L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata al momento della registrazione del contratto oppure nelle annualità successive, in occasione delle proroghe o dei rinnovi. Per i contratti già in essere, l’adesione va comunicata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. La scelta del regime sostitutivo vincola per l’intera durata del contratto o della proroga, e comporta la rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone previsto contrattualmente.
La convenienza della cedolare secca deve essere valutata caso per caso, considerando il reddito complessivo del proprietario. Per contribuenti con redditi medio-alti che già versano IRPEF al 35 o al 43 per cento, aderire alla cedolare al 21 per cento comporta un notevole risparmio fiscale. Chi percepisce un canone annuo di 12.000 euro e ha un reddito complessivo tale da collocarlo nell’ultimo scaglione IRPEF (43 per cento), in regime ordinario pagherebbe circa 5.160 euro di imposte (43 per cento di 12.000 euro), mentre con la cedolare secca verserebbe soltanto 2.520 euro (21 per cento di 12.000 euro), risparmiando 2.640 euro annui.
Al contrario, per chi ha redditi molto bassi, inferiori alla soglia di 8.500 euro annui esenti da tassazione, la cedolare secca risulterebbe svantaggiosa perché imporrebbe il pagamento dell’imposta sostitutiva anche su redditi che altrimenti non sarebbero tassati. In questi casi è preferibile rimanere nel regime ordinario IRPEF, beneficiando della no tax area.
Contratti a canone concordato
Particolarmente vantaggiosa è la cedolare secca al 10 per cento riservata ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa. Tra questi rientrano le principali città italiane come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Venezia, Palermo, Catania, Bari, Genova. Per accedere a questa aliquota ridotta, il contratto deve rispettare i parametri stabiliti dagli Accordi Territoriali sottoscritti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Su un canone annuo di 10.000 euro, l’imposta si riduce a soli 1.000 euro, contro i 2.100 euro della cedolare ordinaria al 21 per cento o i 2.000 euro dell’imposta di registro in regime ordinario.
Disciplina Iva sulla locazione abitativa
Da un punto di vista delle imposte indirette la locazione di fabbricati da parte di soggetti passivi Iva, prevede un regime naturale di esenzione. Questo è previsto ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, sia per i fabbricati abitativi, che per quelli strumentali. Per questi ultimi è possibile, su opzione passare al regime di imponibilità Iva dei canoni di locazione.
Prima di affrontare più in dettaglio la disciplina ricordiamo che sono considerati fabbricati abitativi, tutti gli immobili accatastati nella categoria A, esclusa la categoria A/10 (a prescindere dalle effettive modalità di utilizzo). Mentre i fabbricati strumentali sono quelli rientranti nelle categorie A/10, B, C, D, E (a prescindere dalle effettive modalità di utilizzo). Fatta eccezione per gli immobili pertinenziali di fabbricati abitativi.
Applicazione dell’Iva nella locazione di fabbricati abitativi
Per i fabbricati ad uso abitativo (gruppo catastale A, esclusa A/10), la regola generale è quella dell’esenzione dall’Iva. La disciplina Iva della locazione di immobili ad uso abitativo è contenuta nell’articolo 10, comma 1, n. 8, del DPR n. 633/72. Norma che prevede un regime di imponibilità ad Iva su “opzione“, per le locazioni poste in essere dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici e per le operazioni eseguite nell’ambito del cd. “housing sociale“. In generale prevede regime di esenzione in tutti gli altri casi. Sono, infatti, imponibili Iva mediante opzione del locatore da manifestare nel contratto di affitto, le locazioni di:
- Abitazioni, effettuate dalle imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito lavori di recupero incisivo (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica);
- Alloggi sociali, come individuati dal D.M. 22 aprile 2008, effettuate da qualsiasi impresa (anche non costruttrice o ristrutturatrice).
In entrambi i casi di imponibilità su “opzione“, l’Iva si applica con l’aliquota del 10%. Questo ai sensi del n. 127-duodecicies nella tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72. Inoltre, l’operazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di Registro nella misura fissa di € 67,00 ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, annessa al DPR n. 131/1986. Al di fuori delle ipotesi ora descritte, la locazione di abitazioni (poste in essere da soggetti, esercenti attività commerciale, diversi dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici o aventi ad oggetto abitazioni diverse dagli alloggi sociali) sono operazioni esenti da Iva. In questo caso le operazioni sono soggette all’imposta di Registro in misura pari al 2%.
Tabella di riepilogo
| Locatore | Tipo di abitazione | IVA | Registro |
|---|---|---|---|
| Impresa costruttrice o ristrutturatrice | Abitazione | IVA su opzione 10% | € 67,00 |
| Impresa costruttrice o ristrutturatrice | Alloggio sociale | IVA su opzione 10% | € 67,00 |
| Altre imprese | Abitazione | Esente | 2% |
| Altre imprese | Alloggio sociale | IVA su opzione 10% | € 67,00 |
Applicazione dell’Iva nelle locazioni di fabbricati strumentali
L’articolo 10, comma 1, n 8, del DPR n. 633/1972 disciplina il regime Iva applicabile alla locazione di immobili strumentali. Tale norma prevede, come regime generale, l’esenzione. Fatta salva la possibilità per il locatore di poter esercitare il diritto di opzione direttamente nel contratto di affitto. Nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imponibilità Iva, l’aliquota da applicare è quella del 22%, assieme all’applicazione dell’imposta di registro con aliquota dell’1%. L’imposta di registro sia in sede di registrazione che in sede di rinnovo annuale l’aliquota dell’imposta di registro resta dell’1%, anche nel caso di esenzione IVA del contratto.
| Locatore | Opzione | IVA | Registro |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi impresa | SI | 22% | 1% |
| Qualsiasi impresa | NO | Esente | 1% |
Imposta di registro sul contratto di locazione immobiliare
L’imposta di registro è commisurata al canone pattuito ed è dovuta da chi registra il contratto, solitamente il proprietario. Tale soggetto ha facoltà di rivalersi sull’inquilino, se il contratto lo prevede, nella misura del 50% di quanto pagato. L’imposta di registro ha un valore variabile a seconda del tipo di immobile locato. Gli importi sono riepilogati nella tabella seguente.
| Fabbricato ad uso abitativo | 2% del canone annuo per il numero delle annualità |
| Fabbricati strumentali per natura | 1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva (es: uso commerciale), 2% del canone, negli altri casi |
| Fondi rustici | 0,50% del corrispettivo annuo per il numero delle annualità |
| Altri immobili | 2% del corrispettivo annuo per il numero delle annualità |
Per i contratti di locazione a canone concordato, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. L’imposta di registro è dovuta con un minimo di €. 67,00 al momento della registrazione (il rinnovo per le annualità successive non prevede alcun importo minimo) ed ogni anno, al rinnovo del contratto.
È tuttavia possibile versare l’imposta di registro per più annualità in un’unica soluzione fruendo, in tal caso, di una riduzione degli importi dovuti. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a €. 67,00. Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto. Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
L’imposta di registro sul contratto di locazione pluriennale
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
- Pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo);
- Versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,05% dal 1° gennaio 2020) moltiplicato per il numero delle annualità. Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a €. 67,00. Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno. Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di €. 67,00. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Le sanzioni per omessa o tardiva registrazione
La mancata registrazione del contratto di locazione comporta pesanti conseguenze sia dal punto di vista civilistico sia da quello fiscale. Sul piano civile, il contratto non registrato è nullo per il periodo precedente alla registrazione, con conseguente obbligo per il locatore di restituire i canoni eventualmente percepiti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte confermato questo principio, sottolineando che la registrazione tardiva sana la situazione solo per il futuro ma non elimina la nullità pregressa.
Dal punto di vista tributario, l’omessa registrazione integra una violazione fiscale punita con sanzioni amministrative comprese tra il 120 e il 240 per cento dell’imposta dovuta. Su un contratto con imposta di registro pari a 1.000 euro, la sanzione minima ammonta quindi a 1.200 euro, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati al tasso legale. In caso di parziale occultamento del canone la sanzione va dal duecento al quattrocento per cento della maggiore imposta dovuta.
La registrazione tardiva, effettuata spontaneamente dal contribuente prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un accertamento, consente di avvalersi del ravvedimento operoso che riduce significativamente le sanzioni.
Per registrare tardivamente il contratto occorre compilare il modello RLI indicando la data effettiva di stipula, calcolare l’imposta di registro dovuta e versare anche sanzioni e interessi utilizzando i codici tributo 1507 e 1508 nel modello F24. Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate calcola automaticamente sanzioni e interessi, ma è sempre opportuno verificare la correttezza dei conteggi prima di procedere al versamento.
Gli adempimenti successivi alla registrazione
Una volta completata la registrazione, entro 60 giorni il locatore deve comunicare all’inquilino l’avvenuta registrazione del contratto, fornendo gli estremi dell’ufficio presso cui è stata effettuata e il numero di protocollo assegnato. Questa comunicazione va effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC se l’inquilino ha fornito un indirizzo di posta elettronica certificata.
Contestualmente, il proprietario deve comunicare all’amministratore del condominio i dati del nuovo inquilino per l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. Questa comunicazione è obbligatoria anche quando l’immobile locato non ha parti comuni con altri appartamenti, al fine di consentire la corretta tenuta dell’anagrafe da parte dell’amministratore.
Per i contratti di durata pluriennale, alla scadenza di ogni annualità successiva alla prima occorre versare l’imposta di registro per l’annualità che sta per iniziare. Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1501. L’importo dovuto per ogni annualità è pari al 2 per cento del canone annuo, senza applicazione dell’importo minimo di 67 euro che vale soltanto per la prima registrazione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, entro 30 giorni dalla data di cessazione occorre comunicare la risoluzione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI. Questa comunicazione consente di evitare il versamento delle imposte per le annualità successive ormai non dovute, e in alcuni casi permette di ottenere il rimborso di quanto versato per periodi successivi alla risoluzione. Se la risoluzione interviene a metà dell’anno, il rimborso spetta per la parte di annualità non goduta, proporzionalmente ai mesi residui.
Consulenza fiscale online
La registrazione del contratto di locazione rappresenta un adempimento fiscale che richiede attenzione e tempestività per evitare conseguenze negative sia sul piano civilistico sia su quello tributario. La scelta tra procedura telematica e cartacea, tra cedolare secca e regime ordinario, va valutata attentamente considerando la propria situazione reddituale e gli obiettivi di pianificazione fiscale. Rispettare i termini di 30 giorni dalla stipula o decorrenza del contratto consente di mettersi al riparo da sanzioni rilevanti e di garantire la piena validità del rapporto locatizio. L’evoluzione normativa in materia di locazioni abitative e l’aggiornamento costante del modello RLI richiedono un monitoraggio continuo delle novità per assicurare la corretta gestione degli adempimenti nel tempo.
Per approfondimenti personalizzati sulla tua situazione fiscale, contattaci per una consulenza online.
Fonti
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, articolo 2, articolo 3 e articolo 5 della Tariffa Parte I ù
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, articolo 2-bis della Tariffa Parte II
- Legge 9 dicembre 1998, numero 431, articolo 13
- Legge 27 luglio 1978, numero 392, articolo 8
- Decreto Legislativo 14 marzo 2011, numero 23, articolo 3
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 19 marzo 2019, numero 64442
- Aggiornamenti modello RLI del 14 ottobre 2025 e del 20 ottobre 2025