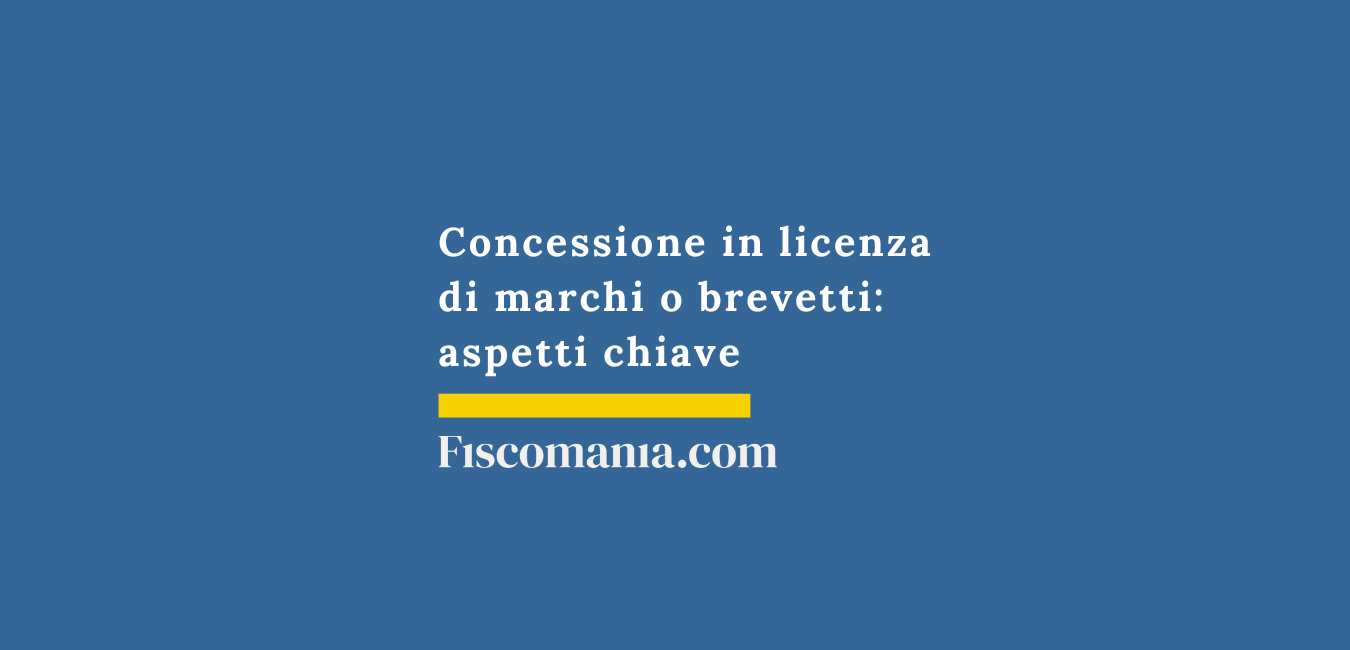Una licenza di marchio è un accordo legale attraverso il quale il titolare di un marchio registrato (licenziante) concede a un’altra parte (licenziatario) il permesso di utilizzare il marchio in conformità con termini e condizioni specifici. Questo tipo di licenza permette al licenziatario di utilizzare il marchio per identificare o promuovere prodotti o servizi che spesso non sono direttamente prodotti o forniti dal titolare del marchio.
Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale può avvenire mediante cessione tra le parti, con la conseguente acquisizione della proprietà industriale e di tutti i diritti dalla stessa derivanti al nuovo proprietario, oppure tramite la concessione in licenza (contratto di licensing).
Nel panorama economico odierno, la proprietà intellettuale assume un ruolo di primaria importanza. Essa rappresenta un’asset strategico per le imprese, che investono tempo e risorse per la sua creazione e tutela. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale può avvenire in diverse modalità, tra cui la concessione in licenza.
Nella pratica quotidiana questo tipo di contratti sono frequenti, sia in ambito nazionale che internazionale. Conoscere la struttura e gli aspetti fiscali di questo tipo di contratti può fare la differenza, sia per il rispetto della compliance normativa, che per fare i propri interessi in una trattativa. Inoltre, conoscere e rispettare gli aspetti fiscali rilevanti può essere di aiuto per superare eventuali controlli in modo positivo.
Indice degli argomenti
La concessione in licenza
La licenza si configura come un contratto mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede a un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare, in tutto o in parte, tale diritto. La licenza può riguardare diverse tipologie di opere, tra cui invenzioni brevettate, marchi, design, software, opere letterarie e artistiche (tutelate da diritti d’autore).
Gli accordi di licenza vengono generalmente utilizzati quando un soggetto, titolare di un’opera, non vuole cedere ad altri il diritto su di essa, ma anzi, vuole al massimo autorizzare il terzo al suo utilizzo, alla produzione o distribuzione di una certa tecnologia o prodotto, entro comunque certi limiti stabiliti tra le parti.
Detti accordi possono quindi avere ad oggetto uno specifico titolo (un marchio o un brevetto) ma anche tutti i diritti di proprietà intellettuale che riguardano quel determinato marchio, prodotto o tecnologia (es. la licenza di uso e commercializzazione di un determinato bene).
Attraverso la concessione in licenza il licenziante quindi non trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, restandone l’effettivo titolare, ma concede invero a soggetti terzi il diritto d’uso sullo stesso, mantenendone la proprietà.
Tipi di licenze
Chiaramente il contenuto del contratto di licenza varia non solo a seconda degli accordi intercorsi tra le parti ma anche dal tipo di diritto oggetto del contratto e del settore di riferimento.
Licenza obbligatoria per mancata attuazione del brevetto (artt. 69, 70, 71 c.p.i)
L’art. 69 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o “c.p.i.”) prevede che il titolare di un brevetto debba attuare l’invenzione oggetto del brevetto medesimo.
Il titolare dello stesso ha tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda (se questo termine scade successivamente al triennio dal rilascio) per attuare l’invenzione. Tale onere di attuazione permane durante tutta la vita del brevetto, anche nel caso in cui detta attuazione sia stata sospesa o interrotta per tre anni.
Art. 70 Codice proprietà industriale
A tale proposito l’art. 70 del Codice della Proprietà industriale disciplina la fattispecie della licenza obbligatoria stabilendo che:
“Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’organizzazione mondiale del commercio, ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 71 a 74 e 81 octies si applicano anche ai diritti sul brevetto europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale”.
Rifiuto di concedere licenza volontaria
Un’ulteriore ipotesi di licenza obbligatoria, disciplinata dall’art. 71 c.p.i. ma difficilmente applicabile nella realtà, ricorre quando il titolare di un brevetto rifiuta di concedere una licenza volontaria al titolare di un successivo brevetto dipendente che soddisfi due condizioni: la dipendenza della seconda invenzione dalla prima e la seconda invenzione costituisce un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto alla prima.
Licensing in, out e cross Licensing
Con il termine licensing in si intende l’acquisizione di diritti di proprietà industriale di un brevetto ma anche, più in generale, del know-how di un’impresa.
Il licensing out invece consiste nel concedere a terzi in licenza un proprio diritto di proprietà industriale, al fine di procurare all’impresa un reddito aggiuntivo. Nel cross licensing invece le parti si concedono reciprocamente delle licenze. Questo fenomeno è particolarmente diffuso in quei settori che, per la specificità del prodotto ovvero del mercato, hanno una forte tendenza a ricorrere allo sviluppo in house e contemporaneamente all’acquisizione di tecnologia da altri concorrenti.
La valutazione economica dei brevetti nei contratti di licenza
Tra i vari elementi essenziali oggetto di un contratto di licenza uno dei più determinanti è quello relativo al valore da assegnare ai diritti oggetto della licenza, in particolare per quel che riguarda la determinazione delle royalties che il licenziatario dovrà corrispondere al licenziante.
A questo proposito l’Ufficio italiano marchi e brevetti ha messo a punto un sistema di valutazione denominato “Griglia di valutazione economico-finanziaria” per i brevetti e per i disegni/modelli, volto a misurare l’incremento di valore all’interno dell’azienda derivante dallo sfruttamento di tali diritti. Tuttavia, per riuscire a determinare il valore di un brevetto, sono diversi i metodi utilizzati, ed i più comuni sono:
- Il metodo reddituale, basato sui flussi di reddito previsti che il proprietario del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso;
- Il metodo dei costi, che stabilisce il valore del brevetto calcolando il costo che l’impresa ha sopportato per sviluppare al suo interno il prodotto, oppure il costo a cui dovrebbe fare fronte per acquisire il brevetto esternamente all’azienda;
- Il metodo del mercato basato sul valore di transazioni comparative fatte sul mercato;
- Il metodo sull’opzione, basato sul metodo sviluppato inizialmente per l’attribuzione del valore ad alcuni strumenti derivati su azioni di società quotate nei mercati.
Aspetti internazionali
Nel contesto globale di oggi, la concessione di licenze di proprietà intellettuale non è limitata alle frontiere nazionali. Le imprese e gli innovatori si trovano a navigare in un panorama internazionale complesso, dove le normative e le pratiche variano notevolmente tra le diverse giurisdizioni. Questo capitolo esamina le sfide e le strategie relative alla concessione di licenze a livello internazionale, nonché l’impatto dei principali trattati internazionali sulla proprietà intellettuale.
Concedere licenze oltre i confini nazionali comporta una serie di sfide uniche. Prima fra tutte, la necessità di comprendere e conformarsi alle leggi di proprietà intellettuale in diverse giurisdizioni. Ogni paese ha il proprio insieme di regole e normative relative che possono influenzare significativamente i termini e le condizioni di una licenza. Inoltre, questioni come la tassazione e il trasferimento di denaro attraverso le frontiere possono complicare ulteriormente le operazioni.
Per gestire efficacemente le licenze a livello internazionale, è essenziale condurre un’analisi approfondita delle leggi e delle prassi di proprietà intellettuale in ogni giurisdizione rilevante. Inoltre, le imprese dovrebbero considerare l’adozione di strategie come la negoziazione di clausole contrattuali flessibili. Questo per adattarsi a diverse normative legali e l’impiego di esperti legali locali. Un altro aspetto chiave è la due diligence. Non solo per valutare la validità e la portata dei diritti, ma anche per comprendere il contesto commerciale e legale locale.
Pagamento delle royalties
Le royalties sono un elemento essenziale del contratto. Possono essere calcolate come percentuale sulle vendite o come importo fisso per unità prodotta, oppure attraverso un canone fisso periodico. Alcuni contratti prevedono una combinazione di canone fisso e pagamento variabile. Il contratto deve chiarire le modalità di calcolo e pagamento, nonché eventuali penali per inadempimenti. Una corretta gestione delle royalties assicura un’equa remunerazione per il licenziante e flussi finanziari prevedibili per il licenziatario, tenendo conto delle normative fiscali e delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
Disciplina fiscale
La tassazione rappresenta uno degli aspetti più critici. Le royalties corrisposte in virtù di tali contratti costituiscono reddito imponibile per il licenziante e, a seconda della residenza fiscale delle parti coinvolte, possono essere soggette a diverse forme di imposizione.
In Italia, se il licenziante è un soggetto residente, le royalties sono tassate come reddito d’impresa o da lavoro autonomo, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del TUIR. Se invece il licenziante è un soggetto estero, è prevista una ritenuta alla fonte del 30% sul compenso lordo (art. 25 del TUIR). Tuttavia, la presenza di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni può ridurre o eliminare questa ritenuta, con aliquote variabili tra il 5% e il 10%, previa presentazione del certificato di residenza fiscale da parte del licenziante estero.
Regime del patent box
Il patent box rappresenta un regime fiscale agevolativo completamente ridefinito dall’articolo 6 del D.L. n. 146/2021, che ha sostituito la precedente disciplina con un sistema di super-deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per beni immateriali. Questo regime opzionale, rivolto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che operano come “investitori” nella creazione e sviluppo di proprietà intellettuale, consente di maggiorare i costi sostenuti sia ai fini IRES che IRAP, generando un risparmio fiscale effettivo di circa il 30,69% dei costi sostenuti.
L’agevolazione si applica a beni immateriali quali brevetti industriali, software protetti da copyright, disegni e modelli registrati, ma esclude espressamente marchi di impresa e know-how. Il regime è stato progettato in conformità alle raccomandazioni OCSE per evitare pratiche di concorrenza fiscale dannosa, garantendo l’allineamento tra elementi sostanziali (sostenimento effettivo dei costi di ricerca e sviluppo) e formali (titolarità dei beni immateriali), rappresentando così uno strumento strategico per incentivare gli investimenti in innovazione e il mantenimento della proprietà intellettuale in Italia.
IVA
L’IVA si applica alle operazioni qualificate come prestazioni di servizi. Se entrambe le parti sono residenti in Italia, l’operazione è soggetta all’aliquota ordinaria del 22%. Quando il licenziante è estero, si applica il meccanismo del reverse charge, che comporta l’integrazione della fattura senza IVA e l’autoliquidazione da parte del licenziatario italiano. In caso di transazioni con soggetti residenti in Paesi extra-UE, le operazioni possono essere considerate fuori campo IVA, ma è fondamentale analizzare la residenza fiscale delle parti coinvolte e la normativa locale.
Consulenza online
La concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta un aspetto fondamentale nel moderno panorama commerciale e legale. Attraverso la comprensione approfondita dei vari aspetti che caratterizzano la proprietà intellettuale, le aziende e gli individui possono sfruttare efficacemente il loro potenziale creativo e innovativo. Questo processo non solo stimola la crescita economica, ma promuove anche la diffusione della conoscenza e dell’innovazione.
L’adozione di strategie di licenza ben pianificate, insieme a una solida conoscenza delle normative legali e internazionali, permette ai detentori di diritti di massimizzare i benefici economici derivanti dai loro asset intellettuali. Allo stesso tempo, è essenziale essere consapevoli delle sfide legali, etiche e pratiche che possono emergere nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
Se desideri approfondire questi aspetti sotto il profilo legale e fiscale contattaci per ricevere una consulenza online con legali specializzati e commercialisti. Segui il link sottostante e attraverso il modulo di contatto fornisci tutte le informazioni sulla tua situazione.
Domande frequenti
Una licenza di proprietà intellettuale è un contratto. Attraverso di esso il titolare dei diritti concede a un’altra parte il permesso di utilizzare la sua proprietà intellettuale, secondo termini e condizioni specifici.
Esistono principalmente due tipi di licenze: esclusive e non esclusive. Una licenza esclusiva concede al licenziatario il diritto esclusivo di utilizzare l’asset di proprietà intellettuale. Mentre una licenza non esclusiva permette al licenziante di concedere lo stesso diritto a più parti.
Le royalty vengono generalmente stabilite in base a vari fattori. Ad esempio, il valore di mercato dell’asset di PI, il settore specifico, la durata del contratto, e la portata geografica dell’uso concesso. Possono essere calcolate come una percentuale delle vendite o un importo fisso.
I trattati internazionali, come il TRIPS e la Convenzione di Berna, stabiliscono standard minimi per la protezione della PI. Inoltre, facilitano l’armonizzazione delle leggi di PI a livello globale, rendendo più semplice per le aziende gestire i diritti di PI in diversi paesi.
La “due diligence” si riferisce al processo di verifica e valutazione dei diritti di PI coinvolti in un contratto di licenza. Include l’analisi della validità, della portata e del potenziale di sfruttamento commerciale dei diritti di PI.