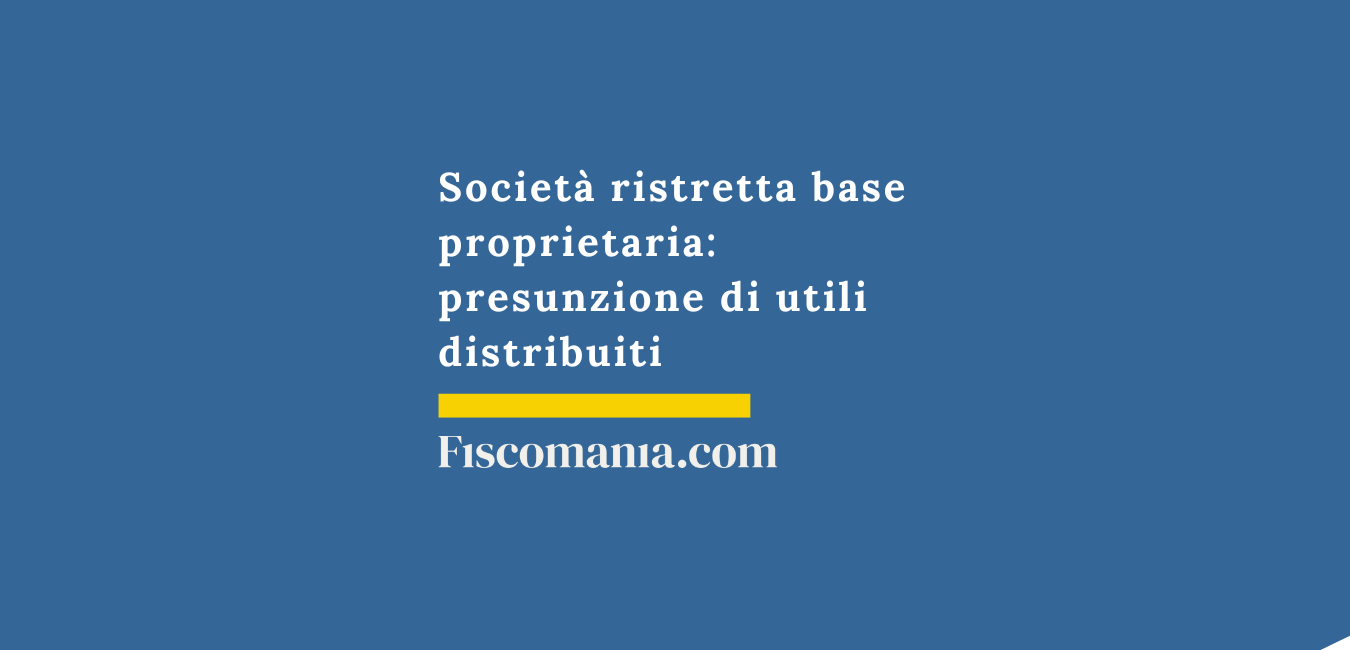Il problema delle società a ristretta base proprietaria negli accertamenti fiscali: Come l’Agenzia delle Entrate può accertare dividendi ai soci quando vengono riscontrati utili non contabilizzati nelle società di capitali con pochi soci.
Una società a ristretta base proprietaria è una società di capitali caratterizzata da una compagine sociale composta da un numero limitato di soci, spesso legati da vincoli familiari, personali o di affinità professionale.
Il nucleo problematico risiede nell’applicazione dell’art. 47, comma 4, del DPR n. 600/1973: quando l’Agenzia delle Entrate accerta alla società maggiori ricavi o minori costi (utili extracontabili), può presumere che questi siano stati automaticamente distribuiti pro quota ai soci.
Questa presunzione (di distribuzione di dividendi) opera indipendentemente dall’effettiva delibera di distribuzione e comporta:
- Doppia imposizione: tassazione in capo alla società + tassazione in capo ai soci come dividendi;
- Applicazione delle ritenute d’acconto sui dividendi presunti;
- Applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi da parte dei soci.
La ratio di questa presunzione risiede nel vincolo di complicità che normalmente caratterizza le società a ristretta base proprietaria, dove i soci hanno un controllo diretto e immediato sulla gestione aziendale. Per questo motivo, la giurisprudenza applica a queste società il principio di trasparenza fiscale, tipico delle società di persone, estendendolo alle società di capitali con compagine sociale ristretta.
Indice degli argomenti
- Cos’è la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
- Il vincolo di complicità
- L’onere della prova
- L’ambito di applicazione: ricavi e costi
- Come funziona l’accertamento sui soci
- Tassazione dei dividendi presunti per i soci persone fisiche
- Strategie di difesa
- Giurisprudenza
- Prospettive future
- Consulenza online accertamento e contenzioso tributario
- Fonti normative e giurisprudenziali
Cos’è la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è una presunzione semplice che consente all’Amministrazione finanziaria di accertare induttivamente in capo ai soci di società di capitali a ristretta base proprietaria la percezione di dividendi “neri” corrispondenti agli utili non contabilizzati accertati in capo alla società.
Per legittimare l’applicazione di questa presunzione, l’Agenzia delle Entrate deve soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 del Codice Civile per le presunzioni semplici.
Di fatto, la mera configurazione di società a ristretta base proprietaria non è sufficiente per giustificare automaticamente l’imputazione pro quota ai soci dei redditi societari occultati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ristretta compagine sociale costituisce solo un indizio iniziale, che deve essere necessariamente supportato da elementi probatori aggiuntivi e convergenti (Cass. 3.2.2025 n. 2464 e Cass. 31.1.2025 n. 2288).
Gli indizi ulteriori richiesti
L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la presenza di circostanze fattuali concrete che rendano ragionevolmente deducibile l’effettiva percezione e distribuzione degli extra-utili, quali:
- Commistione patrimoniale tra società e soci (utilizzo promiscuo di beni, conti correnti, carte di credito);
- Prelievi anomali o movimenti finanziari non giustificati da operazioni documentate;
- Sostenimento di spese personali dei soci a carico della società;
- Coincidenza temporale tra maggiori utili accertati e incrementi patrimoniali dei soci;
- Modalità operative che evidenziano un controllo diretto dei soci sulla gestione finanziaria.
L’effetto che si genera è quello di un meccanismo di doppia imposizione, in quanto il maggior reddito viene prima tassato in capo alla società (IRES) e successivamente ai soci (IRPEF o ritenute).
Solo quando questi elementi si combinino in modo grave, preciso e concordante con la ristretta base societaria, la presunzione acquisisce solidità giuridica, invertendo l’onere della prova sui soci chiamati a dimostrare la non percezione degli utili extracontabili.
Il vincolo di complicità
La giurisprudenza ha individuato nella ristrettezza della compagine sociale il presupposto fondamentale per l’operatività della presunzione, con particolare riferimento ai vincoli familiari tra i soci. Il fondamento risiede nel:
- “vincolo di complicità che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale, specie se appartenenti ad una stessa famiglia“, come chiarito da Cass. 17.10.2005 n. 20078 e Cass. 29.7.2016 n. 15824.
- “normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonchè un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali” (Cass., sez. trib., sent. 20 dicembre 2018, n. 32959).
La casistica giurisprudenziale ha riconosciuto la ristretta base sociale nelle seguenti casistiche:
- Due soci (C.T. Reg. Milano 24.7.2017 n. 3327/1/17);
- Quattro soci (Cass. 17.11.2006 n. 24491);
- Cinque soci senza alcun legame di parentela (Cassazione 3896/2008)
- Sei soci appartenenti a tre nuclei familiari differenti (Cassazione 13399/2003);
- Enti cooperativi (Cass. 11.10.2007 n. 21415);
- Società partecipate da altre società (Cass. 23.10.2019 n. 27049, Cass. 18.7.2023 n. 20840).
La valutazione della ristrettezza non dipende solo dal numero dei soci, ma anche da:
- Vincoli familiari tra i soci;
- Controllo effettivo della gestione sociale;
- Rapporti di collaborazione nella gestione aziendale.
La figura dei “soci tiranni”
Un orientamento particolarmente significativo, espresso da Cass. 3.11.2022 n. 32451, ha stabilito la legittimità dell’imputazione degli utili extracontabili ai soli “soci tiranni“ – anche in presenza di più soci formali – quando questi gestiscono autonomamente le attività sociali.
Società unipersonale e presunzione di distribuzione
Le società unipersonali rappresentano il caso più evidente di ristretta base proprietaria, dove la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili trova la sua applicazione più diretta. In presenza di un unico socio al 100%, viene meno qualsiasi possibilità di dimostrare l’estraneità alla gestione sociale, rendendo particolarmente solida la presunzione dell’Amministrazione finanziaria.
La giurisprudenza ha chiarito che nelle società unipersonali il vincolo di “complicità” tra socio e ente giuridico è massimo, giustificando l’applicazione automatica del principio di trasparenza fiscale. Tuttavia, anche in questi casi rimane possibile la prova contraria attraverso la dimostrazione di specifiche circostanze fattuali che escludano l’effettiva distribuzione degli utili.
Enti dormienti e distribuzione occulta
Le società dormienti o con attività marginale possono rappresentare un terreno fertile per accertamenti di distribuzione occulta, specialmente quando mantengono patrimoni significativi o movimentano somme sproporzionate rispetto all’attività dichiarata. L’assenza di un’attività operativa effettiva fa presumere che qualsiasi movimento finanziario sia riconducibile a operazioni tra soci.
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria può facilmente contestare la sostanza economica dell’ente, presumendo che ogni operazione sia finalizzata al trasferimento di ricchezza ai soci al di fuori del regime ordinario di tassazione dei dividendi.
Liquidazione societaria e distribuzione presunta
Anche nella fase di liquidazione societaria, la presunzione può trovare applicazione quando vengono accertati maggiori valori patrimoniali non dichiarati. Gli utili extracontabili emersi in sede di liquidazione vengono infatti considerati come distribuiti ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione.
La liquidazione non esclude l’applicabilità della presunzione, che anzi può essere rafforzata dalla circostanza che i detentori di quote hanno effettivamente beneficiato dei maggiori valori attraverso le quote di liquidazione ricevute. In questa fase è quindi cruciale una valutazione accurata del patrimonio sociale e una corretta determinazione del saldo di liquidazione.
L’onere della prova
Il verificarsi delle condizioni previste determina la presunzione semplice di distribuzione extracontabile di utili societari. L’effetto è quello di portare sul contribuente l’onere della prova. Di fatto, il socio può teoricamente ribaltare la presunzione dimostrando che gli utili extracontabili accertati:
- Non sono stati distribuiti ai soci ma sono rimasti nella disponibilità societaria;
- Sono stati accantonati in riserve non contabilizzate;
- Sono stati reinvestiti nell’attività aziendale senza transito per il patrimonio personale dei soci.
La complessità della prova contraria
Tuttavia, queste difese si scontrano con ostacoli probatori pressoché insuperabili:
1. Dimostrazione del fatto negativo La prova della non percezione degli utili extracontabili comporta la dimostrazione di un fatto negativo (non aver ricevuto le somme), notoriamente complessa e spesso impossibile da fornire in modo incontrovertibile.
2. Paradosso dell’accantonamento “in nero“ Gli utili extracontabili, derivando per definizione da evasione fiscale, non risultano registrati nella contabilità ufficiale. Pertanto:
- Non possono essere formalmente accantonati a riserva (legale, statutaria o straordinaria);
- L’accantonamento a riserva presuppone utili regolarmente contabilizzati;
- Si crea un paradosso: come documentare l’accantonamento di utili che, per loro natura, non sono documentati?
3. Impossibilità del reinvestimento documentato Analogamente, il reinvestimento aziendale degli utili extracontabili non può essere formalmente dimostrato, poiché:
- Manca la tracciabilità contabile delle somme reinvestite
- Il reinvestimento societario si riferisce normalmente a utili già emergenti dal bilancio
- Gli utili “in nero” non possono generare investimenti documentalmente riconducibili
La sostanziale “prova diabolica“ In definitiva, il socio si trova davanti a una “probatio diabolica“: deve dimostrare la destinazione di somme che, essendo frutto di evasione, non hanno lasciato tracce documentali ufficiali, rendendo la difesa estremamente ardua nella pratica applicativa.
L’ambito di applicazione: ricavi e costi
La presunzione opera classicamente per i ricavi neri accertati in capo al soggetto giuridico, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza (Cass. 19.7.2012 n. 12576; Cass. 11.9.2013 n. 20806; Cass. 10.1.2013 n. 441) oppure per costi oggettivamente inesistenti.
Sul punto la CTR Firenze 9 aprile 2013 n. 54/29/13 ha previsto che se la rettifica si fonda su recupero a tassazione di costi (indeducibili ma effettivamente sostenuti dalla società) o sulla valutazione del magazzino, i maggiori redditi, non essendo stati monetizzati, non possono nemmeno essere stati redistribuiti.
Un orientamento giurisprudenziale significativo, espresso da Cass. 4.4.2022 n. 10680 e Cass. 25.8.2022 n. 25322, ha esteso l’applicazione della presunzione anche ai casi di disconoscimento dei costi per mancanza di inerenza o non deducibilità.
Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito manifesta orientamento contrario (C.G.T. II Trieste 5.1.2023 n. 1/2/23, C.T. Reg. Veneto 13.11.2019 n. 1099/5/19).
La giurisprudenza ha chiarito che non dovrebbero rilevare gli accertamenti di tipo statistico, come quelli derivanti da società di comodo e studi di settore, come sostenuto dalla norma di comportamento AIDC 28.6.2017 n. 198 e confermato da C.T. Reg. Firenze 9.4.2013 n. 54/29/13.
Come funziona l’accertamento sui soci
Quando l’Agenzia delle Entrate applica la presunzione di distribuzione, il procedimento si articola in due accertamenti distinti ma collegati:
Primo accertamento: società
L’Amministrazione finanziaria emette un accertamento nei confronti dell’ente per i maggiori ricavi extracontabili o per il disconoscimento di costi non inerenti. Questo accertamento determina un maggior reddito d’impresa soggetto a tassazione IRES.
Secondo accertamento: soci
Contestualmente o successivamente, viene emesso un accertamento “di riflesso” nei confronti dei soci, presumendo che il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato distribuito pro quota come dividendo “nero“.
Secondo l’art. 42 del DPR n. 600/73, l’accertamento del socio dovrebbe allegare quello della società. Tuttavia, considerato che il detentore di quote può accedere agli atti sociali, la giurisprudenza non ritiene automaticamente annullabile l’atto privo di allegazione (Cass. 17.5.2023 n. 13618).
Per i soci non sussiste automaticamente il raddoppio dei termini anche quando la società sia stata denunciata penalmente, salvo che la denuncia riguardi direttamente il socio.
Calcolo del dividendo imputabile
Un aspetto cruciale riguarda la determinazione dell’importo effettivamente imputabile ai soci. Secondo l’orientamento più corretto (norma di comportamento AIDC 28.6.2017 n. 198), il dividendo imputabile dovrebbe essere calcolato al netto dell’IRES che la compagine sociale è chiamata a pagare sul maggior reddito accertato.
Esempio pratico: Una società riceve un accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati di € 500.000. L’IRES dovuta ammonta a € 120.000 (€ 500.000 x 24%). Il dividendo “nero” da imputare al socio dovrebbe essere di € 380.000 (€ 500.000 – € 120.000), non l’intero importo di € 500.000.
Tuttavia, la giurisprudenza non ha ancora accolto definitivamente questa tesi (Cass. 7.7.2022 n. 21487, Cass. 3.2.2022 n. 3307), creando incertezza applicativa.
Tassazione dei dividendi presunti per i soci persone fisiche
La modalità di tassazione dei dividendi presunti dipende dalla tipologia di partecipazione detenuta dal socio e dal regime fiscale applicabile.
Partecipazioni qualificate con regime transitorio
Per le partecipazioni qualificate (diritti di voto superiori al 20% o partecipazione al capitale superiore al 25%) relative a distribuzioni deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi il regime della concorrenza parziale al reddito.
Le percentuali di concorrenza variano secondo il DM 26.5.2017:
- 40% per alcuni periodi;
- 49,72% per altri periodi;
- 58,14% per il periodo più recente.
Importante: La giurisprudenza ha stabilito che in sede di accertamento la tassazione è sempre integrale, non applicandosi le percentuali ridotte previste per le dichiarazioni volontarie (Cass. 12.7.2024 n. 19272).
Partecipazioni con ritenuta a titolo di imposta
Per i dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 del DPR n. 600/73), l’Agenzia delle Entrate dovrebbe tecnicamente emettere due accertamenti separati in capo all’ente societario:
- Primo accertamento per la sussistenza di utili extracontabili;
- Secondo accertamento per l’omessa applicazione della ritenuta.
In questo caso, teoricamente il detentore di quote non dovrebbe ricevere alcun accertamento diretto, limitandosi il problema a una “rivalsa successiva” da parte dell’ente societario. Tuttavia, la prassi applicativa non è sempre coerente con questa impostazione teorica.
Tassazione per soci società di capitali
Quando la presunzione viene applicata nei confronti di società di capitali partecipate da altre società di capitali, i dividendi concorrono al reddito imponibile dell’ente societario partecipante per il 5% del loro ammontare (art. 89 del TUIR).
Questa disciplina si applica anche agli enti cooperativi a responsabilità limitata, creando un regime fiscale più favorevole rispetto alla tassazione delle persone fisiche.
Strategie di difesa
Guardando alle possibilità di difesa, legate alla dimostrazione probatoria utile a superare questo tipo di presunzione occorre prendere a riferimento gli elementi base per una loro dissimulazione. In particolare, i riferimento vanno a:
- Dimostrazione di una assenza di ristretta base;
- Mancanza di complicità;
- Mancata distribuzione extracontabile degli utili.
L’assenza di ristretta base
Come abbiamo visto la ristretta base non è legata tanto al numero dei soci quanto alla presenza di un vincolo familiare tra di essi. Tale legame sociale qualificato considerato così stretto da permettere di ritenere sussistente una piena comunanza di scopi. Pertanto, nelle imprese familiari, difendersi su questo punto diventa complesso.
Estraneità alla gestione sociale
La presunzione è legata al fatto che la ristretta base sia in grado di provocare reciproco controllo tra i soci, solidarietà e complicità tra di essi. La difesa, per il socio deve essere legata alla dimostrazione dell’assenza di rapporto di complicità, in modo da superare la presunzione. Nella pratica tale dimostrazione non può che passare attraverso la dimostrazione dell’estraneità alla gestione sociale (Cass. n. 17461 del 14/07/2017). Si tratta, in sostanza, di dimostrare che, ancorché vi sia un numero esiguo di soci, il socio ricorrente (che non dovrebbe essere anche amministratore) non ha partecipato direttamente alla gestione della società, per cui non è verosimile che egli abbia percepito i maggiori utili accertati.
Ad esempio, il fatto che il socio lavori abitualmente presso altra azienda è elemento idoneo a vincere la presunzione di attribuzione di utili extra contabili (Cass. n. 26873 del 22/12/2016, vedasi anche CTR Firenze, sezione I, sentenza 724/ 2022).
Altro esempio di estraneità del socio alla gestione sociale della società può essere fornito sulla base di comprovati litigi con il socio che esercita effettivamente il controllo della medesima società (Cass. Civ . 29794/2021).
Mancata distribuzione degli utili
Ulteriore elemento di difesa può essere quello legato al comprovare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest’ultima non li ha distribuiti ma, piuttosto, accantonati o reinvestiti. Come abbiamo avuto modo di evidenziare, questo tipo di prova è la più complessa, in quanto prova in negativo.
Giurisprudenza
Di seguito i riferimenti di giurisprudenza recenti sulla questione.
Cassazione sentenza n. 2752/2024
Con la sentenza n. 2752/2024, la Cassazione ha confermato il principio secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale non si applica il beneficio dell’esenzione parziale degli utili previsto dall’art. 47 del TUIR (limite del 40%) quando si tratta di utili extracontabili conseguiti in evasione d’imposta. Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati dalla società e li aveva imputati per intero al socio di maggioranza (95% e 100% rispettivamente per gli anni 2003 e 2004), senza applicare il limite percentuale del 40%. La Corte ha stabilito che gli utili extracontabili devono essere equiparati a quelli delle società di persone con tassazione “trasparente”, giustificando così la perdita del beneficio dell’esenzione parziale, che si applica solo agli utili regolarmente dichiarati in bilancio. La decisione solleva tuttavia perplessità in merito al principio del divieto di doppia imposizione, poiché comporta la tassazione del medesimo reddito sia in capo alla società che al socio per l’intero ammontare.
Sentenza CGT Campania 3026/5/2025
Un caso emblematico dell’approccio giurisprudenziale più favorevole ai contribuenti è rappresentato dalla sentenza n. 3026/5/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania. In questa vicenda, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una SRL una redditività del 2,76% ritenuta troppo bassa rispetto agli elevati costi del personale (circa 130.000 euro nel 2016), procedendo ad accertamenti nei confronti sia della società che delle socie per presunta distribuzione di dividendi occulti.
La difesa ha tuttavia dimostrato che il basso rendimento apparente della società era giustificato dal fatto che le socie percepivano regolari stipendi come dipendenti presso altre aziende, come documentato dalle certificazioni uniche. I giudici di secondo grado, ribaltando la decisione di primo grado, hanno accolto questa argomentazione, stabilendo che l’esistenza di altri redditi delle socie smentiva l’antieconomicità della gestione aziendale e veniva meno la “gravità e concordanza” delle presunzioni richieste dalla giurisprudenza di Cassazione per legittimare un accertamento analitico-induttivo. La sentenza conferma quindi che una corretta valutazione della situazione reddituale complessiva dei soci può neutralizzare le contestazioni dell’amministrazione finanziaria basate su parametri economici apparentemente anomali.
Ordinanza 2464/2025 Corte di Cassazione
Con l’ordinanza 2464/2025 la Cassazione ha confermato che la presunzione di distribuzione può essere superata anche provando l’estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria avendo egli “ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza aver concretamente svolto alcune delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio” di una società a responsabilità limitata.
Ordinanze 15274 e 16035 Corte di Cassazione
Con le ordinanze 15274 e 16035 del 2025, la Cassazione ha nuovamente affermato che la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati opera anche nel caso in cui la compagine sociale sia composta esclusivamente da altre società, sia di persone sia di capitali; infatti, la ristrettezza dell’assetto societario implicherebbe un reciproco controllo nella gestione sociale da parte dei soci, con conseguente vincolo di solidarietà.
Prospettive future
Con risposta all’interrogazione n. 5-02650 del 24 luglio 2024, la Commissione Finanze della Camera ha affrontato il tema dell’applicabilità immediata delle nuove disposizioni sugli accertamenti alle società a ristretta base partecipativa previste dalla riforma fiscale.
L’art. 17, comma 1, lett. h), n. 4 della Legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede una limitazione della presunzione di distribuzione agli utili extracontabili, ammettendo l’accertamento ai soci solo quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) Accertamento fondato su elementi certi e precisi del maggior reddito della società partecipata b) Rettifica derivante da componenti positivi non dichiarati o componenti negativi inesistenti (escludendo quindi i costi meramente non inerenti).
Nelle recenti ordinanze gemelle (Cass. nn. 12439, 12575 e 12466 del maggio 2024), la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento tradizionale, confermando che:
- La presunzione di distribuzione opera indipendentemente dalle modalità di accertamento;
- La presunzione trova fondamento nella natura partecipativa del rapporto societario;
- Rimane salva la prova contraria dei soci per dimostrare accantonamento o reinvestimento degli utili.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito che:
- Le disposizioni della legge delega non sono immediatamente applicabili;
- La riforma non è stata recepita nel D.Lgs. n. 13/2024;
- L’attuazione avverrà in futuro, secondo la tempistica prevista dalla delega;
- Le nuove regole non si applicano ai giudizi pendenti.
Fino all’emanazione dei decreti attuativi specifici, continua ad applicarsi il regime giurisprudenziale attuale, con la presunzione di distribuzione operante secondo i principi consolidati dalla Cassazione.
Consulenza online accertamento e contenzioso tributario
La gestione delle società a ristretta base proprietaria richiede competenze fiscali specialistiche per prevenire rischi significativi e strutturare difese efficaci in caso di accertamento.
La complessità della materia, che coinvolge aspetti di diritto societario, tributario e processuale, rende indispensabile l’assistenza di professionisti esperti nella gestione di queste problematiche specifiche. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra una strategia difensiva efficace e conseguenze fiscali pesanti per soci e società.
Richiedi una consulenza specializzata per valutare la tua situazione specifica e strutturare le migliori strategie di prevenzione e difesa. L’investimento in consulenza qualificata rappresenta sempre la scelta più conveniente rispetto ai costi di un contenzioso tributario.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Art. 5 TUIR
- Art. 47 e 44 TUIR
- Art. 89 TUIR
- Art. 27 DPR 600/73
- Art. 2729 Codice Civile
- Cass. 3.2.2025 n. 2464 e Cass. 31.1.2025 n. 2288
- Cass. 12.7.2024 n. 19272 e Cass. 30.1.2024 n. 2752
- Cass. 13.9.2024 n. 24621 e n. 24688
- Cass. 19.7.2012 n. 12576 e Cass. 11.9.2013 n. 20806
- Circolare Guardia di Finanza 1/2008 Parte IV cap. II § 6