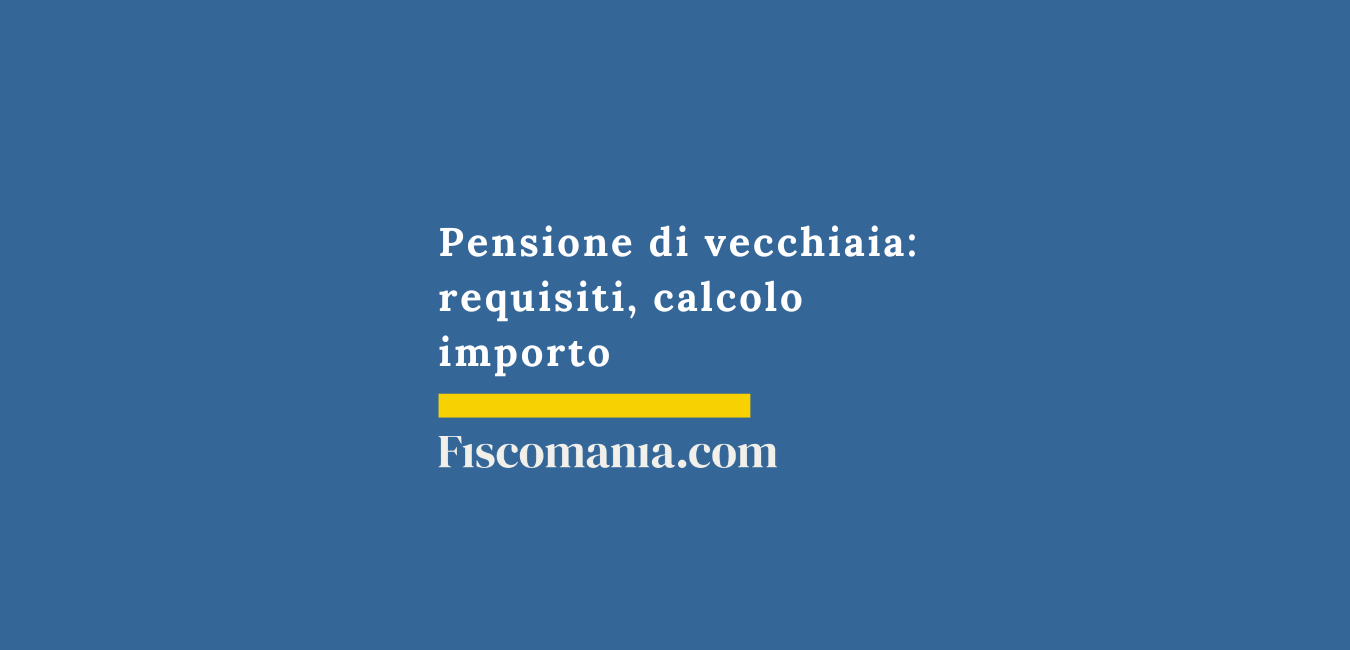La pensione di vecchiaia è la prestazione previdenziale erogata dall’INPS al raggiungimento dell’età pensionabile con un minimo di contribuzione, su domanda dell’interessato. In via ordinaria richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, requisiti confermati fino al 2026.
La pensione di vecchiaia (art. 24 comma 6 del D.L. n. 201/2011) rappresenta il traguardo principale del percorso lavorativo di ogni contribuente. Si tratta di quella prestazione pensionistica erogata dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla gestione separata dell’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.
Naturalmente, oltre a queste prestazione vi sono anche altre alternative di pensionamento da valutare: la pensione anticipata ordinaria (art. 24 comma 10 del D.L. n. 201/2011) alla pensione di anzianità. Ognuna di queste possibilità presenta delle caratteristiche proprie.
Indice degli argomenti
- Requisiti fondamentali per la pensione di vecchiaia
- Il sistema di calcolo della pensione: retributivo, misto e contributivo
- L’importo minimo e le integrazioni al trattamento
- Le deroghe
- La decorrenza
- Quanto spetta
- Come funziona la domanda di pensione semplificata
- Strategie di ottimizzazione fiscale e previdenziale
- Riferimenti normativi
Requisiti fondamentali per la pensione di vecchiaia
I requisiti fondamentali per ottenere la pensione di vecchiaia sono quelli schematizzati nei paragrafi seguenti (art. 24 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011 – conv. Legge n. 214/2011). Occorre il rispetto congiunto degli stessi per ottenere il trattamento pensionistico.
L’età anagrafica
Il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia rimane fissato a 67 anni sia per il 2024 che per il 2025, come confermato dalla Circolare INPS n. 12 del 2024. Questo parametro si applica indistintamente a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, uomini e donne, rappresentando una delle poche certezze in un panorama previdenziale in costante evoluzione.
L’età pensionabile di 67 anni è il risultato dell’ultimo adeguamento all’aspettativa di vita applicato nel 2019. Il prossimo adeguamento è previsto per il 2027, quando potrebbe verificarsi un ulteriore incremento di alcuni mesi. Questa stabilità temporanea offre ai lavoratori una finestra di pianificazione relativamente certa per i prossimi anni.
Il requisito contributivo
Il secondo requisito fondamentale riguarda l’anzianità contributiva minima di 20 anni (1040 settimane) di contributi versati. Questo parametro non ha subito modifiche negli ultimi anni e rappresenta la soglia minima per garantire l’accesso alla prestazione pensionistica ordinaria.
La contribuzione può derivare da diverse fonti: lavoro dipendente, lavoro autonomo, gestione separata INPS, contribuzione volontaria e riscatto di periodi non coperti. La totalizzazione e la ricongiunzione permettono di unificare periodi contributivi versati in gestioni diverse, facilitando il raggiungimento del requisito minimo.
Tabella di riepilogo dei requisiti
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Età del soggetto | 67 anni |
| Annualità contributive | 20 anni |
| Importo dell’assegno minimo | Almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale INPS (*) |
| Cessazione attività lavorativa | A meno che non si operi con modalità part-time |
(*) Se il requisito non viene raggiunto occorre attendere i 71 anni di età, o che l’importo dell’assegno raggiunga la cifra richiesta.
Il sistema di calcolo della pensione: retributivo, misto e contributivo
Il calcolo dell’importo pensionistico dipende strettamente dalla posizione contributiva del lavoratore al 31 dicembre 1995, data spartiacque della riforma Dini. Esistono tre sistemi di calcolo che determinano profonde differenze nell’importo finale della pensione.
Il sistema retributivo puro si applica esclusivamente a chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Questo sistema, ormai residuale, garantisce generalmente importi pensionistici più favorevoli, basandosi sulle retribuzioni degli ultimi anni di carriera.
Il sistema misto interessa la maggioranza dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi. Per questi soggetti, la pensione viene calcolata con il metodo retributivo per l’anzianità maturata fino al 1995 (o fino al 2011 per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 1995) e con il metodo contributivo per i periodi successivi.
Il sistema contributivo puro: la realtà per i giovani lavoratori
Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, si applica integralmente il sistema contributivo. Questo metodo basa il calcolo della pensione sul montante contributivo individuale, ovvero sulla somma rivalutata di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa.
L’aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti è pari al 33% della retribuzione imponibile, mentre per gli autonomi varia tra il 24% e il 25,72% a seconda della gestione previdenziale. Il montante contributivo viene poi trasformato in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione, che variano in base all’età di pensionamento.
I coefficienti di trasformazione per il biennio 2023-2024 (validi anche per le pensioni liquidate nel 2025 con decorrenza 2024) sono stati rivisti al ribasso. A 67 anni, il coefficiente è pari al 5,723%, il che significa che per ogni 100.000 euro di montante contributivo, la pensione annua lorda sarà di 5.723 euro.
L’importo minimo e le integrazioni al trattamento
Un aspetto cruciale per chi rientra nel sistema contributivo puro riguarda l’importo minimo della pensione. Per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi, l’importo mensile deve essere almeno pari all’assegno sociale, che per il 2025 è stimato intorno ai 534,41 euro mensili.
Questa soglia non si applica a chi ha almeno un contributo versato prima del 1996 o a chi raggiunge i 71 anni di età. In quest’ultimo caso, infatti, la pensione viene liquidata indipendentemente dall’importo maturato, purché sussista il requisito contributivo minimo.
Per i pensionati con redditi bassi, il sistema previdenziale prevede diverse forme di integrazione. L’integrazione al trattamento minimo porta la pensione a 598,61 euro mensili per il 2024 (importo soggetto a rivalutazione per il 2025), ma si applica solo alle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto.
Le maggiorazioni sociali possono incrementare ulteriormente l’importo per i pensionati over 60 con redditi particolarmente bassi. Al compimento dei 70 anni, l’incremento al milione (ora pari a circa 735 euro mensili) garantisce un livello minimo di sussistenza a tutti i pensionati in condizioni economiche disagiate.
Le deroghe
L’accesso alla pensione di vecchiaia, anche dopo l’emanazione dell’art. 24 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011, ha mantenuto l’applicazione di alcune deroghe che erano state introdotte dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 503/1992 (vedasi la Circolare INPS 14.3.2012 n. 35; Circolare INPS 1.2.2013 n. 16).
Le deroghe previste per i lavoratori invalidi
La deroga principale ai requisiti previsti è dedicata agli invalidi in misura non inferiore all’80%. Questa categoria di soggetti, infatti, non è assoggettata all’innalzamento dell’età pensionabile prevista per la generalità degli iscritti (art. 1 comma 8 D.Lgs. n. 503/1992).
Si ricorda che le norme dell’epoca prevedevano una età pensionabile di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini, che quindi restano confermati nella fattispecie di cui sopra, ma che tuttavia scontano sia l’aumento della speranza di vita (Cass. n. 31001/2019), sia l’applicazione della finestra. Ne deriva che a partire dall’1.1.2019 possono accedere al trattamento pensionistico solo coloro che raggiungono il requisito contributivo nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti (i lavoratori autonomi e i pubblici dipendenti sono esclusi da tale deroga):
- Le donne invalide almeno all’80% all’età di 56 anni, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi dal requisito sanitario e contributivo, è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- Gli uomini invalidi almeno all’80% all’età di 61 anni, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi dal requisito sanitario e contributivo, e cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le deroghe previste per i lavoratori non vedenti
Anche l’art. 1 comma 7 del D.Lgs. n. 503/92 ha mantenuto una deroga generale per tutti i requisiti, sia anagrafici che contributivi, per i lavoratori non vedenti, applicata con gli stessi criteri di cui sopra. Ne deriva che a partire dall’1.1.2019 possono andare in pensione:
- Le donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 51 anni di età e 10 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Le donne non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 10 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Le donne non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 15 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Le donne non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 15 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Gli uomini non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 56 anni di età e 10 anni di contributi se dipendenti. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Gli uomini non vedenti dalla nascita o da data antecedente l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 10 anni di contributi se autonome. Questo, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi;
- Gli uomini non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 61 anni di età e 15 anni di contributi se dipendenti, con decorrenza del trattamento dopo 12 mesi;
- Gli uomini non vedenti da data successiva l’inizio del rapporto assicurativo con 66 anni di età e 15 anni di contributi se autonomi, con decorrenza del trattamento dopo 18 mesi.
Ulteriori deroghe
L’art. 2 del D.Lgs. n. 503/92 ha invece introdotto diverse deroghe all’aumento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, delle quali ne restano applicabili ormai solo 3:
- La prima riguarda coloro che già erano in possesso dei 15 anni al 31.12.92 e che sulla base del principio del diritto acquisito matureranno comunque il diritto all’età pensionabile. Per poter fruire di questa deroga, è necessario poter far valere una posizione assicurativa e contributiva nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS), sia in qualità di lavoratore dipendente (iscritto al FPLD) che di lavoratore autonomo, oppure nell’ex INPDAP, ex IPOST o ex ENPALS;
- La seconda riguarda coloro che erano autorizzati ai versamenti volontari alla data del 31.12.92 e per i quali saranno sufficienti 15 anni di contributi. Per poter fruire di questa deroga, è necessario poter far valere una posizione assicurativa e contributiva nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS), sia in qualità di lavoratore dipendente (iscritto al FPLD) che di lavoratore autonomo, oppure nell’ex ENPALS. Per i regimi Inpdap e Ipost, l’istituto della contribuzione volontaria è stato introdotto solo a partire dal 12 luglio 1997, pertanto questa seconda eccezione non trova applicazione per gli iscritti a tali gestioni;
- La terza riguarda i lavoratori dipendenti che, assicurati da almeno 25 anni, sono stati occupati per meno di 52 settimane l’anno per almeno 10 anni potranno ancora una volta acquisire il diritto con 15 anni di contributi. Sono destinatari della deroga i soli lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa.
La decorrenza
In merito alla decorrenza della pensione anticipata ordinaria è previsto un periodo di tre mesi di attesa, a partire dalla data di maturazione dei requisiti. Si tratta della c.d. “finestra“. Non è di norma prevista una data entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione. Nella generalità dei casi si applica il principio di “cristallizzazione” dei requisiti. Principio in base al quale, una volta maturati i requisiti per il trattamento pensionistico, l’interessato è libero di richiederlo in qualsiasi momento successivo, anche qualora siano modificate le disposizioni normative in merito.
Resta fermo, comunque, il fatto che, nelle ipotesi in cui la liquidazione della pensione possa avvenire soltanto successivamente alla presentazione della domanda, senza diritto agli arretrati, è opportuna la presentazione tempestiva dell’istanza.
La data di liquidazione della pensione, tuttavia, raramente coincide con la data della decorrenza.
In media le tempistiche intercorrenti tra la presentazione della domanda di pensione ed il primo pagamento dell’assegno corrispondono a circa 180/200 giorni. I giorni di attesa per la liquidazione del trattamento pensionistico si riducono, però, a 50, considerando non la data di presentazione della domanda, ma la data di decorrenza del trattamento stesso.
Altre ipotesi di decorrenza
Nel caso dei dipendenti pubblici iscritti all’AGO, la pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Invece, in caso di periodo di cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Un discorso a parte va fatto per il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), per il quale il trattamento pensionistico decorre dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.
Passiamo ai lavoratori autonomi e dipendenti iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria e alla Gestione Separata. In questo caso, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Quanto spetta
L’Inps ha messo a disposizione degli utenti il servizio PensaMI, ovvero il simulatore che permette di calcolare la propria pensione futura.
Gli importi sono variabili in base ai contributi versati, ma anche al sistema di calcolo in cui si rientra:
- Contributivo;
- Retributivo;
- Misto.
Inoltre, gli importi variano anche in funzione del tipo di attività svolta e del reddito.
Un altro servizio molto interessante e Inps “Pensione futura”, un simulatore di calcolo della pensione al termine dell’attività lavorativa, interamente basato sulla normativa in vigore.
Come funziona? Il simulatore confronta i diversi scenari ed effettua la simulazione della pensione futura. Gli utenti che intendono utilizzare il servizio devono accedere autenticandosi con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.
Come funziona la domanda di pensione semplificata
Al fine di migliorare l’accesso ai servizi online, i lavoratori possono presentare la domanda online semplificata della pensione di vecchiaia ordinaria nel 2024, ma anche per la pensione anticipata ordinaria e per le altre forme di flessibilità in uscita.
Il processo di semplificazione delle domande di pensione si collocata nel progetto del PNRR “Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”. Tra i suoi obiettivi c’è quello di indirizzare gli utenti e orientarli tra le diverse alternative e proposte di pensione.
Si tratta di un servizio molto utile e pratico che consente ai lavoratori di presentare la domanda in pensione se in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio del 2024.
Chi può utilizzare il servizio?
- I lavoratori dipendenti;
- I lavoratori autonomi;
- I liberi professionisti di diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.
Quando si presenta la domanda
Nel 2024, la domanda semplificata per la pensione di vecchiaia, così come quella per la pensione anticipata o flessibile può essere presentata in anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti, ma non più di 3 mesi prima la decorrenza del trattamento.
Quando decorre la pensione? È molto importante tenere presente che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica e del raggiungimento del requisito contributivo.
L’importo spettante della pensione è subordinato comunque alla presentazione della domanda. Quindi, l’importo viene versato dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Non si tratta di una precisazione di poco conto, in quanto è molto importante considerare i tempi di elaborazione della procedura.
Come fare domanda
I lavoratori che hanno maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia devono presentare la domanda all’Inps utilizzando gli appositi servizi online. Le domande devono essere presentate utilizzando i seguenti canali:
- Direttamente sul sito dell’Inps, previo accesso tramite Spid, Cie o Cns. Gli utenti che optano per questa prima modalità devono seguire il percorso: “Pensione e Previdenza”, poi, “Domanda di pensione” e proseguire all’interno dell’area tematica scegliendo il tipo di pensione a cui accedere;
- Utilizzando il servizio di Contact Center, chiamando al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Rivolgendosi ad enti di Patronato o Caf.
Strategie di ottimizzazione fiscale e previdenziale
La scelta del momento ottimale per il pensionamento richiede un’attenta valutazione di molteplici fattori. Posticipare il pensionamento oltre i 67 anni può comportare vantaggi significativi: coefficienti di trasformazione più favorevoli, accumulo di ulteriore montante contributivo e possibilità di migliorare la media retributiva per chi rientra nel sistema misto.
Per ogni anno di posticipo, il coefficiente di trasformazione aumenta mediamente del 4-5%. A 70 anni, ad esempio, il coefficiente sale al 6,655%, garantendo una pensione annua superiore del 16% rispetto al pensionamento a 67 anni, a parità di montante contributivo.
Il riscatto della laurea e dei periodi non coperti
Il riscatto agevolato della laurea rappresenta un’opportunità particolarmente vantaggiosa per i contributivi puri. Con un costo fisso di circa 5.776 euro per anno di corso (importo 2024), permette di aumentare sia l’anzianità contributiva che il montante pensionistico.
Il riscatto ordinario, invece, risulta più oneroso ma può essere conveniente per chi rientra nel sistema retributivo o misto, soprattutto se effettuato negli anni di retribuzione più elevata. La deducibilità fiscale del costo riduce l’onere effettivo del 23-43% a seconda dello scaglione IRPEF di appartenenza.
La contribuzione volontaria e il Cumulo dei Periodi
La prosecuzione volontaria permette di continuare a versare contributi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questa opzione risulta particolarmente strategica per chi è vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici o per migliorare l’importo della futura pensione.
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi consente di sommare gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali. A differenza della ricongiunzione onerosa, il cumulo mantiene le regole di calcolo proprie di ciascuna gestione, risultando spesso più conveniente per i lavoratori con carriere discontinue.
Riferimenti normativi
- Legge n. 335/1995 (Riforma Dini)
- Legge n. 214/2011 (Riforma Fornero)
- Circolare INPS n. 12/2024
- Decreto Ministeriale 1° giugno 2022
- Legge n. 213/2023