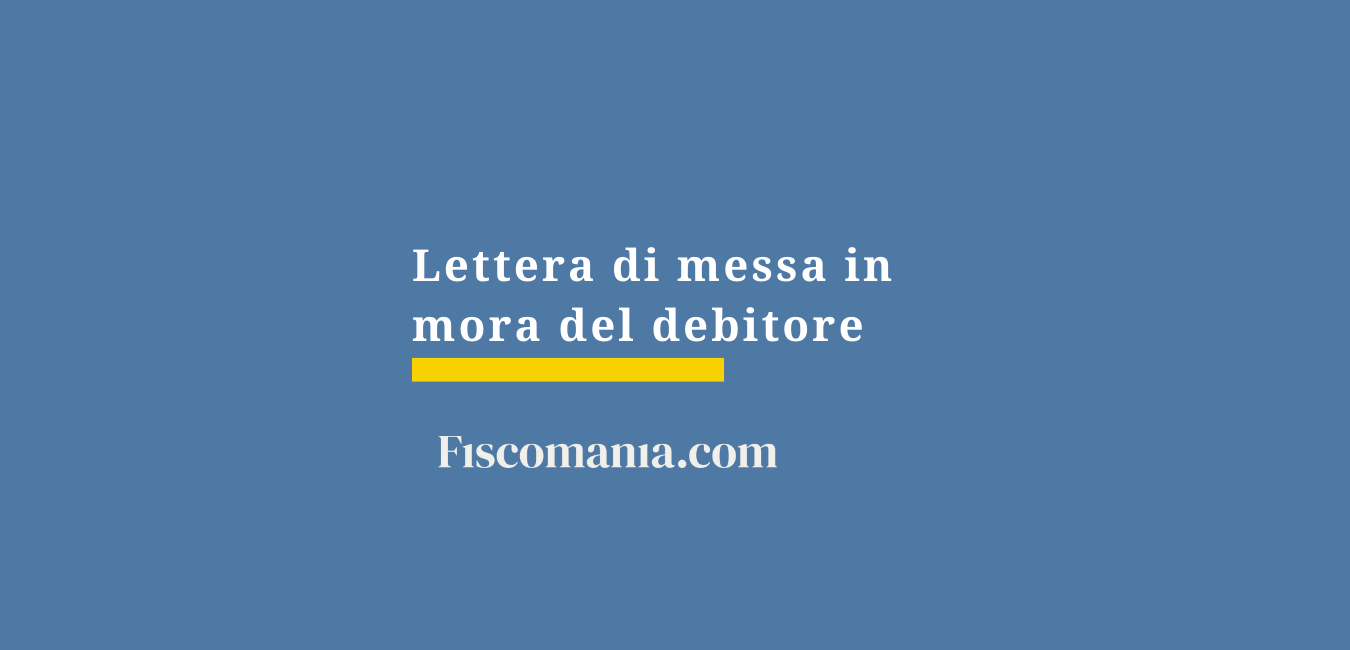La lettera di messa in mora è uno strumento che ha la funzione di garantire il diritto del creditore, ove il debitore sia in ritardo nel pagamento. In alcuni casi, è necessario procedere ad una comunicazione, o lettera di messa in mora o anche diffida ad adempiere. Tuttavia, indipendentemente da queste differenze procedimentali, la normativa disciplina l’ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo.
La lettera in questione ha molti tratti affini ad una diffida ad adempiere. Quest’ultimo è uno strumento di carattere generale e tipico, che può esser fatto valere del creditore, anche in assenza di espressa previsione contrattuale.
La differenza rispetto alla messa in mora sta nel fatto che, mentre in questa, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, il creditore potrà ricorrere alle vie legali per veder tutelati i propri interessi, nella diffida ad adempiere il vano decorso del termine dà la possibilità a chi l’ha inviata di sciogliere il contratto (fatto salvo il risarcimento del danno). Tale volontà deve essere espressamente indicata nella diffida.
Indice degli argomenti
Messa in mora: di cosa si tratta
E’ un istituto giuridico disciplinato dagli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile, attraverso il quale il creditore formalizza l’inadempimento del debitore e ne sollecita l’adempimento. Questo atto rappresenta un presupposto necessario per attivare azioni giudiziali e richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
Attraverso tale documento il creditore vuole garantire il proprio diritto all’adempimento dell’obbligazione assunta dal debitore. Pertanto, questo tipo di comunicazione si rende necessaria ogni qualvolta la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo. Può essere il caso, ad esempio, del sollecito per il mancato pagamento di una fattura.
Questa fattispecie si realizza ogniqualvolta tra la data di scadenza dell’esecuzione della prestazione e il momento in cui l‘inadempimento diventa definitivo, intercorre un lasso di tempo in cui il debitore fa ancora in tempo ad adempiere, sebbene in ritardo.
La costituzione in mora è, dunque, una fattispecie complessa, che presuppone una condotta costituente un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione assunta. Non ogni qualvolta c’è ritardo, tuttavia, c’è mora. Infatti, se quest’ultima presuppone necessariamente il verificarsi del secondo, mentre il secondo non sempre integra la mora de debitore. Il ritardo può essere, altresì, irrilevante oppure può dar luogo ad un inadempimento, ma per rilevare potrebbe sussistere la necessità di rendere qualificato il ritardo. Ma cosa significa ciò?
La disciplina può subire alcune rilevanti modifiche anche in base alla natura del credito stesso, ad esempio laddove si tratti di un credito pecuniario, in genere, la mora è automatica, ossia il soggetto lo è nel momento in cui il credito è liquido ed esigibile. In tal evenienza, non è necessaria una formale lettere di messa in mora.
Dunque, a tal proposito, si parla di mora ex re. Laddove, invece, non sia automatica, è necessario un atto formale di messa in mora, in modo tale da rendere il ritardo qualificato. In altre parole, questa comunicazione è un’intimazione formale del creditore, che produce le conseguenze giuridiche determinate dagli articoli 1221 e 1223 c.c. e interrompe il decorso della prescrizione.
Presupposti applicativi
Nel paragrafo precedente abbiamo espressamente previsto che tra i presupposti vi è sicuramente il ritardo. Tuttavia, questo non è l’unico richiesto affinché sia possibile la messa in mora del debitore. Infatti, è altresì necessario che:
- Esista e sia attuale un rapporto obbligatorio;
- Occorre il ritardo, quindi che vi sia un inadempimento temporaneo e relativo dell’obbligazione;
- Occorre, poi, che il credito sia esigibile.
Non è previsto tra i requisiti che sussista la certezza del credito. Non essendo individuata un’espressa norma che la escluda in caso di credito litigioso, si ritiene che essa sia possibile nonostante non vi sia certezza giuridica del diritto.
Sembra invece necessaria la liquidità del credito, la messa in mora in tal caso potrebbe essere esclusa. In passato era frequente vedere affermato che la costituzione non valeva per i crediti illiquidi, ossia laddove i crediti non siano determinati nel loro ammontare, o non siano di pronta liquidazione. Ciò in quanto, laddove il credito non sia liquido, il soggetto non può procedere ad adempiere alla prestazione.
Invero, sul punto la dottrina sembra aver accolto una tesi differente. Infatti, mancando delle evidenze normative contrarie, sembrerebbe possibile ammettere la messa in mora del debitore anche quando il credito non risulta liquido. In particolare ciò accade quando, l’ammontare della prestazione è deve essere effettuata sulla base di operazioni meramente matematiche del debitore, questo dovrà attendervi e provvedere al pagamento.
Ma anche ove non sia compito del debitore provvedere al calcolo, questo è tenuto a versare la parte di prestazione che è presumibilmente dovuta. Infine, come dicevamo, ultimo requisito ove sia una mora ex persona, è l’intimazione che può avvenire anche mediante comunicazione formale.
Effetti giuridici
La costituzione in mora produce effetti immediati e rilevanti sul piano legale:
- Obbligo di risarcimento dei danni, comprendenti sia il danno emergente (perdite dirette) sia il lucro cessante (mancato guadagno), purché dimostrabili e causalmente collegati all’inadempimento;
- Decorrenza degli interessi moratori sul debito, calcolati secondo i tassi legali o contrattuali;
- Rischio della prestazione a carico del debitore, il quale diviene responsabile anche per la perdita o il deterioramento della cosa oggetto del debito, anche se derivanti da cause non imputabili;
- Interruzione della prescrizione, ossia il blocco del termine entro cui il creditore può esercitare il diritto di azione. Ovviamente, tale previsione riguarda solo i casi di mora ex persona.
In assenza di messa in mora, il creditore non può pretendere il risarcimento per il ritardo, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (es. obbligazioni pecuniarie). L’efficacia dell’istituto risiede dunque nella sua capacità di trasformare un semplice ritardo in un inadempimento giuridicamente rilevante, attivando tutte le tutele previste dall’ordinamento.
Eccezioni e casi particolari
Questo tipo di comunicazione non è richiesta per le obbligazioni derivanti da illecito civile, quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, o quando la prestazione debba eseguirsi al domicilio del creditore (art. 1219 c.c.). In tali ipotesi, il debitore è considerato automaticamente in mora senza necessità di intimazione formale.
Contenuto e forma dell’atto
La lettera di messa in mora del debitore deve essere redatta in forma scritta e contenere elementi essenziali per la sua validità:
- Identificazione chiara del creditore e del debitore;
- Descrizione dettagliata del titolo del credito (es. contratto, fattura) e dell’obbligazione inadempiuta, con chiaro richiamo delle norme di cui agli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile ai fini della formale costituzione in mora;
- Specifica dell’importo dovuto, inclusi eventuali interessi moratori e spese accessorie;
- Termine perentorio per l’adempimento, generalmente non inferiore a sette giorni dalla ricezione della comunicazione;
- Avvertimento esplicito sulle azioni legali che il creditore intraprenderà in caso di mancato pagamento.
La forma prescelta per la notifica deve garantire la prova certa della ricezione: l’invio avviene tipicamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o posta elettronica certificata (PEC). Questa formalità è cruciale per interrompere i termini di prescrizione del credito e per documentare l’inadempimento in eventuali procedimenti giudiziari.
Fac simile lettera di messa in mora
Raccomandata a/r
(Nome, cognome, luogo e data di nascita del mittente)
via ____________n.___
cap______Città_____
Luogo e data di invio
Spett.
(ragione sociale, nome, ditta, indirizzo ecc. del destinatario)
OGGETTO: Messa in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
In nome e per conto di __________, nato a_________, il __________ e residente in ____________ via _____________ n.___,
in riferimento a quanto meglio esposto nel prosieguo.
Premesso che:
In data _______ veniva stipulato il contratto relativo a __________; ad oggi non risulta ancora da Voi adempiuto il contratto con la Vostra prestazione ________ (oggetto della prestazione)
Tutto ciò premesso, con la presente Vi costituisco formalmente in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice Civile ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica. Il decorso inutile di tale termine, mi determinerà ad adire le vie legali per il risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.
Cordialmente.
Firma __________________
Notifica al debitore
La lettera deve inoltre esser notificato al debitore. Come si procede in tal senso? Gli strumenti per recapitare una comunicazione di questo tipo sono tendenzialmente due: la pec e la raccomandata. Tale adempimento è ovviamente necessario affinché produca i suoi effetti.
Sul punto, infatti, è opportuno ricordare che la comunicazione si presenta quale atto recettizio i cui effetti vengono a prodursi solamente nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza (quindi solamente dopo la sua ricezione).
Detto ciò, solitamente l’atto deve essere notificato all’indirizzo di residenza del debitore.Potresti non esser a conoscenza dell’effettivo indirizzo del debitore. A tal proposito ti consigliamo di richiedere un certificato di residenza agli organi competenti.
Laddove il debitore fosse una società, l’atto dovrà essere notificato presso la sua sede legale. In questo caso sarà ancora più semplice acquisire l’indirizzo, nel caso di indisponibilità, potrà essere agilmente acquisita per mezzo di una visura camerale aggiornata.
Soluzioni per evitare la messa in mora
Le soluzioni si articolano su tre livelli: prevenzione attiva, gestione negoziale del debito e strumenti legali di difesa. La strategia ottimale varia a seconda dello stadio della controversia e della collaborazione tra le parti.
Un approccio proattivo richiede un controllo sistematico delle scadenze finanziarie, con registrazione puntuale delle bollette e dei contratti in corso. L’attivazione di domiciliazioni bancarie o pagamenti automatici elimina il rischio di dimenticanze, garantendo l’adempimento nei termini previsti. Parallelamente, una gestione oculata dei consumi (energetici, telefonici, ecc.) previene l’accumulo di debiti imprevisti, soprattutto in contesti con forniture a consumo variabile.
In caso di difficoltà economiche temporanee, è cruciale avviare un dialogo con il creditore prima della scadenza. Molti istituti accettano piani di rateizzazione o accordi di saldo e stralcio, riducendo l’importo dovuto in cambio di un pagamento immediato parziale. La trasparenza sulle proprie capacità contribuisce a costruire relazioni fiduciarie, evitando escalation legali.
Qualora il debito sia contestabile, una risposta formale alla messa in mora – inviata tramite raccomandata A/R o PEC – permette di sollevare eccezioni come la prescrizione del credito o l’inesattezza dell’importo richiesto. In assenza di risposta del creditore, questa documentazione assume valore probatorio in eventuali controversie. Per debiti superiori alle proprie possibilità, la Legge Salva Debiti offre percorsi come il Piano del Consumatore, che consente di rinegoziare gli obblighi e sospendere azioni esecutive già avviate.
Se la comunicazione di mora è già stata notificata, è possibile richiedere una sospensione temporanea presentando prove documentali di difficoltà finanziarie (es. licenziamento, riduzione del reddito). Alcuni creditori concedono moratorie o riduzioni degli interessi in cambio di un piano di rientro verificabile. Nei casi più complessi, l’intervento di un avvocato esperto in diritto esecutivo permette di valutare l’impugnazione dell’atto per vizi formali o il ricorso a procedure concorsuali.
La chiave risiede nella tempestività: il 78% delle controversie si risolve senza procedimenti giudiziali se gestito nelle prime fasi. Ignorare la situazione o ritardare la risposta espone a rischi come decreto ingiuntivo, pignoramenti e iscrizioni in Centrale Rischi, con impatti duraturi sulla reputazione creditizia
Esempi pratici di applicazione
La messa in mora trova applicazione in contesti diversi, sempre legati all’inadempimento di obbligazioni contrattuali o legali. Ecco alcuni esempi pratici tratti dalla casistica giuridica e dalle fonti indicate:
Contratti di servizi o formazione
Un individuo (Tizio) acquista un corso online con pagamento rateale: paga la prima rata ma non la seconda entro i termini. Il creditore invia una lettera di comunicazione di mora tramite PEC, indicando il contratto sottoscritto, l’importo residuo e un termine di 15 giorni per regolarizzare, minacciando azioni legali in caso di inottemperanza.
Effetti: decorrenza degli interessi moratori (art. 1224 c.c.) e rischio di azione giudiziale per decreto ingiuntivo.
Prestiti personali o finanziamenti
Una banca concede un prestito a un cliente, il quale smette di pagare le rate. L’istituto invia una diffida scritta con specifica dell’importo dovuto, inclusi interessi e spese accessorie, concedendo 10 giorni per il saldo.
Effetti: interruzione della prescrizione del credito (art. 2943 c.c.) e possibilità di segnalazione alla Centrale Rischi.
Forniture commerciali non saldate
Un’azienda fornitore consegna merce a un cliente, che non paga la fattura entro 60 giorni. Il fornitore notifica la comunicazione di mora tramite raccomandata A/R, allegando copia della fattura e fissando un termine di 7 giorni.
Effetti: obbligo di risarcire il danno emergente (es. costi di recupero crediti) e lucro cessante (mancato reinvestimento dei fondi).
Locazioni e canoni non corrisposti
Un locatore invia una diffida a un inquilino moroso, richiedendo il pagamento degli arretrati entro 20 giorni. Se l’inquilino non adempie, il locatore può avviare lo sfratto per morosità.
Effetti: sospensione della prescrizione decennale sul credito e possibilità di pignoramento dei beni.
Mora del creditore (caso inverso)
Un costruttore termina un immobile e cerca di consegnarlo al cliente, che rifiuta ingiustificatamente la presa di possesso. Il costruttore invia una comunicazione di mora al creditore (cliente), intimando di ritirare l’immobile entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento.
Effetti: trasferimento del rischio di deterioramento sull’immobile al creditore e diritto al risarcimento per i costi di custodia.
Obbligazioni derivanti da illeciti
In caso di danno da sinistro stradale, la vittima invia una comunicazione all’assicurazione del responsabile, che ritarda il risarcimento. La lettera specifica l’importo richiesto e minaccia un ricorso all’IVASS o un’azione giudiziale.
Effetti: decorrenza automatica degli interessi legali senza necessità di dimostrare il danno specifico (art. 1224 c.c.).
Contratti di lavoro autonomo
Un professionista (es. avvocato) non riceve il compenso pattuito per una consulenza. Invia una richiesta di pagamento con costituzione in mora, allegando il contratto e le email di sollecito precedenti, fissando 10 giorni per il bonifico.
Effetti: possibilità di agire per risarcimento del danno reputazionale e spese legali.