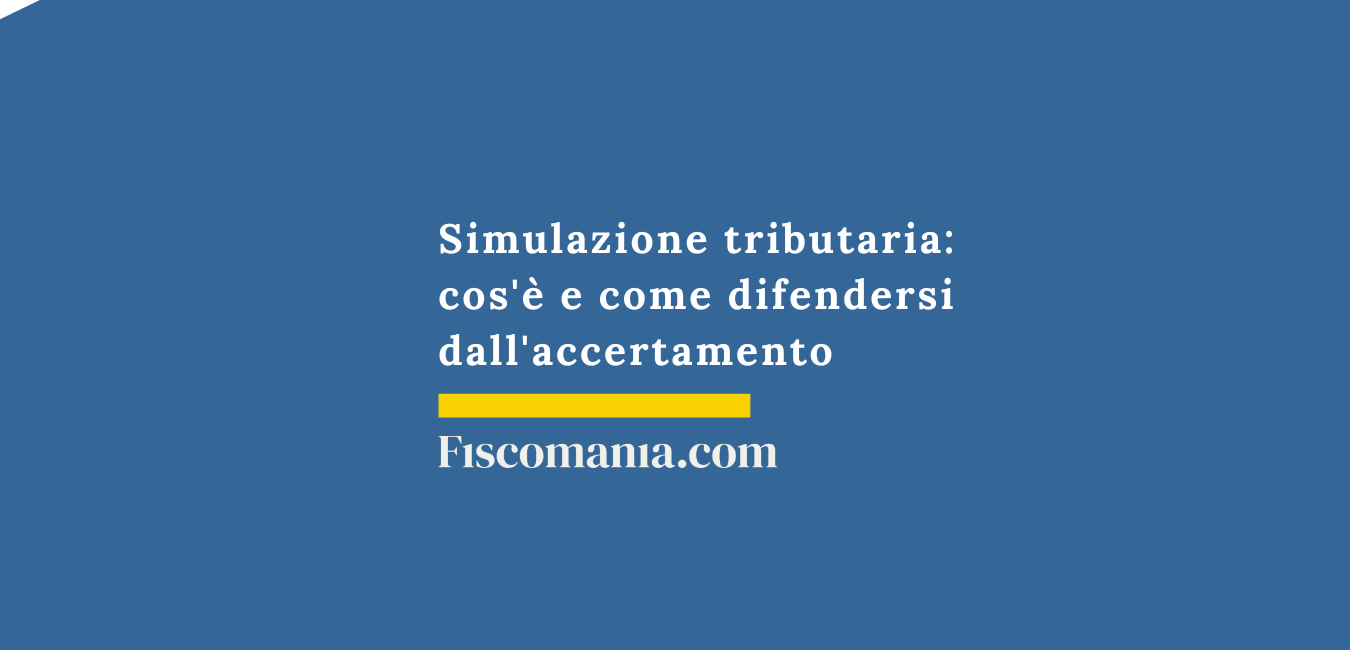È l’azione (o il negozio) posto in essere dalle parti in modo apparente, con l’intesa segreta (accordo simulatorio o controdichiarazione) di non volerne gli effetti (assoluta) o di volerne altri e diversi (relativa), al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale o di celare la reale fattispecie soggetta a imposta.
L’accordo apparente rappresenta uno degli strumenti più complessi e controversi del diritto tributario, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate contesta la finzione di un contratto per far emergere la reale volontà delle parti e applicare la corretta tassazione. A differenza dell’elusione fiscale, che implica operazioni formalmente lecite ma sostanzialmente abusive, questo fenomeno rientra nell’alveo dell’evasione vera e propria, perché presuppone un’intesa segreta volta a creare una finzione giuridica per occultare materia imponibile. Comprendere natura, presupposti e conseguenze di tale meccanismo è fondamentale per professionisti, imprese e contribuenti che affrontano verifiche fiscali basate su contestazioni di operazioni fittizie, fatture false o schemi negoziali apparenti. La divergenza tra volontà dichiarata e volontà reale costituisce il cuore di questo istituto, che colpisce chi utilizza contratti di facciata per ridurre illegalmente il carico tributario.
Un contratto simulato è l’accordo concluso dalle parti per invocarlo di fronte a terzi, con l’intesa segreta che gli effetti giuridici previsti non si devono verificare, creando una divergenza consapevole tra dichiarazione e realtà.
Indice degli argomenti
- Cos’è l’accordo simulatorio in ambito fiscale
- Elementi costitutivi del negozio apparente
- Finzione assoluta e relativa: differenze operative
- Interposizione fittizia
- Onere probatorio e mezzi di prova
- Differenza tra finzione, elusione e abuso del diritto
- Rilevanza penale del negozio fittizio
- Accertamento fiscale delle operazioni fittizie
- Conseguenze fiscali e sanzionatorie
- Finzione del Prezzo negli Atti Immobiliari
- Strumenti di difesa e strategie processuali
- Consulenza fiscale online
- Fonti
Cos’è l’accordo simulatorio in ambito fiscale
L’accordo apparente trova disciplina negli articoli 1414 e seguenti del Codice Civile, che non offrono una definizione espressa ma ne regolano gli effetti, stabilendo che il contratto fittizio non produce conseguenze tra le parti. Nel diritto tributario, questo istituto consente all’Amministrazione finanziaria di superare l’apparenza formale degli atti stipulati dal contribuente per ricostruire la reale fattispecie imponibile. La causa simulandi, ossia il motivo concreto per cui i contraenti creano una mera apparenza, costituisce l’elemento teleologico dell’operazione. Si tratta di una divergenza consapevole e concordata tra dichiarazione e volontà effettiva, che può assumere due forme distinte: assoluta, quando le parti fingono di concludere un negozio che in realtà non vogliono affatto realizzare, oppure relativa, quando nascondono un accordo reale e diverso dietro quello apparente.
L’ipotesi assoluta si verifica tipicamente quando viene simulato il trasferimento di un immobile tra familiari per sottrarlo ai creditori o al pignoramento, senza che vi sia alcun effettivo passaggio della proprietà. La fattispecie relativa può invece riguardare il prezzo dichiarato in un rogito notarile, inferiore a quello realmente pattuito per ridurre imposte di registro e plusvalenze tassabili.
Nel contesto tributario, tale fenomeno costituisce evasione fiscale, non elusione, perché comporta occultamento della base imponibile attraverso dichiarazioni mendaci o contratti fittizi. L’amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti fiscali dell’atto apparente e tassare l’operazione realmente voluta, applicando maggiori imposte, sanzioni e interessi. La Corte di Cassazione ha ripetutamente confermato il potere del Fisco di riqualificare i negozi apparenti senza attendere una sentenza civile.
La causa simulandi, cioè la ragione concreta per cui le parti hanno creato l’apparenza, è l’elemento che il Fisco ricerca durante le verifiche. Documentare sempre valide ragioni economiche per ogni operazione è la migliore difesa preventiva.
Questo significa che il Fisco può ignorare un contratto di affitto e tassarlo come vendita dissimulata, oppure contestare fatture per operazioni inesistenti emesse da società fittizie create allo scopo di dedurre costi mai sostenuti.
Elementi costitutivi del negozio apparente
Secondo la dottrina consolidata, l’accordo fittizio si caratterizza per tre elementi fondamentali:
- Il contratto apparente ufficiale stipulato dalle parti, inidoneo a realizzare gli effetti cui è preordinato;
- L’accordo simulatorio vero e proprio, ossia l’intesa segreta che l’atto non produrrà conseguenze reali;
- Ed eventualmente un contratto dissimulato, cioè l’accordo effettivamente voluto dai contraenti.
La controdichiarazione rappresenta il documento scritto che prova l’intesa segreta, diverso dall’accordo simulatorio stesso che può rimanere anche solo verbale. Questi elementi devono coesistere perché si configuri una fattispecie rilevante ai fini civilistici e tributari. La divergenza tra dichiarazione e volontà deve essere volontaria, consapevole e frutto di un’intesa comune tra tutte le parti coinvolte.
L’elemento soggettivo richiede che tutti i contraenti siano consapevoli dell’apparenza creata e concordi nel non voler produrre gli effetti dichiarati. Non integra finzione negoziale la semplice irregolarità documentale o esecutiva del contratto, se manca l’intento simulatorio comune. La finalità di ingannare i terzi costituisce l’aspetto teleologico: le parti creano l’apparenza per ottenere effetti nei confronti di soggetti esterni, come ridurre il carico fiscale, sottrarre beni ai creditori o aggirare vincoli normativi. La presenza di questa finalità distingue il fenomeno da altri istituti come l’errore negoziale o la riserva mentale unilaterale, che non sono rilevanti ai fini tributari. L’articolo 1414 del Codice Civile stabilisce che, in caso di finzione assoluta, il contratto apparente non produce alcun effetto tra le parti, mentre nella fattispecie relativa può avere efficacia il negozio dissimulato, se sussistono i requisiti di sostanza e forma richiesti dalla legge.
Finzione assoluta e relativa: differenze operative
La finzione assoluta ricorre quando le parti stipulano un negozio apparente escludendone del tutto la rilevanza nei rapporti interni. Un esempio tipico riguarda il finto trasferimento di un bene che in realtà non esce mai dal patrimonio dell’alienante, operazione posta in essere per sottrarlo all’azione esecutiva dei creditori. Sul piano tributario, tale operazione può servire a evitare imposte sulle liberalità oppure a creare costi fittizi deducibili. L’Agenzia delle Entrate, accertata l’assenza di volontà traslativa, disconosce l’atto e applica la tassazione corretta, recuperando le imposte evase con le relative sanzioni amministrative e interessi. La giurisprudenza conferma che l’Amministrazione può contestare tali operazioni anche in assenza di una preventiva pronuncia del giudice civile.
La finzione relativa è più articolata perché presuppone l’esistenza di un contratto dissimulato, realmente voluto ma tenuto nascosto. Si distingue in oggettiva, quando il negozio dissimulato differisce da quello apparente per natura o elementi essenziali, e soggettiva o interposizione fittizia, quando viene mascherata l’identità di una delle parti contrattuali. Nel primo caso, tipico è l’esempio della vendita che nasconde una donazione: le parti stipulano formalmente una compravendita ma in realtà intendono realizzare una liberalità senza corrispettivo. La finzione soggettiva, regolata dall’articolo 37 comma 3 del DPR n. 600/73, ricorre quando il contratto viene intestato a un prestanome diverso dall’effettivo titolare del diritto, spesso per sfruttare regimi fiscali favorevoli o nascondere la vera identità del percipiente del reddito.
Interposizione fittizia
L’interposizione fittizia di persona rappresenta una particolare forma di finzione relativa soggettiva, in cui le parti attribuiscono la qualità di contraente a un soggetto estraneo che si limita a prestare il proprio nome. Tale fattispecie ricorre quando A, B e C si accordano affinché le parti apparenti del contratto siano A e B, mentre in realtà la vera controparte di A è C. Questa ipotesi richiede la partecipazione all’accordo simulatorio di tutti e tre i soggetti coinvolti, costituendo un accordo trilaterale. L’articolo 37, comma 3, del DPR n. 600/73 consente all’Amministrazione finanziaria di imputare i redditi al loro effettivo possessore, anche quando risultano formalmente intestati ad altri, qualora venga dimostrato, anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti, che il vero titolare agisce tramite interposta persona.
La distinzione con l’interposizione reale è fondamentale per evitare confusioni applicative. Quest’ultima si verifica con l’intestazione fiduciaria o con l’acquisto del mandatario per conto del mandante, situazioni in cui l’accordo è bilaterale e l’interposto è l’effettivo destinatario, ancorché non definitivo, del contratto. Non vi è finzione perché l’interposto acquista realmente il diritto, salvo poi doverlo ritrasferire al mandante o fiduciante. L’interposizione fittizia si distingue anche dall’intestazione di beni in nome altrui, come quando il figlio acquista formalmente un immobile ma il prezzo è pagato dal padre: tale operazione configura una donazione indiretta, non un accordo apparente, perché corrisponde alla reale volontà delle parti di attribuire gratuitamente la proprietà al figlio.
Le contestazioni di prestanome riguardano frequentemente società estere prive di struttura operativa, holding familiari utilizzate per schermare redditi personali, o contratti con società riconducibili agli stessi amministratori. In tutti questi casi l’Amministrazione cerca di dimostrare che il soggetto interposto è solo una “scatola vuota” controllata dal contribuente.
Onere probatorio e mezzi di prova
L’articolo 1417 del Codice Civile disciplina i mezzi di prova ammissibili per dimostrare l’accordo apparente. La norma stabilisce che la prova per testimoni è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se proposta dalle parti. Ciò significa che i soggetti esterni possono servirsi liberamente della prova testimoniale e per presunzioni, considerato che la controscrittura è probabilmente nelle mani dei contraenti e quindi inaccessibile. Le parti, invece, a cui il divieto dell’articolo 2722 del Codice Civile vieta la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, possono comunque accedervi per far valere lo specifico vizio dell’illiceità del negozio dissimulato.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria quando contesta operazioni fittizie, assumendo la posizione di terzo rispetto al contratto stipulato. Il Fisco può avvalersi di qualsiasi mezzo probatorio, incluse presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La Corte di Cassazione ha affermato che la dimostrazione deve investire sia elementi oggettivi, come l’assenza di effettiva esecuzione o la mancanza di interesse economico coerente, sia elementi soggettivi, ossia la comune volontà di creare un’apparenza fittizia. Indizi rilevanti sono l’assenza di movimentazioni finanziarie reali, la contestualità temporale di operazioni contrapposte, il collegamento tra le parti, la mancanza di struttura nelle società coinvolte, e contraddizioni tra documentazione formale e comportamenti concreti. Quando le scritture contabili risultano inattendibili, il Fisco può ricostruire i redditi mediante presunzioni, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
Differenza tra finzione, elusione e abuso del diritto
La distinzione tra accordo apparente, elusione fiscale e abuso del diritto è essenziale per comprendere conseguenze giuridiche e sanzionatorie. Il negozio fittizio rientra nell’evasione fiscale perché presuppone un comportamento fraudolento volto a occultare base imponibile attraverso dichiarazioni mendaci o contratti di facciata. Le parti creano consapevolmente un’apparenza difforme dalla realtà con l’intento di sottrarsi all’imposizione. L’evasione integra sia illecito amministrativo tributario sia, nei casi gravi previsti dal Decreto Legislativo n. 74/00, reato penale punibile con reclusione. Al contrario, l’elusione e l’abuso del diritto, disciplinati dall’articolo 10-bis della Legge n. 212/00, riguardano operazioni formalmente lecite e realmente eseguite, ma che utilizzano schemi contrattuali artificiosi al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali indebiti, aggirando la ratio delle norme tributarie.
Nell’elusione non c’è occultamento della realtà fattuale, ma uso distorto di strumenti giuridici leciti. Una riorganizzazione societaria complessa con passaggi intermedi privi di sostanza economica, finalizzata esclusivamente a ridurre il carico fiscale, configura abuso del diritto, non finzione negoziale. Le operazioni sono realmente eseguite e dichiarate, ma la strutturazione è artificiosa. Le conseguenze sanzionatorie sono profondamente diverse: l’elusione comporta solo sanzioni amministrative pecuniarie e recupero delle imposte evase, senza responsabilità penale. Il contratto apparente, essendo evasione, può far scattare sia sanzioni amministrative tributarie più elevate sia responsabilità penale quando superati i limiti di imposta evasa previsti dal diritto penale tributario. Inoltre, per l’abuso del diritto è obbligatorio il contraddittorio preventivo ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/73, mentre per l’accordo fittizio tale garanzia non opera, potendo essere contestato direttamente con avviso di accertamento.
Tabella di riepilogo: contratto apparente vs elusione
| Caratteristica | Contratto apparente | Elusione/Abuso del diritto |
|---|---|---|
| Natura giuridica | Evasione fiscale | Illecito amministrativo tributario |
| Occultamento della realtà | Sì (accordo fittizio) | No (operazioni reali ma artificiose) |
| Responsabilità penale | Possibile (D.Lgs. 74/2000) | Esclusa |
| Contraddittorio preventivo | Non obbligatorio | Obbligatorio (art. 37-bis) |
| Onere della prova | Amministrazione finanziaria | Amministrazione finanziaria |
| Sanzioni | Amministrative elevate + penali | Solo amministrative |
Fonte: artt. 1414 ss. c.c., art. 37 comma 3 e 37-bis DPR 600/1973, art. 10-bis L. 212/2000
Rilevanza penale del negozio fittizio
La Corte di Cassazione, con la sentenza 5929 del 2015, ha chiarito che l’accordo apparente ha piena rilevanza penale tributaria. Nel caso esaminato, i titolari di una società erano indagati per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex articolo 3 del Decreto Legislativo n. 74/00, avendo posto in essere un’operazione complessa che aveva portato all’indicazione nel modello Redditi di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. I giudici hanno affermato che la finzione contrattuale, in quanto evasione e non elusione, integra gli estremi del reato tributario quando l’imposta evasa supera le soglie previste dalla legge penale. Questo orientamento si discosta nettamente dalla disciplina dell’abuso del diritto, che la sentenza 48293 del 2016 della Cassazione ha confermato essere priva di rilevanza penale, proprio perché non comporta occultamento di materia imponibile ma solo sfruttamento artificioso di schemi leciti.
Accertamento fiscale delle operazioni fittizie
L’Agenzia delle Entrate può accertare la finzione di un contratto esercitando i poteri istruttori del DPR n. 600/73 e del DPR n. 633/72, che consentono di acquisire documenti, richiedere chiarimenti, effettuare verifiche fiscali e raccogliere informazioni da banche e terzi. Quando emergono indizi, l’Ufficio emette avviso di accertamento motivato, contestando l’apparenza dell’atto e ricostruendo la reale operazione imponibile, liquidando maggiori imposte, sanzioni e interessi. La contestazione deve indicare elementi di fatto e ragioni giuridiche che fondano la pretesa. Non è necessario attendere una sentenza del giudice civile, poiché la giurisprudenza riconosce al Fisco il potere autonomo di accertare e disconoscere gli effetti fiscali dei negozi apparenti. La Cassazione ha confermato che il giudice tributario ha piena competenza per valutare la finzione in via incidentale, senza necessità di preventivo giudizio civile.
L’Amministrazione deve dimostrare sia elementi oggettivi sia soggettivi dell’accordo simulatorio. Gli elementi oggettivi riguardano l’assenza di reale esecuzione del contratto o la mancanza di struttura operativa delle società coinvolte. Gli elementi soggettivi concernono la volontà comune di creare un’apparenza fittizia. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14804/25, ha ribadito che il giudice tributario ha potere e dovere di accertare se un contratto sia apparente quando tale valutazione risulti necessaria per decidere sulla legittimità dell’accertamento impugnato. Il contribuente può difendersi nel ricorso tributario argomentando regolarità ed effettività dell’operazione contestata. Il giudice valuterà le prove secondo il principio della sostanza economica prevalente sulla forma giuridica, potendo disconoscere contratti puramente formali anche senza una causa civile di accertamento della finzione.
Effetti civilistici verso terzi e creditori
L’articolo 1415 comma 1 del Codice Civile stabilisce che non può essere opposta la finzione ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. Per i terzi vale quindi il negozio apparente in virtù del principio dell’affidamento, avendo questi confidato legittimamente sulla situazione giuridica del simulante. La trascrizione della domanda esclude però la buona fede, perché pubblicizza l’avvenuto accertamento.
Ad esempio, in caso di vendita che nasconde una donazione, gli aventi causa di buona fede del titolare apparente prevalgono rispetto alle parti e ai creditori del simulato alienante, se la trascrizione dell’acquisto precede la trascrizione della domanda giudiziale. I terzi danneggiati dal contratto fittizio possono farne accertare la nullità ai sensi dell’articolo 1415 comma 2 del Codice Civile.
Per i creditori occorre distinguere a seconda che si tratti di creditori del simulato alienante o del simulato acquirente. L’articolo 1416 del Codice Civile stabilisce che i creditori del simulato alienante possono far accertare la finzione che pregiudica i loro diritti e agire sui beni dei quali il debitore si è solo apparentemente spogliato. Per i creditori del simulato acquirente si distingue ulteriormente: i privilegiati non subiscono l’opponibilità della finzione, mentre i chirografari la subiscono, salvo che non abbiano già avviato un procedimento esecutivo sui beni fittiziamente acquistati dal loro debitore. Questa disciplina civilistica ha importanti riflessi tributari, perché l’Amministrazione finanziaria, quale creditore d’imposta, può far valere l’accordo apparente per recuperare le imposte evase aggredendo i beni realmente appartenenti al contribuente, indipendentemente dall’intestazione formale.
Conseguenze fiscali e sanzionatorie
Le conseguenze dell’accertamento di un accordo apparente sono significative sul piano impositivo e sanzionatorio. L’Agenzia delle Entrate disconosce gli effetti fiscali del contratto fittizio e applica la tassazione corretta secondo la reale operazione economica sottostante. Se viene accertata la finzione di un affitto che maschera una vendita, il Fisco recupera l’imposta di registro dovuta per il trasferimento immobiliare, le imposte ipotecarie e catastali, e tassa l’eventuale plusvalenza realizzata dal venditore come reddito soggetto a IRPEF o IRES. Se la finzione riguarda fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione nega la deducibilità dei costi fittizi e recupera l’IVA indebitamente detratta, ricalcolando le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto per tutti gli anni non prescritti.
Sul piano sanzionatorio, essendo evasione fiscale, si applicano le sanzioni amministrative del D.Lgs. n. 471/97. Le penalità variano dal 70% per cento dell’imposta evasa per dichiarazione infedele, fino al 120% per omessa dichiarazione. Quando la finzione integra utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, le sanzioni amministrative sono particolarmente severe e possono andare dal 105% al 140% dell’imposta (co. 4-bis art. 5). Se l’ammontare evaso supera le soglie del D.Lgs. n. 74/00, il contribuente incorre anche in responsabilità penale per reati tributari come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, punito con reclusione da quattro a otto anni. La rilevanza penale distingue nettamente il negozio fittizio dall’elusione fiscale, priva di conseguenze penali.
Tabella di riepilogo delle sanzioni
| Violazione contestata | Sanzione amministrativa | Responsabilità penale |
|---|---|---|
| Dichiarazione infedele | 70% imposta evasa | Sì, se evaso > 100.000€ annui |
| Omessa dichiarazione | 120% imposta evasa | Sì, se evaso > 50.000€ annui |
| Interposizione art. 37 c.3 | 70% imposta maggiore | Sì, se evaso supera soglie |
Fonte: D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 74/2000, art. 37 comma 3 DPR 600/1973
Finzione del Prezzo negli Atti Immobiliari
Una delle forme più diffuse riguarda la dichiarazione di un prezzo inferiore a quello realmente pattuito negli atti di compravendita immobiliare, al fine di ridurre imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, ed eventuali plusvalenze tassabili. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 7246 del 2007, hanno stabilito che nel caso in cui le parti abbiano fissato nell’atto un prezzo diverso da quello effettivo, non è ammessa la prova per testimoni del prezzo dissimulato. La prova non concerne un elemento accessorio ma essenziale del contratto, per cui operano le limitazioni dell’articolo 2722 del Codice Civile. L’articolo 1417 ammette la prova testimoniale solo per far valere l’illiceità del contratto dissimulato, non per modificare elementi essenziali validamente pattuiti.
L’Agenzia delle Entrate scopre tale pratica attraverso verifiche incrociate che confrontano il prezzo dichiarato con i valori di mercato dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare o con le movimentazioni bancarie del compratore. Quando emerge discrepanza significativa, l’Amministrazione può contestare la finzione relativa del prezzo e recuperare le maggiori imposte calcolate sul corrispettivo reale, applicando sanzioni per dichiarazione infedele. La Corte di Cassazione ha recentemente modificato l’orientamento sulla tassazione della sentenza che accerta la finzione del prezzo. Tradizionalmente si riteneva che la pronuncia comportasse un “ritrasferimento” del bene, soggetto a imposta proporzionale di registro. La giurisprudenza più recente ha invece stabilito che la sentenza dichiarativa ha natura meramente accertativa e non dispositiva, producendo effetti retroattivi. Di conseguenza, deve essere assoggettata a imposta fissa di registro, mentre il recupero delle maggiori imposte avviene mediante rettifica dell’atto originario, evitando duplicazione impositiva.
Strumenti di difesa e strategie processuali
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per contestazione di operazioni fittizie dispone di strumenti difensivi in via amministrativa e giurisdizionale. In via amministrativa, può presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 218/97, proponendo all’Ufficio una rideterminazione concordata delle imposte. L’adesione consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale e di definire la controversia senza contenzioso, ma presuppone un riconoscimento almeno parziale della pretesa tributaria. Alternativamente, può presentare istanza di autotutela, chiedendo all’Amministrazione di riesaminare il proprio operato e annullare o ridurre l’accertamento in presenza di errori evidenti. L’autotutela è discrezionale e l’Ufficio non è obbligato ad accoglierla, ma può risultare efficace quando si dimostrano vizi macroscopici.
La difesa giurisdizionale si attua mediante ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria entro sessanta giorni dalla notifica. Nel ricorso il contribuente deve contestare puntualmente i presupposti dell’accertamento, dimostrando che l’operazione contestata come fittizia è stata realmente eseguita secondo le modalità dichiarate. La strategia più efficace consiste nel fornire prove documentali dell’effettività del contratto: estratti conto bancari che attestino i pagamenti, corrispondenza commerciale, documenti di trasporto, testimonianze di terzi, registrazioni contabili coerenti. È fondamentale dimostrare che l’operazione aveva una valida ragione economica e che la struttura adottata rispondeva a esigenze commerciali concrete, non meramente fiscali. Quando la contestazione riguarda l’interposizione fittizia, occorre provare l’autonomia economica, organizzativa e gestionale del soggetto interposto, producendo bilanci, contratti di lavoro, documenti societari.
Giurisprudenza recente e orientamenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 444 del 2025, ha affermato che il giudice tributario può autonomamente riqualificare una contestazione di elusione in evasione per accordo apparente, con la conseguenza che non è censurabile il mancato rispetto del contraddittorio preventivo richiesto dall’articolo 37-bis del DPR n. 600/73. Nel caso esaminato, una società aveva moltiplicato artificiosamente i costi servendosi di società satellite alle quali venivano formalmente assegnate risorse umane che svolgevano prestazioni alle dipendenze della società principale. I giudici hanno ritenuto configurata una finzione piuttosto che un abuso del diritto, perché le società satelliti erano meri schermi privi di autonomia operativa, creati solo per trasferire e maggiorare fittiziamente i costi del personale. Questa pronuncia conferma l’orientamento restrittivo che qualifica come evasione molte operazioni che i contribuenti considerano elusione.
Un altro caso significativo riguarda la tassazione delle plusvalenze da cessione aziendale, oggetto della sentenza 1085 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia. L’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione plusvalenze derivanti dalla cessione di un’azienda preceduta da plurimi contratti di vendita e affitto finalizzati a simulare il trasferimento nella sfera personale dell’imprenditore di un immobile strumentale indispensabile per l’esercizio dell’impresa. I giudici hanno accolto la pretesa del Fisco, affermando che l’Amministrazione aveva fornito prova sufficiente, mediante presunzioni gravi precise e concordanti, sia degli elementi oggettivi sia soggettivi della finzione. L’operazione mirava a far apparire l’immobile come bene personale anziché aziendale, riducendo la base imponibile della plusvalenza da cessione. Questi casi dimostrano come presunzioni adeguatamente motivate possano essere sufficienti per fondare l’accertamento.
Consulenza fiscale online
Affrontare una contestazione di operazioni fittizie richiede competenze tecniche specialistiche sia in diritto civile sia in diritto tributario, unite a profonda conoscenza della giurisprudenza più recente. Ogni caso presenta peculiarità fattuali che richiedono analisi approfondita della documentazione contrattuale, dei flussi finanziari e delle modalità di esecuzione delle operazioni contestate. L’assistenza di un commercialista esperto in contenzioso tributario è fondamentale per valutare la fondatezza della pretesa fiscale, raccogliere le prove necessarie a dimostrare l’effettività dell’operazione e costruire una strategia difensiva efficace sia in sede di accertamento con adesione sia nel giudizio tributario. La tempestività dell’intervento professionale è decisiva, poiché i termini per proporre ricorso sono brevi e la raccolta delle prove documentali deve essere immediata e completa.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento che contesta operazioni fittizie, interposizione fittizia o fatture false, oppure se stai per porre in essere operazioni complesse e vuoi verificare preventivamente i profili di rischio fiscale, posso offrirti una consulenza personalizzata. Durante la consulenza analizzeremo nel dettaglio la tua situazione specifica, valuteremo la documentazione disponibile e ti illustrerò le possibili strategie di difesa o di pianificazione fiscale per gestire correttamente l’operazione. Contattami attraverso il sito fiscomania.com per prenotare una consulenza, durante la quale potrai espormi il tuo caso e ricevere un parere tecnico qualificato su come procedere per tutelare al meglio i tuoi interessi.
Fonti
- Codice Civile, articoli 1414-1417
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37 comma 3
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37-bis
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 471
- Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 444/2025
- Corte di Cassazione, sentenza n. 7246/2007 SS.UU.
- Corte Giustizia Tributaria Sicilia, sentenza n. 1085/2025