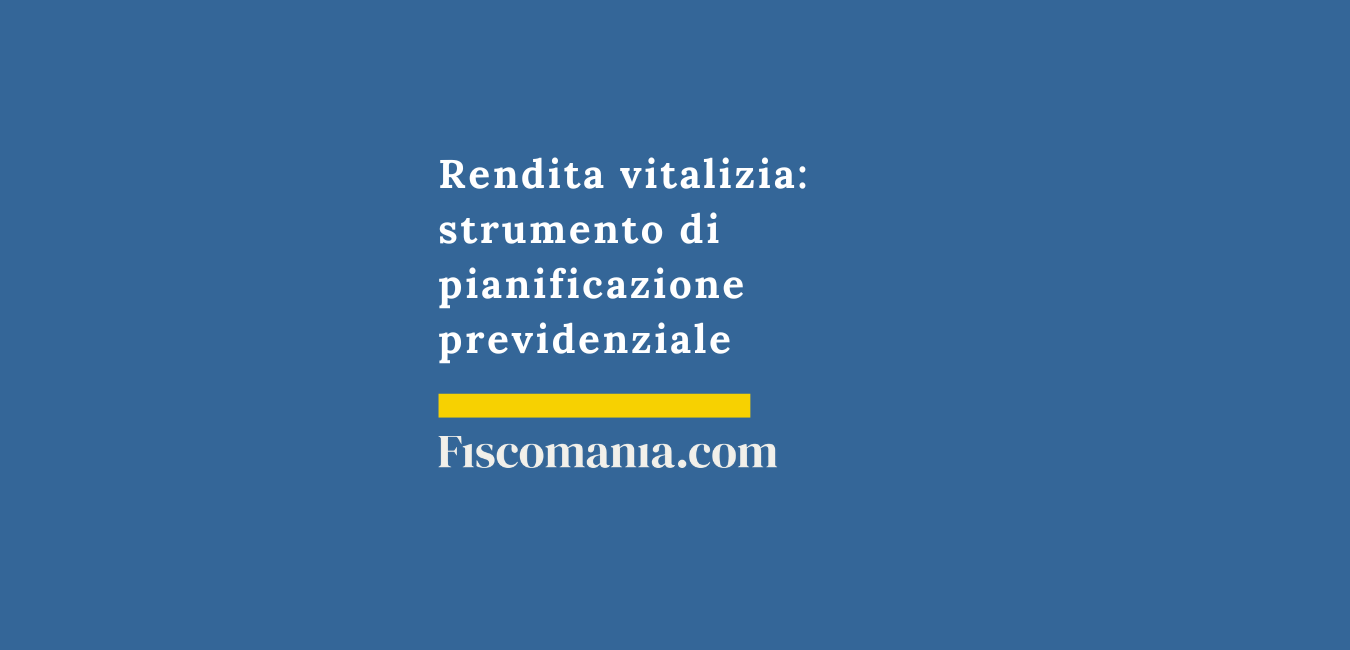La rendita vitalizia è un contratto tramite il quale una parte (l’erogatore della rendita) si impegna a pagare periodicamente una somma di denaro a un beneficiario per tutta la durata della vita del beneficiario stesso. Una soluzione previdenziale che trasforma il capitale in reddito garantito per tutta la vita, offrendo sicurezza economica e protezione dall’inflazione.
La rendita vitalizia rappresenta una delle soluzioni più efficaci per trasformare un capitale accumulato in un flusso di reddito garantito per tutta la vita. In un contesto economico caratterizzato da pensioni pubbliche sempre più ridotte e incertezza sui mercati finanziari, questo strumento contrattuale offre sicurezza e stabilità economica a lungo termine, particolarmente apprezzata da chi si avvicina alla pensione o desidera pianificare la propria successione.
Il contratto di rendita vitalizia consente di convertire patrimoni immobiliari o capitali liquidi in pagamenti periodici certi, eliminando il rischio di esaurimento delle risorse durante la vecchiaia. La sua natura aleatoria lo rende uno strumento unico nel panorama degli investimenti previdenziali, dove il fattore tempo vita del beneficiario determina la convenienza economica dell’operazione.
Indice degli argomenti
Definizione e caratteristiche
La rendita vitalizia è un contratto disciplinato dagli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile, attraverso il quale una parte (il vitaliziante) si obbliga a corrispondere periodicamente una somma di denaro o una quantità di cose fungibili all’altra parte (il vitaliziato) per tutta la durata della vita del beneficiario o di un terzo soggetto.
Il Codice Civile, pur non fornendo una definizione specifica della rendita vitalizia, richiama la definizione di rendita perpetua dell’articolo 1861, adattandola alla durata limitata dalla vita umana. La caratteristica distintiva di questo contratto risiede nella sua natura aleatoria: la durata dell’obbligazione dipende da un evento incerto, ovvero la durata della vita della persona designata.
Le parti coinvolte nel contratto assumono ruoli specifici con diritti e doveri ben definiti. Il vitaliziante è il soggetto onerato del pagamento periodico della rendita, mentre il vitaliziato è colui che conferisce il capitale o il bene immobile e acquisisce il diritto a ricevere le prestazioni periodiche. Entrambe le parti devono possedere la capacità di agire e di disporre, poiché il contratto comporta atti di disposizione che modificano sostanzialmente i patrimoni coinvolti.
Nella pratica potrebbe ragionevolmente accadere che o il capitale (o il valore dell’immobile) non sia integralmente restituiti alla morte, in danno della parte che ha provveduto all’erogazione. Oppure può accadere, a contrario, che chi è chiamato a rendere il vitalizio muoia prima di aver restituito la somma (o il valore).
Forma del contratto
La forma scritta rappresenta un requisito essenziale per la validità del contratto di rendita vitalizia. Il contratto deve essere redatto ad substantiam mediante scrittura privata o atto pubblico. Anche eventuali proposte irrevocabili devono rispettare il requisito della forma scritta.
Se la sua costituzione è preceduta da una proposta irrevocabile di procedere alla stessa anch’essa deve essere redatta in forma scritta e le parti non possono comportarsi diversamente da quanto sottoscritto. Questa è l’opinione di una giurisprudenza consolidatasi nel lontano 1963 con una sentenza della Cassazione, la numero 1004 del 20 aprile.
La giurisprudenza consolidata, a partire dalla sentenza della Cassazione n. 1004 del 1963, ha stabilito che l’assenza della forma scritta comporta l’inesistenza del negozio giuridico, vizio non sanabile neppure attraverso la presenza del contenuto contrattuale in altri documenti.
Garanzie e tutele del vitaliziato
Il vitaliziato gode di specifiche tutele normative per garantire il conseguimento della rendita. L’articolo 1878 del Codice Civile prevede che, in caso di inadempimento del vitaliziante, il creditore non può domandare la risoluzione del contratto, ma può procedere al sequestro e alla vendita dei beni del debitore per costituire un capitale sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Questa disposizione derogatoria rispetto alle regole generali sull’inadempimento si giustifica con la considerazione che la risoluzione potrebbe risultare più dannosa che vantaggiosa per il vitaliziato che dipende esclusivamente dalla rendita per il proprio sostentamento.
Il vitaliziato può inoltre avvalersi di ulteriori strumenti di tutela: eccezione di inadempimento ex articolo 1460, sospensione dell’esecuzione per mutate condizioni patrimoniali del debitore ex articolo 1461, risoluzione per mancanza o diminuzione delle garanzie pattuite ex articolo 1877, e inserimento nel passivo fallimentare per il valore della rendita ex articolo 60 della Legge Fallimentare.
Modalità di costituzione
L’articolo 1872 del Codice Civile stabilisce le modalità attraverso cui può essere costituita una rendita vitalizia, distinguendo tra costituzione a titolo oneroso e a titolo gratuito.
Costituzione a titolo oneroso
La forma più comune prevede la costituzione mediante contratto a titolo oneroso, dove il vitaliziato aliena un bene mobile o immobile oppure cede un capitale in cambio dell’impegno del vitaliziante a corrispondere la rendita periodica. Questa modalità assume carattere consensuale e presenta natura di contratto aleatorio, dove entrambe le parti si assumono il rischio economico legato alla durata della vita contemplata.
Il rischio aleatorio rappresenta l’elemento essenziale del contratto: il vitaliziante assume il rischio che il rapporto possa risultare economicamente svantaggioso se il vitaliziato dovesse vivere più a lungo del previsto, mentre quest’ultimo rischia di non recuperare interamente il valore del capitale ceduto in caso di morte prematura.
Costituzione a titolo gratuito
La rendita può essere costituita per donazione o testamento, assumendo carattere di liberalità. Nel caso di costituzione testamentaria, si realizza attraverso un legato di rendita vitalizia, disciplinato dall’articolo 670 del Codice Civile. Il diritto alla prestazione decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquisisce diritto all’intera prestazione del periodo in corso anche se si trova in vita solo all’inizio dello stesso.
Una forma particolare è rappresentata dal legato di alimenti, regolato dall’articolo 660 del Codice Civile, dove la rendita consiste nella corresponsione degli alimenti necessari al vitaliziato, commisurati alle sue necessità e alla sua posizione sociale.
L’alea come elemento caratterizzante
L’alea costituisce l’elemento fondamentale che caratterizza la causa e l’oggetto del contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso. Questo elemento di incertezza si manifesta sotto due profili distinti ma interconnessi.
Dal punto di vista della causa contrattuale, l’alea rende incerta la condizione economica finale di entrambe le parti contraenti. Il vantaggio o lo svantaggio economico dipendono esclusivamente dalla durata effettiva della vita del soggetto contemplato, creando una situazione di equilibrio nell’assunzione del rischio.
Riguardo all’oggetto del contratto, mentre il vitaliziato effettua una prestazione certa e determinabile (cessione di bene o capitale), il vitaliziante assume un’obbligazione di entità complessiva incerta, dipendente dalla durata della vita del beneficiario.
La Cassazione, con sentenza n. 19763 del 2005, ha chiarito i criteri per verificare l’esistenza dell’alea, stabilendo la necessità di accertare l’equivalenza del rischio. Al momento della conclusione del contratto, entrambe le parti devono godere di una ragionevole probabilità di guadagno o perdita, considerando l’entità della rendita, la sua durata prevedibile e le probabilità di sopravvivenza del beneficiario.
L’assenza dell’alea comporta la nullità del contratto. Questa situazione si verifica quando, al momento della stipula, risulta già prevedibile la durata di vita del vitaliziato per ragioni di età avanzata o gravi condizioni di salute, rendendo calcolabili i guadagni e le perdite delle parti.
Soggetti del contratto: vitaliziante e vitaliziato
La struttura soggettiva del contratto di rendita vitalizia può presentare diverse configurazioni, adattandosi alle esigenze specifiche delle parti coinvolte.
Il vitaliziante
Il vitaliziante assume l’obbligazione di corrispondere la prestazione periodica e può essere costituito da uno o più soggetti. Nel caso di pluralità di debitori, l’obbligazione si ripartisce per quote, escludendo la solidarietà tra i soggetti passivi. In mancanza di specifica determinazione delle quote, queste si presumono uguali.
La sostituzione del vitaliziante può avvenire in due circostanze: attraverso novazione soggettiva per atti tra vivi, oppure per successione ereditaria quando il vitaliziante muore prima del vitaliziato. In quest’ultimo caso, gli eredi subentrano nell’obbligazione pagando per quote ereditarie.
Il vitaliziato
Il vitaliziato può essere parte contrattuale o terzo beneficiario, a seconda che si tratti di rendita onerosa ex articolo 1872 o di rendita a favore di terzi ex articolo 1875 del Codice Civile. Il suo credito è liberamente cedibile secondo le regole generali sulla cessione del credito.
In caso di morte del vitaliziato, gli eredi possono subentrare nel credito solo se l’alea era commisurata alla vita di soggetto diverso dal vitaliziato stesso, mantenendo così la natura aleatoria del contratto.
Il diritto di credito può essere anche ceduto, nelle forme della cessione del credito. Esso è anche trasmissibile agli eredi, infatti se muore subentrano nel suo credito gli eredi. Ovviamente, ciò si realizza solo ove l’alea della rendita era misurata alla durata della vita di un soggetto diverso. La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile dalle parti ai sensi dell’articolo 1881 del codice civile.
Tipologie di rendita
Il panorama delle rendite vitalizie presenta diverse configurazioni che rispondono a specifiche esigenze di pianificazione patrimoniale e previdenziale. Questo tipo di contratto è, in genere, utilizzato nel settore assicurativo. Ad esempio per il riscatto delle polizze vita, oppure finanziario, soprattutto quando si partecipa ai fondi d’investimento. In questi casi, spesso, è possibile scegliere se ottenere l’intero importo a scadenza oppure se optare per una rendita fissa.
Esistono vari tipi di rendita vitalizia, ognuno dei quali propone delle caratteristiche particolari, dei vantaggi e alcuni svantaggi.
Rendita semplice
La rendita vitalizia semplice prevede l’erogazione della prestazione fino alla morte del beneficiario, senza alcuna reversibilità. Rappresenta la forma più elementare e offre generalmente importi più elevati, poiché il rischio per l’erogatore è maggiore per l’assenza di beneficiari successivi.
Rendita reversibile
La rendita vitalizia reversibile garantisce il trasferimento del diritto alla rendita a un secondo beneficiario (generalmente il coniuge) dopo la morte del primo. La reversibilità può essere totale o parziale, riducendo proporzionalmente l’importo della rendita originaria in funzione del rischio aggiuntivo assunto dall’erogatore.
Il destinatario del beneficio, detto reversibilità, deve essere indicato nel contratto. Naturalmente la reversibilità della rendita non è quasi mai il 100% della somma, ma viene determinata una quota in base al grado di parentela. Di solito il coniuge prende l’80 o il 90%, i figli il 50 o il 60% e così via, a seconda di quanto previsto dal contratto tra le parti.
Rendita per vita contemplata
Il contratto può essere costituito non solo sulla vita del vitaliziato, ma anche su quella di un terzo soggetto (vita contemplata). Questa configurazione permette maggiore flessibilità nella strutturazione dell’operazione, consentendo di adattare la durata del contratto a specifiche esigenze familiari o successorie.
Forme alternative di costituzione
Oltre al contratto e al testamento, la rendita vitalizia può originarsi da diverse fonti negoziali: contratto a favore di terzi (articolo 1875), donazione (articolo 1872), contratto di assicurazione (articolo 1882), contratto di divisione (articoli 713 e seguenti), promessa al pubblico (articolo 1989), e titolo giudiziale (articolo 2057).
Vitalizi impropri
Vi sono poi particolari tipologie di rendite vitalizie, dette vitalizi impropri. Questi rappresentano una categoria comprensiva di una variegata fenomenologia pattizia accomunata dalla erogazione di prestazioni variamente combinate di dare e facere infungibile a favore del vitaliziato. Si differenzia dalla rendita vitalizia tipica, che è incentrata sul dare beni fungibili.
Appartengono a questa categoria: vitalizio alimentare, vitalizio di mantenimento e vitalizio assistenziale. Tali fattispecie hanno progressivamente assunto autonoma fisionomia a partire dal generale patto di vitalizio tipico, portando con sé una singolare rivisitazione della primigenia funzione previdenziale dell’istituto.
I vitalizi impropri condividono una struttura affine a quella della rendita vitalizia, in quanto si trattano comunque di vincoli poggianti su di un‘unica prestazione iniziale contro una serie di prestazioni lungo tutta la vita contemplata. Nondimeno, ciascuno dei tipi contrattuali rassegnati obbedisce a una propria vocazione.
Vitalizio alimentare
Come affermato nei paragrafi precedenti, una delle fattispecie di rendita vitalizia, è il vitalizio alimentare. Questo comporta l’obbligo in capo al vitaliziante di provvedere agli alimenti del vitalizianto. Il contratto fa sorgere l’obbligo di provvedere agli alimenti del vitaliziato garantendogli vitto, vestiario, alloggio, cure sanitarie.
Secondo la dottrina, si distingue dalla rendita vitalizia, dalla circostanza che la prestazione è intuitus personae. Essa quindi deve essere necessariamente prestata da un determinato soggetto. Non è quindi indifferente per il vitaliziato l’identità di chi somministra le prestazioni. Si nota come le medesime prestazioni alimentari siano connotate in termini di facere continuativo, che può aggiungersi o meno ad una condotta di dare.
Sono dei contratti anch’essi aleatori. In questo caso, il rischio coinvolge non solo la durata dell’obbligo vitalizio, a seconda della longevità del vitaliziato, ma anche la consistenza di quanto dovuto. Infatti, questi mutano a seconda delle specifiche esigenze del vitaliziato.
Vitalizio di mantenimento
Il vitalizio di mantenimento è un’ulteriore categoria di rendita vitalizia. Come la precedente fattispecie, si connota per imporre in capo al vitaliziante sia obblighi di facere che di dare. Quindi anche in questo caso sono rese delle prestazioni volte a provvedere all’esigenza di vita del soggetto beneficiario.
Si distingue dalla precedente tipologia di vitalizio improprio, in quanto non è determinato sulla base dei bisogni di vita e le esigenze del soggetto beneficiario. Il vitalizio di mantenimento vincola il vitaliziante sulla base dello standard del tenore di vita, mantenuto, in genere, in costanza del matrimonio.
Vitalizio assistenziale
Una terza tipologia di vitalizio improprio, quindi di rendita vitalizia, è il vitalizio assistenziale. Questo, oltre a profili discretivi inerenti alla prestazione di un facere e alla infungibilità, già presentati dal vitalizio alimentare e da quello di mantenimento, si connota proprio per lo speciale impegno in termini di aiuto, cura e supporto materiale e morale, che il vitaliziante assume verso il beneficiario
Vantaggi e rischi
La rendita vitalizia presenta caratteristiche che la rendono particolarmente adatta a specifiche situazioni patrimoniali e previdenziali, pur comportando alcuni rischi che devono essere attentamente valutati.
Vantaggi principali
La sicurezza del reddito a vita rappresenta il vantaggio fondamentale, eliminando il rischio di esaurimento delle risorse durante la vecchiaia. Questo aspetto risulta particolarmente importante in un contesto di allungamento dell’aspettativa di vita e riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche.
La protezione dall’inflazione può essere garantita attraverso rendite indicizzate, mantenendo il potere d’acquisto nel lungo periodo. La flessibilità strutturale consente di adattare il contratto alle specifiche esigenze familiari attraverso clausole di reversibilità o periodi certi.
Dal punto di vista della pianificazione successoria, la rendita vitalizia offre strumenti per garantire il sostentamento del coniuge superstite o di altri familiari, integrando la strategia testamentaria complessiva.
Rischi e limitazioni
Il principale rischio consiste nella perdita di liquidità del capitale, che viene trasformato in flusso di reddito non più disponibile per necessità impreviste. In caso di morte prematura del vitaliziato, il capitale versato potrebbe non essere recuperato integralmente, salvo specifiche clausole contrattuali.
L’erosione inflazionistica può ridurre significativamente il valore reale della rendita nel lungo periodo, particolarmente nelle rendite non indicizzate. I costi di gestione possono inoltre incidere sul rendimento effettivo dell’operazione.
Aspetti fiscali
Il trattamento fiscale della rendita vitalizia varia in funzione della sua natura e modalità di costituzione, presentando generalmente aspetti favorevoli rispetto ad altre forme di investimento.
Per le rendite costituite attraverso contratti assicurativi, i rendimenti sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% sui proventi del capitale investito. Le rendite erogate sono tassate solo per la parte eccedente il capitale versato, determinata secondo coefficienti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate in funzione dell’età del beneficiario.
Le rendite costituite a titolo oneroso tra privati seguono il regime fiscale ordinario, con tassazione della componente di rendimento secondo le aliquote IRPEF. Le rendite a titolo gratuito sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le franchigie e aliquote vigenti.
La deducibilità fiscale dei premi versati per la costituzione di rendite vitalizie previdenziali è prevista entro i limiti stabiliti per i fondi pensione (previdenza complementare), rendendo questo strumento particolarmente attraente per la pianificazione fiscale a lungo termine.
Calcolo e valutazione
La determinazione dell’importo della rendita vitalizia richiede l’applicazione di criteri attuariali che considerano l’aspettativa di vita del beneficiario, i tassi di interesse e i costi di gestione.
L’aspettativa di vita media in Italia si attesta attualmente su 80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne, con una media di 83 anni. Questi dati ISTAT costituiscono la base per il calcolo attuariale della rendita.
Per valutare la convenienza dell’operazione, si deve confrontare il capitale versato con il valore attuale dei pagamenti futuri attesi. Un capitale di 100.000 euro convertito in rendita a 65 anni può generare una rendita annua di circa 5.000 euro, basata su un’aspettativa di vita residua di 20 anni.
I fattori di conversione tengono conto del rischio di longevità, dei tassi di interesse tecnici e dei margini dell’erogatore. Rendite indicizzate all’inflazione comportano importi iniziali inferiori ma offrono maggiore protezione del potere d’acquisto nel tempo.
Fonti
- Codice Civile, artt. 1872-1881
- Codice Civile, art. 1861
- Codice Civile, artt. 660, 670
- Cass. Civ. Sez. II, n. 19763/2005
- Cass. Civ. Sez. II, n. 1004/1963
- Trib. Firenze, 1994
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E/2015