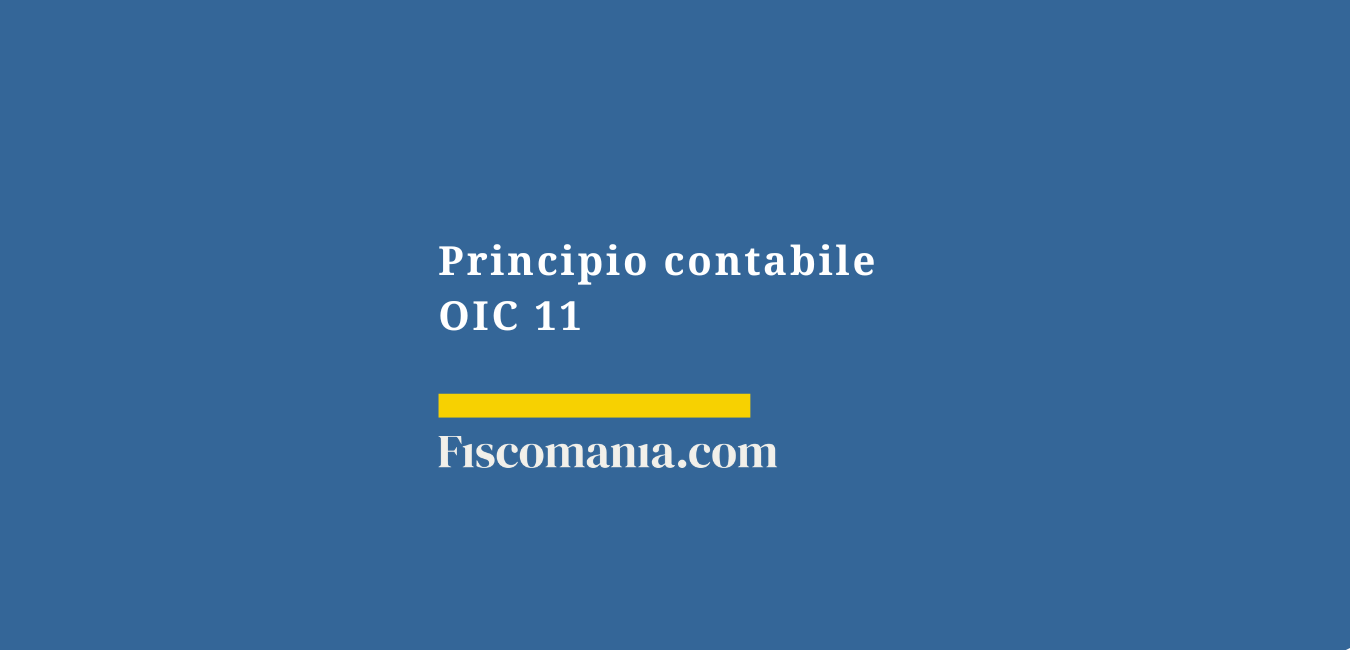Il principio contabile nazionale OIC 11 interpreta ed integra le norme del codice civile contenute nell’art. 2423-bis in materia di principi di redazione del bilancio, elencando e dettagliando i diversi postulati che rappresentano le basi normative di riferimento da cui partire affinché il bilancio sia redatto con chiarezza e sia in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziare della società e il risultato economico d’esercizio (art. 2423 c.c.).
Prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità. Sono questi i postulati oggetto del principio contabile che i redattori del bilancio sono tenuti a rispettare al fine di soddisfare in modo adeguato e non ambiguo le esigenze informative dei vari stakeholder.
Postulati che rispecchiano la tradizionale cultura contabile italiana, basata sui principi di civil law e finalizzati alla determinazione del valore contabile delle imprese al fine di garantire la tutela dei creditori, contrariamente ai principi contabili internazionali IAS/EFRS che invece tendono a garantire l’esposizione in bilancio del valore economico (valore corrente) al fine di tutelare gli investitori sia attuali che potenziali.
Postulati del bilancio
Il documento OIC 11 rappresenta il Framework dei principi contabili nazionali, vale a dire il documento che delinea le linee guida e i comportamenti contabili da utilizzare nella redazione del bilancio. Dopo aver specificato il ruolo interpretativo ed integrativo dei principi contabili rispetto alle norme del codice civile in materia di bilancio (artt. 2423 e ss. c.c.), nonché il ruolo ricoperto dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e la preminente funzione informativa del documento di bilancio nel soddisfare le attese di conoscenza sulla gestione aziendale di tutti i soggetti, sia interni che esterni, l’OIC si sofferma ad analizzare sette postulati del bilancio, alcuni dei quali rappresentano una mera duplicazione di quanto già in merito è previsto dagli articoli del codice civile. I postulati richiamati nel documento di prassi sono i seguenti:
A. Prudenza;
B. Prospettiva della continuità aziendale;
C. Rappresentazione sostanziale;
D. Competenza;
E. Costanza nei criteri di valutazione;
F. Rilevanza;
G. Comparabilità
A) PRUDENZA
Il postulato della prudenza, ispirato alla cultura ragionieristica continentale, mira a garantire primariamente, soprattutto mediante il principio valutativo del costo storico e la contabilizzazione delle perdite prospettiche ancorché non ancora realizzate, la tutela dei creditori.
Contrariamente a quanto accade nei Paesi anglosassoni, dove l’attenzione nella stesura del bilancio viene posta a tutela degli investitori e dove quindi i principi contabili devono essere in grado di evidenziare il valore economico (corrente) dell’impresa e la sua capacità di produrre prospetticamente reddito, nel nostro Paese, ritenut...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso