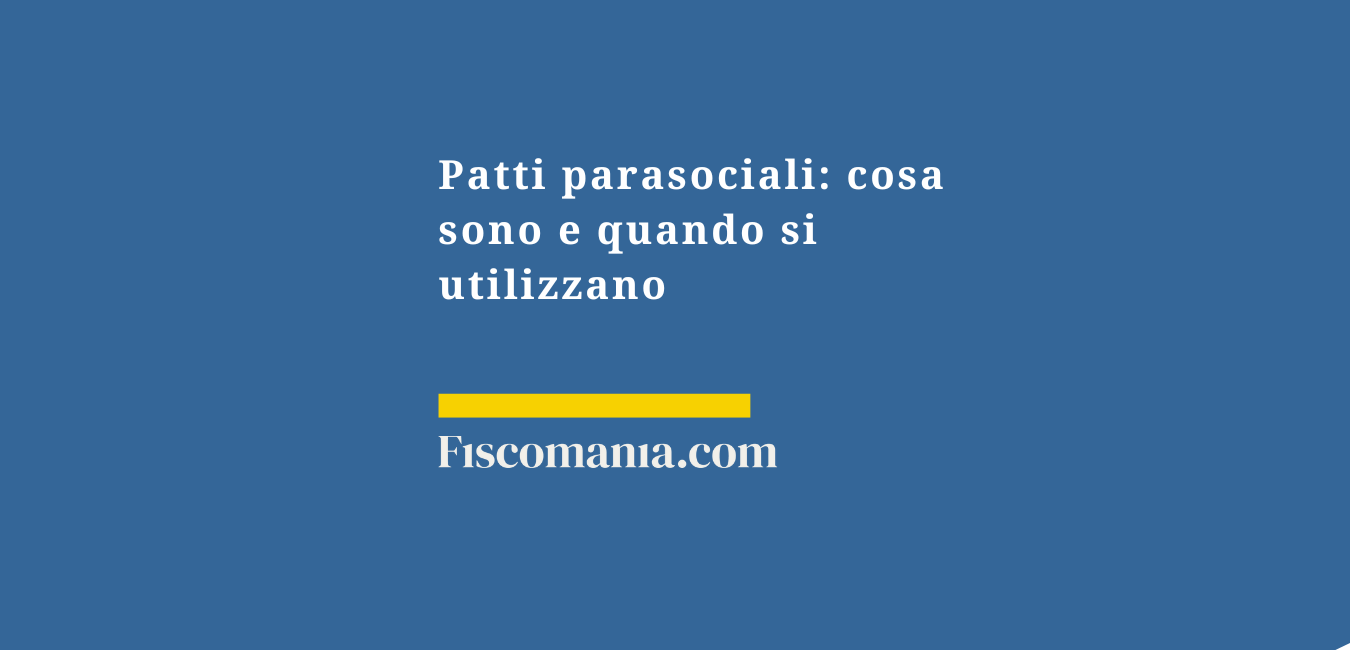I patti parasociali sono accordi privati stipulati tra soci di una società per regolare specifici aspetti della loro partecipazione societaria, che vanno oltre quanto previsto dallo statuto sociale. Possono riguardare: limitazioni al trasferimento delle partecipazioni; modalità di esercizio del diritto di voto; governance societaria; obblighi di non concorrenza tra i soci; meccanismi di risoluzione delle controversie.
Nel panorama imprenditoriale moderno, i patti parasociali rappresentano uno strumento giuridico fondamentale per garantire stabilità e controllo nelle società (di persone o capitali). Questi accordi, spesso sottovalutati o mal compresi, possono fare la differenza tra una gestione societaria serena e conflitti interni devastanti. Nella nostra attività di consulenza abbiamo assistito numerose aziende nell’implementazione di questi strumenti strategici, osservandone direttamente l’efficacia nella prevenzione di dispute e nella tutela degli investimenti.
Indice degli argomenti
- Cosa sono i patti parasociali: definizione e caratteristiche
- Le principali tipologie di patti parasociali
- Clausole avanzate: drag along, tag along e opzioni put/call
- Durata e limiti temporali
- Regime di pubblicità: trasparenza e riservatezza
- Il recesso
- Efficacia
- Violazione degli accordi
- Consulenza online specialistica
- Fonti normative e giurisprudenziali
I patti parasociali sono contratti stipulati tra soci di una società per regolamentare specifici comportamenti nei rapporti interni o verso la società stessa. A differenza dello statuto societario, questi accordi hanno natura extrasociale e vincolano esclusivamente le parti contraenti, senza produrre effetti verso terzi o verso la società. L’obiettivo dei patti parasociali è quello di andare a regolamentare alcuni diritti spettanti ai soci (clausole statutarie), volendo gestire gli stessi in modo unitario per i soci aderenti all’accordo.
La loro importanza strategica emerge particolarmente nelle società con strutture complesse, dove la presenza di soci non appartenenti allo stesso nucleo familiare o l’ingresso di investitori esterni richiede regole chiare di governance.
Riferimenti normativi
Da un punto di vista normativo, il riferimento principale è costituito dalla disciplina prevista per le SPA dall’art. 2341-bis c.c., rubricato “patti parasociali“. Tale disposizione trova applicazione esclusivamente per le società per azioni, mentre per le SRL non esiste una regolamentazione specifica.
Ciononostante, l’utilizzo di accordi parasociali risulta ammissibile anche nelle società a responsabilità limitata, seppur con una diversa base giuridica: in questo caso, infatti, non è possibile richiamare la normativa azionaria, dovendo fare affidamento sui principi generali dell’autonomia contrattuale e sulle disposizioni codicistiche di carattere generale.
Caratteristiche distintive
Le principali caratteristiche di questo tipo di accordi tra soci possono essere riassunte come segue:
- Natura contrattuale autonoma: I patti parasociali costituiscono accordi separati dall’atto costitutivo e dallo statuto, mantenendo piena autonomia negoziale;
- Efficacia obbligatoria limitata: Vincolano solo i soci sottoscrittori, non tutti i membri della compagine sociale;
- Flessibilità formale: Possono essere stipulati sia in forma scritta che verbale, anche se la prassi consiglia sempre la forma scritta per maggiore certezza. Essendo un contratto, può essere modificato in qualsiasi momento per adattarsi a nuove esigenze o a cambiamenti nella compagine sociale. La modifica richiede, di norma, il consenso di tutti i firmatari, a meno che l’accordo stesso non preveda procedure diverse (ad esempio, una decisione a maggioranza qualificata);
- Riservatezza: Non devono essere resi pubblici (salvo specifiche eccezioni per società quotate), permettendo ai soci di mantenere riservate le proprie strategie.
Sussistono varie tipologie di accordi parasociali, a titolo esemplificativo, possiamo individuare i seguenti.
Sindacati di voto
I sindacati di voto rappresentano la tipologia più diffusa di patti parasociali, finalizzati a uniformare il comportamento dei soci durante le assemblee. Questi accordi possono prevedere:
- Voto unanime: Tutti i soci del sindacato devono concordare la linea da seguire;
- Voto a maggioranza: Prevale la decisione della maggioranza dei soci sindacati;
- Delega a rappresentante comune: Un soggetto designato vota per conto di tutti i soci aderenti.
È fondamentale comprendere che la violazione del patto non inficia la validità della delibera assembleare, ma espone il socio inadempiente al risarcimento del danno verso gli altri partecipanti.
Sindacati di blocco
I sindacati di blocco mirano a stabilizzare la compagine sociale limitando la libera circolazione delle partecipazioni. Possono assumere diverse configurazioni:
- Divieto di alienazione temporaneo: Blocco delle cessioni per un periodo determinato;
- Clausole di prelazione: Diritto di precedenza per gli altri soci in caso di vendita;
- Gradimento: Necessità di approvazione per l’ingresso di nuovi soci.
Patti di consultazione
Questi accordi obbligano i soci a discutere preventivamente delle materie che saranno oggetto di votazione in assemblea, favorendo il coordinamento e riducendo i conflitti.
Patti di garanzia agli utili
Atto con il quale è garantito un utile minimo ad uno o più soci al momento della distribuzione dell’utile. Tuttavia, sussiste il divieto del c.d. patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ. il quale sancisce la nullità del “patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”. Pertanto è nullo il patto che prevede l’assegnazione di una quota mensile forfetaria di utili ai soci di minoranza, con esclusione della loro partecipazione alle perdite. E’ invalida anche la convenzione che esclude in maniera assoluta e costante un socio dalla ripartizione degli utili.
Tabella: differenze tra tipi di accordi
| Tipo di Patto | Obiettivo | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Sindacato di Voto | Consolidare il voto in assemblea | Potere decisionale coordinato | Rischio di limitare la libertà individuale |
| Patti di Blocco | Limitare la cessione delle quote | Stabilità della società | Ridotta flessibilità di disinvestimento |
| Patti di Consultazione | Coordinare decisioni strategiche | Riduzione dei conflitti interni | Necessità di continua negoziazione |
| Prelazione | Diritto di prelazione sulla vendita | Protezione contro l’ingresso di nuovi soci | Limiti alla libera circolazione delle quote |
Clausole avanzate: drag along, tag along e opzioni put/call
All’interno di questi accordi possono trovare applicazione specifiche clausole avanzate per regolare specifici aspetti dell’accordo. Le più famose sono le seguenti.
Il patto di co-vendita “drag along”
Il drag along attribuisce a un socio il diritto di obbligare gli altri a vendere congiuntamente le proprie partecipazioni alle medesime condizioni economiche. Questa clausola risulta particolarmente utile quando:
- Un acquirente desidera il controllo totalitario della società;
- Esistono quorum assembleari rafforzati che potrebbero bloccare la vendita;
- Si vuole facilitare l’exit strategy del socio di maggioranza.
Il patto assolve la funzione di garantire ad un socio la possibilità di disinvestire anche a fronte di richieste di acquisto non circoscritte alla partecipazione sociale dallo stesso detenuta, pur quando quest’ultima sia di maggioranza, a causa della presenza, ad esempio, di quozienti assembleari rafforzati in determinate materie tali da attribuire alla minoranza una sorta di diritto di veto. Tale clausola deve garantire che sia offerto al socio obbligato alla dismissione, almeno il valore che gli sarebbe spettato in caso di recesso, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 2437-ter del c.c..
Il patto di co-vendita “tag along”
Il tag along protegge i soci di minoranza consentendo loro di aderire alla vendita di un altro socio alle stesse condizioni. Questo meccanismo evita che il socio rimanga “intrappolato” con un nuovo partner non gradito. Il contenuto dell’obbligazione può essere diversamente articolato, potendo avere ad oggetto sia l’acquisto dell’intera partecipazione del socio creditore, sia l’acquisto di una partecipazione di misura proporzionale a quella eliminata dal socio debitore. L’avente diritto resta libero o meno di aderire alla proposta di compravendita, seppur formulata alla condizioni previste nel patto parasociale.
A tale fine la clausola è strutturata in modo tale che il soggetto passivo sia obbligato a informare gli aventi diritto circa il ricevimento della proposta di acquisto di un terzo; nell’onere di dichiarare entro un termine fisso la propria disponibilità di vendere a parità di prezzo e condizioni; nell’obbligo del soggetto passivo di adoperarsi affinché il terzo acquisti anche la partecipazione dell’avente diritto; in caso di rifiuto del terzo, nell’obbligo del soggetto passivo di non vendere la propria partecipazione o di ridurre l’ammontare della partecipazione venduta al fine di consentire all’avente diritto di vendere parte della propria partecipazione.
Tale clausola può essere annoverata tra i sindacati di blocco, dal momento che condiziona la trasferibilità della partecipazione ad una o più obbligazioni, la cui violazione può generare pesanti ripercussioni economiche a carico del soggetto obbligato, traducendosi in un limite alla libera circolazione delle partecipazioni. Ne consegue la soggezione del patto alla disciplina dell’articolo 2341-bis c.c..
Clausole di opzione put e call
Le opzioni put conferiscono il diritto di vendere la propria partecipazione a un prezzo predeterminato, mentre le opzioni call attribuiscono il diritto di acquistare la partecipazione altrui. Queste clausole sono frequenti nelle joint venture e negli accordi di investimento.
Mediante la stipulazione del contratto put, una parte acquisisce il diritto potestativo di vendere una partecipazione sociale, diritto da esercitare entro il termine contenuto a mente dell’articolo 1329 c.c.. Al contrario, mediante la stipulazione di un contratto di call una parte ha il diritto potestativo di acquistare, sempre entro il termine convenuto, la partecipazione della controparte, che si trova in uno stato giuridico di soggezione. Le clausole in oggetto ricorrono frequentemente nei contratti di acquisizione parziale di partecipazioni sociali, laddove viene a generarsi una situazione di joint venture tra due partners.
Tramite l’opzione di put una parte si riserva la facoltà di disinvestimento, mediante la vendita della sua partecipazione alla controparte, solitamente all’altro o ad un altro socio; in definitiva si realizza una possibile tecnica di way out dell’operazione economica, per la ragioni più diverse. Con l’opzione di call, invece, una parte ottiene il diritto di acquistare la partecipazione della controparte, con l’obiettivo di incrementare il proprio investimento nell’operazione o di estromettere l’altro socio dalla compagine sociale.
È prassi diffusa che le parti di un patto parasociale si concedano reciprocamente un’opzione di putt ed un’opzione di call. Lo scopo perseguito è quello di rendere certa per il socio che concede un’opzione di put e riceve un’opzione di call l’uscita dell’altro socio; e dall’altro lato, per il socio che riceve un’opzione di put e concede un opzione di call il diritto a disinvestire, uscendo dall’operazione. L’utilizzo combinato di clausole di put e call reciproche può costituire altresì una tecnica per fronteggiare, ed in via preventiva dissuadere, vicende di cambiamento del controllo delle società partecipanti, in qualità di contraenti del patto parasociale.
Durata e limiti temporali
Vediamo i limiti temporali suddivisi tra società per azioni e società a responsabilità limitata.
Società per Azioni (SPA)
Per le SPA, l’articolo 2341-bis del Codice Civile stabilisce che i patti parasociali hanno durata massima di 5 anni. Qualsiasi previsione eccedente questo termine viene automaticamente ricondotta al limite quinquennale.
Per i patti a tempo indeterminato, ogni socio può recedere con preavviso di 180 giorni.
Società a Responsabilità Limitata (SRL)
Nelle SRL non esistono limiti temporali specifici per i patti parasociali, lasciando piena autonomia alle parti contraenti. Tuttavia, per patti a durata indeterminata, resta ferma la possibilità di recesso con preavviso di 180 giorni.
Società quotate
Le società quotate seguono la disciplina del TUF (art. 122), che prevede durata massima di 3 anni rinnovabile, con diritto di recesso esercitabile con preavviso di 6 mesi.
Regime di pubblicità: trasparenza e riservatezza
Il regime pubblicitario di questi accordi è diverso e graduato a seconda che si tratti di società quotate, oppure che si tratti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società “aperte“), o di società che non vi fanno ricorso (società “chiuse“).
Società chiuse
Per le società chiuse non è previsto alcun obbligo di pubblicità, garantendo massima riservatezza agli accordi parasociali.
Società quotate
Le società quotate devono rispettare stringenti obblighi pubblicitari entro 5 giorni dalla stipulazione:
- Comunicazione alla CONSOB;
- Pubblicazione per estratto su quotidiano;
- Deposito presso il Registro delle Imprese;
- Comunicazione alla società.
L’inosservanza comporta nullità del patto e divieto di voto.
Società con azionariato diffuso
Devono dichiarare l’esistenza del patto all’apertura di ogni assemblea e trascrivere tale dichiarazione nel verbale da depositare al Registro delle Imprese.
Il recesso
Il recesso dai parasociali si esercita applicando la clausola prevista nei patti stessi. Nel caso in cui non sia prevista nessuna clausola, al fine di evitare controversie e conflitti interpretativi circa l’applicabilità o meno dell’art. 1373, 2° co. c.c. alla fattispecie, è preferible che le parti sciolgano il patto parasociale per mutuo consenso.
Efficacia
I patti parasociali, essendo contratti di diritto privato, producono effetti solo per le parti che li sottoscrivono. Producendo effetti soltanto per le parti che sottoscrivano l’accordo, gli obblighi derivanti dal patto parasociale non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica, mediante decisioni giudiziarie aventi effetti costitutivi.
La violazione del contenuto può comportare l’obbligo al risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli altri soci partecipanti al sindacato, purché i soci danneggiati provino e quantifichino in giudizio il danno subito a causa dell’altrui violazione del patto.
Violazione degli accordi
La violazione di un’intesa tra soci ha efficacia puramente obbligatoria, vincolando solo le parti firmatarie. Ciò significa che l’atto compiuto in violazione dell’accordo (ad esempio, un voto in assemblea difforme da quanto pattuito) resta valido ed efficace per la società. Il socio adempiente, tuttavia, ha a disposizione rimedi contrattuali: può richiedere il risarcimento del danno subito, dimostrando il nesso tra la violazione e il pregiudizio economico. Per rafforzare la tutela, è comune inserire nell’accordo una clausola penale, che predetermina l’importo da versare in caso di inadempimento, agendo come un forte deterrente.
Consulenza online specialistica
La complessità dei patti parasociali richiede competenze integrate di diritto societario, fiscale e strategico. È consigliabile richiedere consulenza professionale quando:
- Si pianificano operazioni di investimento o disinvestimento;
- Esistono conflitti latenti tra soci;
- Si valutano strategie di successione aziendale;
- Si strutturano acquisizioni parziali o joint venture.
Come professionisti del settore, possiamo affermare che un patto parasociale ben strutturato rappresenta un investimento fondamentale per la tutela del patrimonio aziendale e la prevenzione di costose dispute future.
Se desideri approfondire come questi strumenti possano essere utilizzati per proteggere il tuo investimento o migliorare la governance della tua società, non esitare a contattarci per una consulenza fiscale online. Saremo lieti di aiutarti a costruire un futuro solido per la tua impresa.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 14629/2001
- Articoli 2341-bis e 2341-ter del Codice Civile
- Articoli 122 e 123 del Testo Unico della Finanza
- Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 17960/2008
Leggi anche: