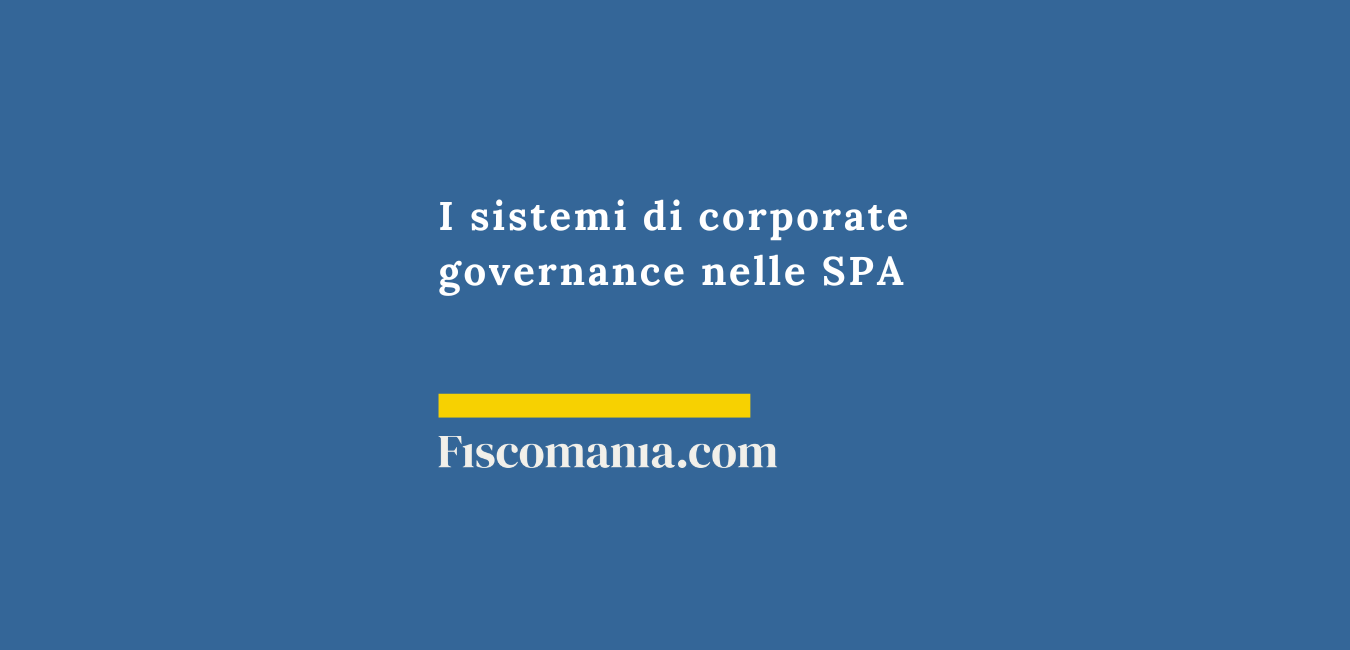Le società di capitali per il loro funzionamento possono adottare tre differenti modelli di Corporate Governance. Modelli da scegliere a seconda delle singole caratteristiche o peculiarità della società.
La scelta del sistema di corporate governance nelle SpA rappresenta una decisione strategica fondamentale che influenza direttamente l’efficienza operativa, la trasparenza gestionale e la capacità di attrarre investitori. Dal 2004, il legislatore italiano offre alle società per azioni tre modelli di amministrazione e controllo tra cui scegliere: una flessibilità che permette di adattare la struttura di governo societario alle specifiche esigenze aziendali, dimensionali e di mercato. Questa guida analizza in dettaglio caratteristiche, vantaggi e criticità di ciascun sistema, fornendo gli strumenti decisionali necessari per una scelta consapevole e strategicamente orientata.
Indice degli argomenti
- La definizione di corporate governance
- I tre sistemi di governance: panoramica normativa e applicativa
- Il sistema tradizionale: il modello italiano
- Sistema dualistico: il modello di derivazione tedesca
- Sistema monistico: il modello anglosassone
- La scelta del modello di corporate governance
- La corporate governance in Italia
- Consulenza online
- Fonti normative e riferimenti
La definizione di corporate governance
Si definisce corporate governance:
l’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa, intesa come sistema di compensazione fra gli interessi (potenzialmente divergenti) dei soci di minoranza, dei soci di controllo e degli amministratori di una società.
La struttura della Corporate Governance esprime quindi:
- Le regole e i processi con cui si prendono le decisioni in un’azienda;
- Le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali;
- I mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.
Sostanzialmente, si tratta di sistemi che regolano il governo aziendale. Si tratta in altri termini delle “regole del gioco” attraverso le quali si sviluppano le più importanti decisioni dell’impresa. Quelle che in linea di principio concorrono a determinare la prosperità o l’insuccesso di un’azienda.
Per questo motivo chi si appresta a costituire una società di rilevanti dimensioni, come una SPA deve fare particolare attenzione a scegliere il tipo di governance più adatto alle caratteristiche della società che vuole costituire.
I tre sistemi di governance: panoramica normativa e applicativa
La riforma del diritto societario introdotta con il D.Lgs. 6/2003 ha rivoluzionato l’architettura della governance delle società per azioni italiane, introducendo accanto al modello tradizionale due sistemi alternativi di derivazione internazionale. Questa evoluzione normativa risponde all’esigenza di rendere le SpA italiane più competitive nel contesto globale, permettendo strutture organizzative più flessibili e adatte a diverse realtà imprenditoriali.
La scelta del sistema di amministrazione e controllo deve essere esplicitata nello statuto sociale e può essere modificata attraverso una delibera dell’assemblea straordinaria. In assenza di una scelta statutaria specifica, si applica automaticamente il sistema tradizionale, che rimane il modello di default previsto dal legislatore.
Nella disciplina economico aziendale esistono tre principali modelli di gestione e controllo aziendale (corporate governance), che adesso andiamo ad analizzare, ovvero, il modello ordinario, il modello monistico e il modello dualistico.
Il sistema tradizionale: il modello italiano

Il sistema tradizionale di governance rappresenta il modello storicamente radicato nel tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da una netta separazione tra funzioni di gestione, controllo contabile e controllo di legalità. Questo sistema, disciplinato dagli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile, prevede una struttura articolata su tre organi distinti con competenze specifiche e non sovrapponibili.
Struttura e composizione degli organi
L’assemblea dei soci rappresenta l’organo sovrano che esprime la volontà sociale attraverso le deliberazioni. Le sue competenze variano significativamente tra assemblea ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, determina il loro compenso, nomina i sindaci e il revisore legale, delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci. L’assemblea straordinaria, invece, si occupa delle modifiche statutarie, delle operazioni straordinarie e dello scioglimento della società.
Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico costituisce l’organo di gestione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La composizione numerica del CdA varia in base alle dimensioni aziendali e alle esigenze operative: dalle piccole SpA con amministratore unico alle grandi società quotate con consigli composti da 15-20 membri. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, mantenendo comunque alcune competenze non delegabili come l’approvazione dei piani strategici e la vigilanza sul generale andamento della gestione.
Il collegio sindacale rappresenta l’organo di controllo interno composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti. I sindaci devono possedere specifici requisiti di professionalità e indipendenza, essere iscritti nel registro dei revisori legali e svolgere funzioni di vigilanza sulla legalità e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Nelle società non quotate che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale può anche svolgere la revisione legale dei conti, purché tutti i sindaci siano revisori legali iscritti.
Vantaggi operativi del sistema tradizionale
La familiarità culturale del modello tradizionale nel contesto italiano facilita l’interazione con stakeholder nazionali, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni. Gli operatori del diritto, dai notai ai commercialisti, dai consulenti agli avvocati societari, hanno una conoscenza approfondita di questo sistema, riducendo i costi di consulenza e i rischi di errori procedurali.
La separazione netta delle funzioni garantisce un sistema di checks and balances consolidato, dove ciascun organo opera in autonomia ma con obblighi informativi reciproci. Questa struttura favorisce la specializzazione delle competenze: gli amministratori si concentrano sulla gestione strategica e operativa, mentre i sindaci mantengono il focus sul controllo di legalità e correttezza amministrativa.
La flessibilità nella composizione del CdA permette di adattare l’organo amministrativo alle dimensioni aziendali. Le PMI possono optare per strutture snelle con pochi amministratori o amministratore unico, mentre le grandi società possono articolare il consiglio in comitati specializzati (comitato controllo e rischi, comitato remunerazioni, comitato nomine) senza modificare il sistema di governance complessivo.
Criticità e limiti strutturali
Il sistema tradizionale presenta alcune inefficienze nei flussi informativi tra organi, con possibili duplicazioni di controlli e rallentamenti decisionali. La presenza di molteplici organi con funzioni di controllo (collegio sindacale, revisore legale, eventuale organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) può generare sovrapposizioni operative e aumentare i costi di compliance.
Per le società con vocazione internazionale, il modello tradizionale può risultare meno attrattivo per investitori esteri abituati a sistemi di governance anglosassoni o germanici. La complessità della struttura e la molteplicità degli organi possono essere percepite come elementi di rigidità che rallentano i processi decisionali in contesti di mercato dinamici.
Sistema dualistico: il modello di derivazione tedesca

Il sistema dualistico, disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice Civile, introduce in Italia un modello di governance di matrice germanica caratterizzato dalla presenza di un consiglio di sorveglianza che si interpone tra l’assemblea e l’organo di gestione. Questa struttura a due livelli (two-tier) separa nettamente le funzioni di supervisione strategica da quelle di gestione operativa.
Architettura organizzativa e funzioni
L’assemblea dei soci nel sistema dualistico vede ridotte le proprie competenze rispetto al modello tradizionale. Nomina e revoca i membri del consiglio di sorveglianza, determina il loro compenso, nomina il revisore legale e delibera sulla distribuzione degli utili, ma non approva direttamente il bilancio, competenza che passa al consiglio di sorveglianza salvo specifica richiesta di almeno un terzo dei componenti di uno dei due consigli.
Il consiglio di gestione rappresenta l’organo amministrativo vero e proprio, composto da almeno due membri anche non soci. I consiglieri di gestione sono nominati dal consiglio di sorveglianza che può anche revocarli, creando un rapporto fiduciario diretto tra i due organi. Il consiglio di gestione ha competenza esclusiva per la gestione dell’impresa e compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Il consiglio di sorveglianza costituisce l’elemento distintivo del sistema dualistico, composto da almeno tre membri con specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Oltre alle funzioni di controllo tipiche del collegio sindacale nel sistema tradizionale, il consiglio di sorveglianza approva il bilancio d’esercizio, nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti e riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta.
Opportunità strategiche del modello dualistico
La concentrazione del potere decisionale nel consiglio di gestione, svincolato dall’assemblea per la nomina, garantisce maggiore autonomia operativa e rapidità nelle scelte strategiche. Questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa in contesti di mercato volatili o per società che operano in settori ad alta innovazione tecnologica dove la tempestività decisionale rappresenta un fattore competitivo critico.
Per le società con azionariato diffuso o frammentato, il sistema dualistico offre una governance più stabile, meno soggetta alle fluttuazioni delle maggioranze assembleari. Il consiglio di sorveglianza funge da filtro tra proprietà e gestione, garantendo continuità strategica anche in presenza di cambiamenti nella compagine societaria.
La valorizzazione delle competenze tecniche trova nel sistema dualistico un ambiente favorevole. Il consiglio di gestione può essere composto interamente da manager professionisti scelti per competenze specifiche, mentre il consiglio di sorveglianza mantiene il collegamento con la proprietà assicurando l’allineamento agli interessi degli azionisti.
Complessità applicative e sfide operative
L’incremento dei costi di governance rappresenta una criticità significativa del sistema dualistico. La presenza di due organi consiliari comporta maggiori oneri per compensi, assicurazioni D&O (Directors and Officers), costi di funzionamento e supporto segretariale. Per società di dimensioni medio-piccole, questi costi aggiuntivi possono risultare sproporzionati rispetto ai benefici.
La scarsa diffusione in Italia del modello dualistico genera difficoltà pratiche: limitata giurisprudenza di riferimento, minore esperienza degli operatori professionali, possibili incertezze interpretative su aspetti non completamente disciplinati dalla normativa. Le banche e gli investitori istituzionali italiani possono mostrare diffidenza verso un sistema percepito come complesso e meno trasparente.
I potenziali conflitti tra i due consigli richiedono un’attenta definizione statutaria delle rispettive competenze e modalità di interazione. La sovrapposizione di alcune funzioni, come l’approvazione dei piani strategici, può generare tensioni operative se non adeguatamente regolamentata attraverso regolamenti interni e protocolli di comunicazione.
Sistema monistico: il modello anglosassone

Il sistema monistico, regolato dagli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile, importa nel diritto societario italiano il modello di governance anglosassone basato su un unico organo amministrativo al cui interno viene costituito un comitato con funzioni di controllo. Questa struttura one-tier elimina la tradizionale separazione tra amministrazione e controllo interno, concentrando entrambe le funzioni nel consiglio di amministrazione.
Configurazione e meccanismi di funzionamento
Nel sistema monistico, l’assemblea dei soci mantiene competenze simili al modello tradizionale: nomina e revoca gli amministratori, ne determina il compenso, nomina il revisore legale, approva il bilancio e delibera sugli altri oggetti di sua competenza. La principale differenza risiede nel fatto che l’assemblea nomina un unico organo consiliare anziché organi distinti per amministrazione e controllo.
Il consiglio di amministrazione nel sistema monistico assume una configurazione particolare. Deve essere composto per almeno un terzo da amministratori indipendenti in possesso dei requisiti previsti dal codice civile e dalle eventuali previsioni statutarie. Il consiglio gestisce l’impresa con pienezza di poteri e al suo interno nomina il comitato per il controllo sulla gestione, creando una distinzione funzionale tra amministratori esecutivi e amministratori con funzioni di controllo.
Il comitato per il controllo sulla gestione rappresenta l’innovazione caratteristica del sistema monistico. Composto da almeno tre amministratori indipendenti (o due nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), il comitato vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile. I componenti del comitato non possono essere membri del comitato esecutivo né svolgere funzioni gestorie neppure in società controllate o controllanti.
Benefici dell’integrazione funzionale
La semplificazione della struttura di governance riduce i livelli decisionali e accelera i processi informativi. L’unicità dell’organo amministrativo elimina le potenziali ridondanze e conflitti tra organi distinti, favorendo un dialogo diretto e continuo tra funzioni di gestione e controllo. Questa integrazione risulta particolarmente efficace per società che operano in settori dove la velocità decisionale e l’adattabilità rappresentano vantaggi competitivi determinanti.
L’ottimizzazione dei costi di governance deriva dalla presenza di un solo organo consiliare anziché due o tre organi distinti. La riduzione del numero complessivo di amministratori e sindaci comporta minori costi per compensi, minori oneri assicurativi e amministrativi, semplificazione delle procedure di convocazione e verbalizzazione. Per le PMI quotate o per le società in crescita, questa efficienza economica può liberare risorse da destinare allo sviluppo del business.
La familiarità per investitori internazionali rappresenta un vantaggio strategico significativo. Il modello monistico è ampiamente diffuso nei paesi anglosassoni e risulta immediatamente comprensibile per fondi di investimento, private equity e investitori istituzionali esteri. Questa caratteristica può facilitare l’accesso ai mercati internazionali dei capitali e ridurre il costo del capitale proprio.
Rischi e limitazioni del modello monistico
La potenziale commistione tra controllo e gestione costituisce la principale criticità del sistema monistico. Nonostante i requisiti di indipendenza, i membri del comitato per il controllo sulla gestione siedono nello stesso consiglio degli amministratori esecutivi, partecipando alle deliberazioni consiliari. Questa vicinanza può compromettere l’oggettività del controllo, specialmente in situazioni di potenziale conflitto di interessi.
La limitata esperienza applicativa in Italia genera incertezze operative e interpretative. La scarsità di precedenti giurisprudenziali e di prassi consolidate può creare difficoltà nella gestione di situazioni complesse o straordinarie. Professionisti e consulenti potrebbero non avere familiarità con le specificità del modello, aumentando il rischio di errori procedurali o di governance.
I requisiti stringenti di indipendenza per una quota significativa del consiglio possono risultare onerosi per società a capitale concentrato o familiare. La necessità di reperire amministratori indipendenti qualificati e disponibili a assumere responsabilità di controllo può comportare costi di ricerca e selezione elevati, oltre a compensi superiori per attrarre profili adeguati.
La scelta del modello di corporate governance
La selezione del sistema di governance richiede un’analisi multidimensionale che consideri variabili interne ed esterne all’organizzazione. Non esiste un modello universalmente superiore: la scelta ottimale dipende dalle specificità aziendali, dagli obiettivi strategici e dal contesto competitivo di riferimento.
Dimensione e complessità aziendale
Le società di piccole e medie dimensioni con strutture organizzative semplici e azionariato concentrato trovano generalmente nel sistema tradizionale la soluzione più efficiente. La familiarità del modello riduce i costi di implementazione e gestione, mentre la flessibilità nella composizione degli organi permette di adattare la governance alla crescita aziendale senza cambiamenti strutturali.
Le grandi società con operazioni complesse e diversificate possono beneficiare del sistema dualistico o monistico. Il dualistico offre una separazione netta tra supervisione strategica e gestione operativa, utile per gruppi con multiple business unit o presenza internazionale. Il monistico garantisce rapidità decisionale e integrazione informativa, vantaggiosa per società in settori dinamici o in fase di trasformazione.
Struttura proprietaria e obiettivi degli azionisti
Le società a controllo familiare spesso privilegiano il sistema tradizionale che garantisce un controllo diretto attraverso l’assemblea sulla nomina degli amministratori. Il modello tradizionale preserva l’influenza della proprietà sulla gestione mantenendo al contempo organi di controllo indipendenti che tutelano eventuali soci di minoranza.
Le società con azionariato diffuso o in preparazione alla quotazione possono trovare nel sistema monistico o dualistico strutture più adatte ad attrarre investitori istituzionali. Il monistico facilita il dialogo con investitori anglosassoni, mentre il dualistico può risultare attrattivo per partnership con aziende dell’Europa continentale.
Prospettive di sviluppo e internazionalizzazione
Le società con piani di espansione internazionale dovrebbero valutare l’adozione di sistemi di governance riconoscibili nei mercati target. Il sistema monistico facilita l’ingresso nei mercati anglosassoni e l’attrazione di capitali da fondi internazionali. Il sistema dualistico può favorire joint venture o acquisizioni nell’Europa centrale e settentrionale.
La preparazione a operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni o quotazioni richiede una governance flessibile e credibile per il mercato. Il passaggio a un sistema monistico prima di un’IPO può segnalare l’adozione di best practice internazionali, mentre il mantenimento del sistema tradizionale con l’introduzione di comitati endoconsiliari può rappresentare un compromesso efficace.
La corporate governance in Italia
Nel panorama italiano, caratterizzato dalla presenza di piccole-medie imprese, le best practices di Corporate Governance hanno trovato applicazione nelle imprese quotate.
La definizione di efficaci strutture di governo e controllo aziendale consentono una migliore distribuzione del valore e delle performance societarie.
La Corporate Governance è un elemento fondamentale nell’ambito del sistema aziendale. Essa è in grado di influenzare la fiducia del mercato dei capitali tanto quanto le performance dell’impresa stessa.
Considerata l’importanza di tale aspetto per il perseguimento dell’economicità d’impresa, nella prassi si sono affermati diversi principi colti a definire best practice applicative sul tema degli assetti di governo e controllo delle imprese.
Aspetti che andremo a vedere di seguito.
Il codice di autodisciplina di Borsa Italiana
il Codice di Autodisciplina, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, pubblicato nella sua prima edizione, nel 1999 è stato modificato profondamente nel 2006.
A questo link puoi scaricare l’ultima versione del modello.
Il Codice di Autodisciplina è formato in particolare da 10 articoli di cui i primi 6 incentrati sul consiglio di amministrazione, il suo funzionamento, la sua indipendenza, nomina e remunerazione.
I restanti 4 articoli analizzano gli altri aspetti caratterizzanti la corporate governance ovvero i sindaci, il sistema di controllo interno, il rapporto con gli azionisti e le forme non tradizionali di governace (sistema dualistico e monistico).
Si comprende, fin da subito, come si ritenga di fondamentale importanza il consiglio di amministrazione, in qualità di organo preposto alla direzione e allo sviluppo della società.
Il Codice di Autodisciplina è accettato e applicato su base volontaria dalle società quotate, le quali però sono tenute a dichiarare a quali articoli non si conformano (principio del comply or explain).
La corporate governance per PMI
Per quanto riguarda le PMI i principi di Corporate Governance devono essere una fonte di ausilio ai costi che una struttura organizzata e strutturata comporta.
Tali principi prevedono quanto segue:
- Definizione di un quadro istituzionale e di governance adeguato all’impresa;
- Adozione di un codice etico e di comportamento. Gli organi sociali devono farsi promotori dei contenuti del codice etico;
- Costituzione di un consiglio di amministrazione o di un Advisory Board;
- Nomina di un adeguato numero di consiglieri indipendenti e non esecutivi nel consiglio di amministrazione;
- Il compito del consiglio di amministrazione/Advisory Board deve essere quello di supportare la proprietà aziendale nella definizione del codice etico, nella scelta delle strategie aziendali, nell’analisi e presidio dei rischi di impresa, nella valutazione dei risultati e nel monitoraggio e risoluzione di eventuali situazioni di conflitto di interessi fra soci e amministratore unico/delegato;
- Rispetto dei principi di funzionamento del consiglio di amministrazione;
- Creazione o implementazione di un adeguato sistema di controllo interno, che deve essere basato su controlli di primo livello e formalizzazione della loro struttura, segregazione delle responsabilità, tracciabilità dei dati e delle informazioni, verifica del raggiungimento dei KPI, informativa economica-patrimoniale e finanziaria almeno trimestrale;
- istituzione di un organo di controllo;
- Adeguato livello di remunerazione degli organi sociali al fine di attrarre e motivare persone adeguate alla realtà imprenditoriale stessa;
- Programmazione e pianificazione della successione a livello di proprietà aziendale;
- Comunicazione e informazione costante e periodica da parte del consiglio di amministrazione a tutti i soci tramite reportistica specifica e meccanismi atti a evidenziare e gestire i conflitti di interesse tra soci. Inoltre nel bilancio annuale si approfondisce l’informativa circa i principi adottati e la composizione e frequenza delle riunioni degli organi sociali.
Consulenza online
La scelta e l’implementazione del sistema di governance ottimale per la vostra SpA richiede un’analisi approfondita delle specificità aziendali e degli obiettivi strategici di medio-lungo termine. Ogni sistema presenta vantaggi e complessità che devono essere valutati nel contesto specifico della vostra realtà imprenditoriale, considerando non solo gli aspetti giuridici ma anche le implicazioni organizzative, economiche e reputazionali.
Il nostro studio offre consulenza specializzata nell’analisi comparativa dei sistemi di governance, supportando il processo decisionale con valutazioni quantitative dei costi-benefici e simulazioni degli impatti organizzativi. Accompagniamo le società in tutte le fasi della transizione, dalla progettazione statutaria all’implementazione operativa, assicurando compliance normativa e ottimizzazione dei processi di governance.
Contattateci per una consulenza dove analizzeremo la vostra situazione attuale e identificheremo le opportunità di ottimizzazione della governance societaria.
Fonti normative e riferimenti
- Codice Civile, articoli 2380-2409-noviesdecies (Libro V, Titolo V, Capo V)
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – Riforma organica della disciplina delle società di capitali
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- Principi di Corporate Governance del Comitato per la Corporate Governance (Borsa Italiana, ed. 2020)
- Massimario Notarile – Orientamenti in materia di sistemi di amministrazione e controllo
- Circolare Assonime n. 15/2024 – Governance delle società per azioni: profili applicativi
- Documento Banca d’Italia – Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013)