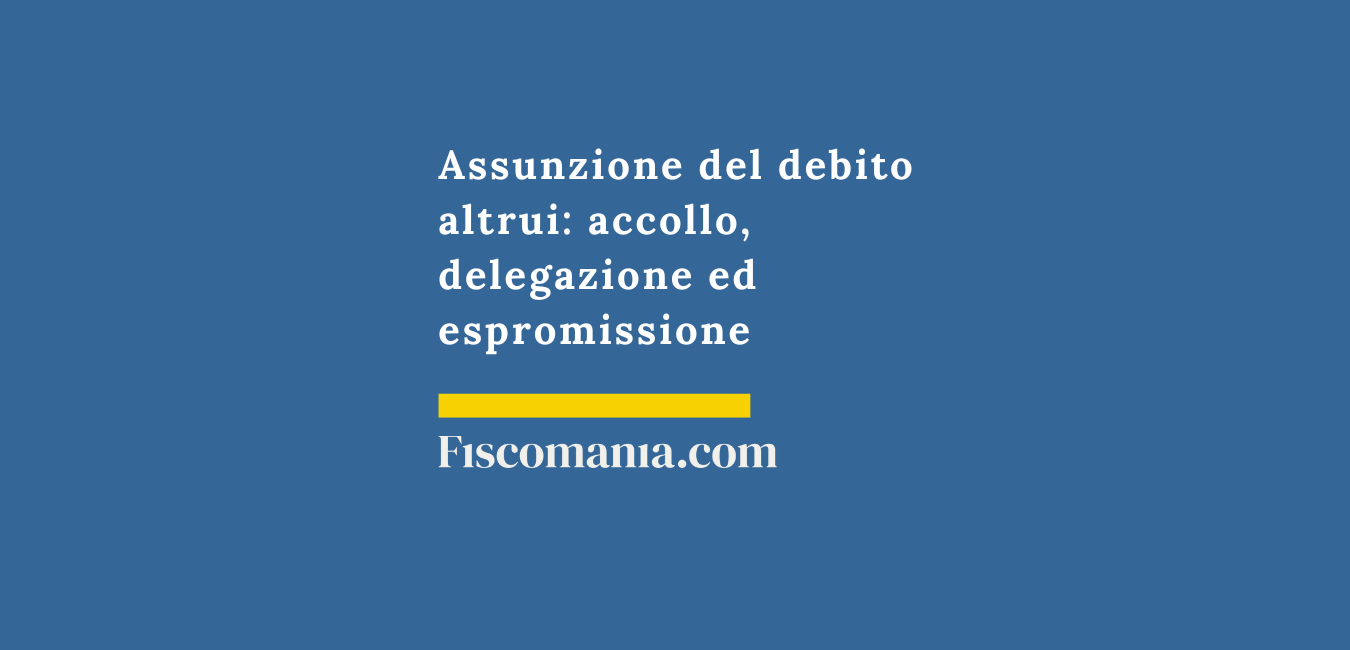Tutto quello che imprenditori e privati devono sapere su accollo, delegazione ed espromissione per gestire strategicamente i debiti aziendali e personali.
L’assunzione del debito altrui è il meccanismo con cui un soggetto terzo entra nel rapporto obbligatorio assumendo il debito di un altro, attraverso istituti distinti come accollo, espromissione e delegazione, ciascuno con effetti, presupposti e rischi operativi differenti. Per chi compra o vende immobili, ristruttura debiti, o gestisce operazioni societarie, comprendere come funziona l’assunzione del debito è decisivo per negoziare clausole liberatorie, preservare garanzie e prevenire contenziosi con il creditore.
Allo stesso tempo, quando un’impresa acquisisce un ramo d’azienda, rileva un’attività commerciale o semplicemente necessita di ottimizzare la propria struttura debitoria, la comprensione approfondita di questi meccanismi diventa essenziale per una gestione patrimoniale efficace. Il nostro ordinamento prevede tre modalità principali attraverso cui un soggetto terzo può assumere l’obbligazione di un debitore: l’accollo, la delegazione e l’espromissione, ciascuna con caratteristiche specifiche e implicazioni fiscali differenti.
Indice degli argomenti
- Come funziona l’assunzione di un debito da parte di un terzo
- L’accollo: lo strumento più utilizzato nelle operazioni immobiliari
- La delegazione: versatilità per le imprese
- L’espromissione: quando il terzo interviene spontaneamente
- Tabella di confronti tra i vari istituti
- Implicazioni fiscali e ottimizzazione tributaria
- Esempi pratici e casi d’uso
- Scelte strategiche: quale istituto usare e perché
- Profili di rischio e tutele contrattuali
- Consulenza online
- FAQ: domande frequenti
- Fonti
Come funziona l’assunzione di un debito da parte di un terzo
Il meccanismo dell’assunzione del debito coinvolge sempre tre soggetti: il creditore originario, il debitore principale e il terzo assuntore. La complessità di queste operazioni risiede nella gestione di tre rapporti giuridici distinti che si intrecciano tra loro. Gli strumenti tipici sono tre: accollo ex art. 1273 c.c., espromissione ex art. 1272 c.c. e delegazione ex artt. 1268-1269 c.c., che si distinguono per struttura negoziale, necessità di adesione del creditore e riferimenti ai rapporti di valuta e provvista.
Il rapporto di valuta intercorre tra creditore e debitore originario e costituisce l’obbligazione principale che si intende trasferire o garantire. Il rapporto di provvista lega invece il terzo assuntore al debitore originario e rappresenta spesso la ragione economica sottostante all’operazione. Infine, si crea un nuovo rapporto tra creditore e terzo assuntore che può sostituire o affiancare quello originario.
Gli effetti giuridici e fiscali dell’operazione
Quando un’impresa assume il debito di un’altra, le conseguenze non sono solo civilistiche ma anche fiscali. Dal punto di vista tributario, l’operazione può comportare l’emersione di componenti positive o negative di reddito, a seconda del corrispettivo pattuito e del valore nominale del debito assunto. È fondamentale valutare preventivamente questi aspetti per evitare sorprese in sede di dichiarazione dei redditi.
La liberazione del debitore originario non è automatica ma richiede sempre un’espressa dichiarazione del creditore. Questa distinzione tra assunzione cumulativa e liberatoria ha riflessi importanti sulla solidarietà passiva e sulle garanzie che assistono il credito.
L’accollo: lo strumento più utilizzato nelle operazioni immobiliari
L’accollo del debito rappresenta la forma più diffusa di assunzione del debito altrui, particolarmente nelle compravendite immobiliari gravate da mutuo ipotecario. Si tratta di un contratto trilaterale attraverso cui l’accollante si obbliga verso il creditore accollatario ad estinguere il debito dell’accollato.
Accollo interno ed esterno: differenze operative
L’accollo interno rimane confinato nel rapporto tra accollante e accollato, senza attribuire diritti diretti al creditore. Questa forma è utilizzata principalmente come clausola interna di indennizzo in operazioni societarie complesse. Il creditore potrà eventualmente agire solo attraverso l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., sempre che ne sussistano i presupposti.
L’accollo esterno, disciplinato dall’art. 1273 c.c., attribuisce invece al creditore il diritto di pretendere l’adempimento direttamente dall’accollante. Dal momento dell’adesione del creditore, la stipulazione diventa irrevocabile e l’accollante risponde direttamente nei confronti del creditore.
Caso emblematico si realizza con il contratto di compravendita in cui il venditore anziché farsi pagare tutto il prezzo del bene acquistato (generalmente un immobile), devia questo suo diritto a favore di un suo creditore. Quest’ultimo è il mutuante che gli ha lasciato il mutuo per l’acquisto della casa che è in procinto di vendere.
Applicazioni pratiche nell’ambito aziendale
Nelle acquisizioni aziendali, l’accollo viene frequentemente utilizzato per la gestione dei debiti verso fornitori o istituti di credito. Un caso tipico si verifica quando l’acquirente di un’azienda si accolla i debiti commerciali del cedente, detraendo il relativo importo dal prezzo di cessione. Questa operazione permette una semplificazione dei rapporti e può generare vantaggi fiscali attraverso la deduzione degli interessi passivi.
Esempio pratico: Un imprenditore acquista un capannone industriale del valore di 800.000 euro gravato da un mutuo residuo di 300.000 euro. Attraverso l’accollo, l’acquirente paga solo 500.000 euro al venditore e si impegna a corrispondere le rate residue del mutuo direttamente alla banca. L’operazione comporta un risparmio immediato di liquidità e mantiene condizioni di finanziamento potenzialmente più vantaggiose.
Il regime delle eccezioni nell’accollo
L’accollante può opporre al creditore tutte le eccezioni fondate sul rapporto di valuta, tranne quelle personali all’accollato. Inoltre, essendo l’accollo titolato anche rispetto al rapporto di provvista, l’accollante può eccepire le vicende del contratto base. Se il contratto di compravendita viene risolto o dichiarato nullo, decade anche l’obbligo di accollo.
La delegazione: versatilità per le imprese
La delegazione di pagamento e la delegazione promissoria offrono maggiore flessibilità rispetto all’accollo, potendo essere strutturate in modi diversi a seconda delle esigenze operative dell’impresa. In particolare possiamo avere:
La delegazione promissoria (art. 1268 c.c.) comporta l’assunzione di un’obbligazione del delegato verso il delegatario su incarico del delegante. Si crea un vero vincolo obbligatorio che può sostituire o affiancare quello originario.
La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) consiste invece in un semplice ordine di pagamento senza creazione di vincoli obbligatori. Il delegato mantiene la facoltà di adempiere ma non è obbligato verso il delegatario. Questo strumento è particolarmente utile nelle operazioni di tesoreria aziendale e nella gestione dei flussi finanziari infragruppo.
La delegazione pura e i suoi rischi
La delegazione pura non menziona né il rapporto di valuta né quello di provvista, configurandosi come un’attribuzione patrimoniale astratta. Questa caratteristica la rende uno strumento potente ma rischioso, utilizzabile per operazioni di pianificazione patrimoniale complesse ma con attenzione alle possibili contestazioni sulla causa del negozio.
Dal punto di vista fiscale, la delegazione pura può sollevare questioni sulla deducibilità dei costi e sulla natura dell’operazione ai fini IVA, richiedendo un’attenta valutazione preventiva.
Strategie di utilizzo nel tax planning
La delegazione trova applicazione strategica nella gestione dei rapporti infragruppo e nelle operazioni di cash pooling. Attraverso delegazioni incrociate è possibile ottimizzare i flussi finanziari riducendo i costi di transazione e migliorando l’efficienza fiscale del gruppo.
L’espromissione: quando il terzo interviene spontaneamente
L’espromissione si distingue per l’intervento spontaneo del terzo espromittente, senza delega o incarico del debitore espromesso. Questo istituto, disciplinato dall’art. 1272 c.c., trova applicazione principalmente nelle situazioni di crisi aziendale e nelle operazioni di salvataggio.
L’espromittente assume l’obbligazione facendo riferimento necessario al rapporto di valuta, che costituisce la causa stessa dell’operazione. Non potendo opporre le eccezioni derivanti dal rapporto con il debitore originario (salvo patto contrario), l’espromittente si trova in una posizione più esposta rispetto all’accollante.
L’espromissione può essere cumulativa, mantenendo la responsabilità sussidiaria del debitore originario, o privativa con liberazione totale dello stesso. La scelta tra le due modalità dipende dalla valutazione del rischio creditizio e dalle garanzie disponibili.
Applicazioni nelle ristrutturazioni aziendali
Nelle procedure di risanamento aziendale, l’espromissione viene utilizzata quando un soggetto terzo (tipicamente la capogruppo o un investitore) interviene per garantire la continuità operativa assumendo debiti strategici. L’operazione può essere strutturata per preservare rapporti commerciali essenziali o per evitare azioni esecutive dannose.
Tabella di confronti tra i vari istituti
Clausola liberatoria e rischi
Attenzione alla clausola liberatoria nell’accollo ed espromissione: senza espressa condizione o dichiarazione del creditore, il debitore originario resta coobbligato in solido con il terzo, con possibili impatti su affidamenti bancari e compliance. Inserire sempre un testo chiaro sulla liberazione e sulle garanzie residue, compresa la regolazione dell’eventuale beneficio di escussione e del perimetro delle eccezioni opponibili.
Implicazioni fiscali e ottimizzazione tributaria
L’assunzione del debito altrui genera conseguenze fiscali differenziate che richiedono un’analisi approfondita caso per caso. Dal punto di vista delle imposte dirette, l’operazione può comportare:
- Sopravvenienze attive per il debitore liberato, tassabili secondo le regole ordinarie;
- Costi deducibili per l’assuntore, nei limiti della competenza e inerenza;
- Variazioni patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Per quanto riguarda l’IVA, l’assunzione del debito non costituisce di per sé operazione rilevante, ma può influenzare il pro-rata di detraibilità e i termini di versamento dell’imposta.
Esempi pratici e casi d’uso
Vediamo, di seguito, alcuni esempi pratici di applicazione dei vari istituti in commento, in relazione anche alla nostra esperienza diretta.
Compravendita immobiliare con mutuo residuo e accollo
Un venditore di immobile con mutuo residuo conviene con l’acquirente che quest’ultimo si accolli il debito residuo, decurtando l’importo dal prezzo, e la banca aderisce alla stipulazione per azione diretta sull’accollante. Se la clausola non prevede liberazione o la banca non la dichiara, il venditore resta solidalmente responsabile finché il mutuo non è estinto, con potenziali riflessi su merito creditizio e garanzie.
Consolidamento debiti e espromissione liberatoria
Una società capogruppo assume mediante espromissione il debito di una controllata verso un fornitore strategico, e il fornitore dichiara di liberare la controllata per stabilizzare i rapporti commerciali. Qui l’iniziativa del terzo è rivolta al creditore e, con la dichiarazione liberatoria, la debitrice originaria esce dal rapporto, ma il regime delle eccezioni resta ancorato al rapporto di valuta.
Cash management e delegazione promissoria
Una capogruppo delega una consociata a promettere il pagamento ai fornitori del gruppo, titolando la delegazione sia a valuta sia a provvista per consentire al delegato di far valere eccezioni pertinenti ai rapporti sottostanti. La promessa delegatoria crea un obbligo del delegato verso il creditore che, salvo liberazione espressa, non estromette il debitore originario ma ne regola i rapporti interni con beneficio di escussione.
Scelte strategiche: quale istituto usare e perché
Quando serve azione diretta del creditore sul terzo e possibile liberazione del debitore, l’accollo esterno con adesione del creditore è lo strumento più lineare, specie se integrato da clausola liberatoria espressa.
Se si intende rafforzare un credito senza coinvolgere formalmente il debitore originario, l’espromissione offre una via rapida con modulazione tra cumulativa e privativa, mantenendo chiaro il perimetro delle eccezioni sul rapporto di valuta.
Quando l’obiettivo è ingegnerizzare i flussi di pagamento in gruppi o filiere senza necessariamente trasferire il debito, la delegazione, specie promissoria, consente architetture contrattuali flessibili ma va titolata con cura per evitare incertezze sull’effettiva assunzione.
In ogni caso, la redazione delle clausole su liberazione, garanzie, eccezioni opponibili e ordine di escussione è cruciale per prevenire contenziosi ed allineare gli interessi tra debitore, terzo e creditore.
Profili di rischio e tutele contrattuali
Il rischio principale è la mancata liberazione del debitore originario per assenza di clausola o dichiarazione espressa, con responsabilità solidale involontaria e riflessi su rating e covenant. Ulteriori rischi riguardano l’invalidità o inefficacia della causa di provvista nei modelli titolati, che può riaprire l’obbligazione originaria ex art. 1274 c.c. e alterare i rapporti interni di regresso.
Prevedere condizioni sospensive per la liberazione, representations sullo stato del debito e meccanismi di indennizzo preserva l’equilibrio dell’operazione e limita l’esposizione per le parti.
Per operazioni su crediti bancari o fornitori strategici, è consigliabile raccogliere formale adesione del creditore e allineare i testi con policy di compliance e sistemi di garanzia accessoria.
Consulenza online
L’assunzione del debito altrui rappresenta un’operazione complessa che richiede competenze multidisciplinari. La scelta tra accollo, delegazione ed espromissione deve essere guidata da un’analisi approfondita degli aspetti civilistici, fiscali e strategici specifici di ogni situazione.
La corretta strutturazione dell’operazione può generare significativi vantaggi economici e fiscali, mentre errori di valutazione possono comportare costi imprevisti e responsabilità inattese. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti che possano guidare l’intero processo, dalla due diligence iniziale alla formalizzazione contrattuale, garantendo la piena tutela degli interessi coinvolti.
Se stai valutando un’operazione di assunzione del debito per la tua impresa o necessiti di assistenza nella strutturazione di operazioni straordinarie, contattaci per una consulenza personalizzata.
FAQ: domande frequenti
L’accollo nasce da un accordo tra debitore e terzo assuntore, mentre nell’espromissione il terzo interviene spontaneamente senza accordo con il debitore originario.
Per l’efficacia verso il creditore è sempre necessaria la sua adesione o accettazione, tranne nell’accollo interno che rimane efficace solo tra accollante e accollato.
Il debitore liberato realizza una sopravvenienza attiva pari all’ammontare del debito estinto, tassabile secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa.
L’assunzione è liberatoria solo con espressa dichiarazione del creditore; in mancanza, si presume cumulativa con permanenza della responsabilità del debitore originario.
Fonti
- Codice Civile, articoli 1268-1276 (Delegazione, espromissione e accollo)
- Codice Civile, articolo 1180 (Adempimento del terzo)
- Codice Civile, articolo 2900 (Azione surrogatoria)
- Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 15234/2023
- Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 8976/2023
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 21456/2022
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2022
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), articoli 88 e 101