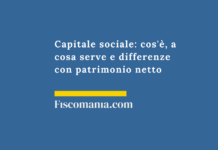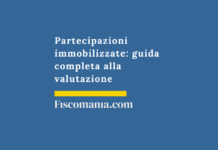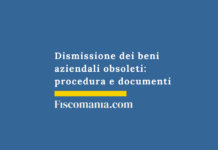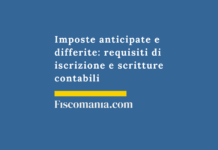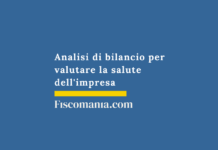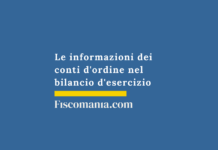Il leasing, nonostante sia richiamato da diverse disposizioni normative, costituisce una fattispecie contrattuale non regolata espressamente dal codice civile che ha avuto una rilevante espansione nel nostro ordinamento giuridico, tanto da poter essere considerato come un contratto “socialmente tipico”. Le ragioni del suo ampio utilizzo sono strettamente legate alle esigenze sempre più spesso avvertite dagli imprenditori di disporre di beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, ecc.) da utilizzare nell’ambito delle proprie attività produttive senza ricorrere all’immobilizzazione di capitali per il loro acquisto. I beni, infatti, vengono forniti da imprese finanziarie specializzate (società di leasing) mediante un contratto che presenta tratti tipici della locazione, della vendita a rate, del mutuo e del finanziamento bancario, senza però identificarsi con nessuno di questi. Il suo successo, però, non ha ancora trovato riscontro in una compiuta disciplina civilistica, nonostante abbia raggiunto sufficienti livelli di standardizzazione attraverso i contratti tipizzati predisposti dalle imprese di leasing. L’ampia diffusione del leasing, oltre che nella pratica imprenditoriale (leasing d’impresa), si è registrata anche per l’acquisto di beni di consumo durevoli, come automobili ed elettrodomestici (leasing di consumo) e di beni immobili (leasing immobiliare). Tipologie contrattuali Il leasing si articola principalmente in tre tecniche operative che presentato tratti molto differenti tra di loro:
LEASING FINANZIARIO Rappresenta la formula contrattuale più diffusa, sia in riferimento all’attività imprenditoriale per l’acquisizione di beni strumentali, sia nell’ambito di operazioni di acquisto di beni di consumo durevoli e immobiliari. Tale tipologia di leasing si sostanzia in un’operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente o locatore), il soggetto interessato all’utilizzo del bene (utilizzatore o locatario) e il produttore o il distributore del bene oggetto del contratto (fornitore). In base a questo schema contrattuale, il soggetto interessato ad utilizzare un bene, invece di rivolgersi al mercato dei capitali al fine di ottenere uno specifico finanziamento per il suo acquisto, si rivolge all’impresa di leasing affinché acquisti il bene in questione dal fornitore e glielo conceda in godimento. Il contratto che viene stipulato è caratterizzato dai seguenti aspetti:- il godimento viene concesso per un periodo di tempo determinato, che generalmente per il leasing di beni strumentali coincide con la loro vita utile;- l’utilizzatore è tenuto a corrispondere per l’intera durata del contratto un canone periodico al concedente (che in genere è più elevato di un semplice canone di locazione) a fronte del godimento del bene, assumendo su di sé i rischi del suo perimento e del suo cattivo funzionamento;- alla scadenza del contratto, all’utilizzatore viene riconosciuta la facoltà di restituire il bene, rinnovare...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso