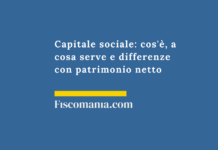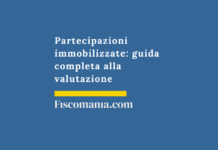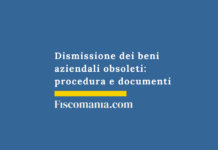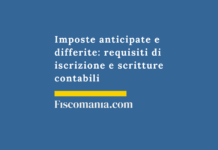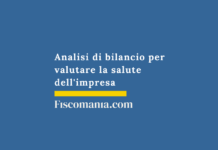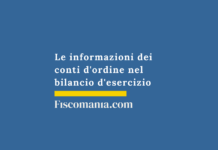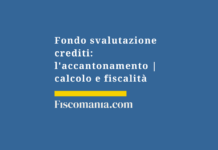Nel corso della vita di un’impresa si rende spesso necessaria l’esigenza di redigere bilanci riferiti ad archi temporali più ristretti rispetto a quelli che interessano i bilanci d’esercizio, e ciò principalmente al fine di monitorare l’andamento della gestione e di misurare il grado di coerenza delle azioni strategiche rispetto agli obiettivi di medio/lungo termine fissati dagli amministratori. Per distinguerli da quelli d’esercizio, che generalmente fanno riferimento ad un periodo di dodici mesi, vengono definiti intermedi, o anche infrannuali, e possono avere cadenze temporali differenti che variano a seconda di una serie di parametri, come la dimensione aziendale, il contesto socio-economico nel quale l’impresa opera e le esigenze informative che per il loro tramite si intendono soddisfare. Hanno in genere uno scopo informativo a contenuto interno e la loro redazione non richiede necessariamente il rispetto di tutte le formalità previste per la redazione dei bilanci d’esercizio, in quanto, rispetto a questi ultimi, differenti sono gli scopi che attraverso i medesimi si vogliono raggiungere. Per determinate circostanze, però, è il codice civile a richiamarne l’obbligatorietà, dettando i principi generali che occorre rispettare per la loro redazione. È il caso, ad esempio, di tutte le operazioni che possono avere incidenza sul capitale sociale, come quelle ne comportano la riduzione (anche nel caso di perdite) o l’aumento, o sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa, come per le emissione di un prestito obbligazionario o le operazione di fusione o scissione. Le norme del codice che regolano questi ed altri specifici casi sono interpretate ed integrate dal principio contabile OIC 30, che è stato emanato ad aprile 2006 sostituendo il precedente principio n. 30 elaborato nel 2002 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri. I Bilanci Intermedi Un bilancio intermedio, anche noto con il termine di infrannuale, è un documento contabile che espone la situazione patrimoniale ed economica riferita ad un periodo inferiore ai dodici mesi, la cui cadenza temporale può assumere configurazioni diverse a seconda delle esigenze informative, sia interne che esterne, che si tendono a soddisfare. Generalmente, l’arco di tempo a cui si riferisce abbraccia un periodo di tre o sei mesi, per cui, prima del bilancio annuale, che di regola si chiude al 31/12, possono aversi tanti bilanci intermedi a seconda del periodo di base scelto (così, se si sceglie il trimestre come periodo di riferimento si avranno quattro bilanci intermedi, mentre se si considera il semestre se ne avranno due). Data la loro funzione meramente informativa e il differente carattere temporale che presentano rispetto ai bilanci d’esercizio e consolidati, non necessariamente devono essere strutturati come questi ultimi, ovvero comporsi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, essendo possibile ricorrere a for...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso