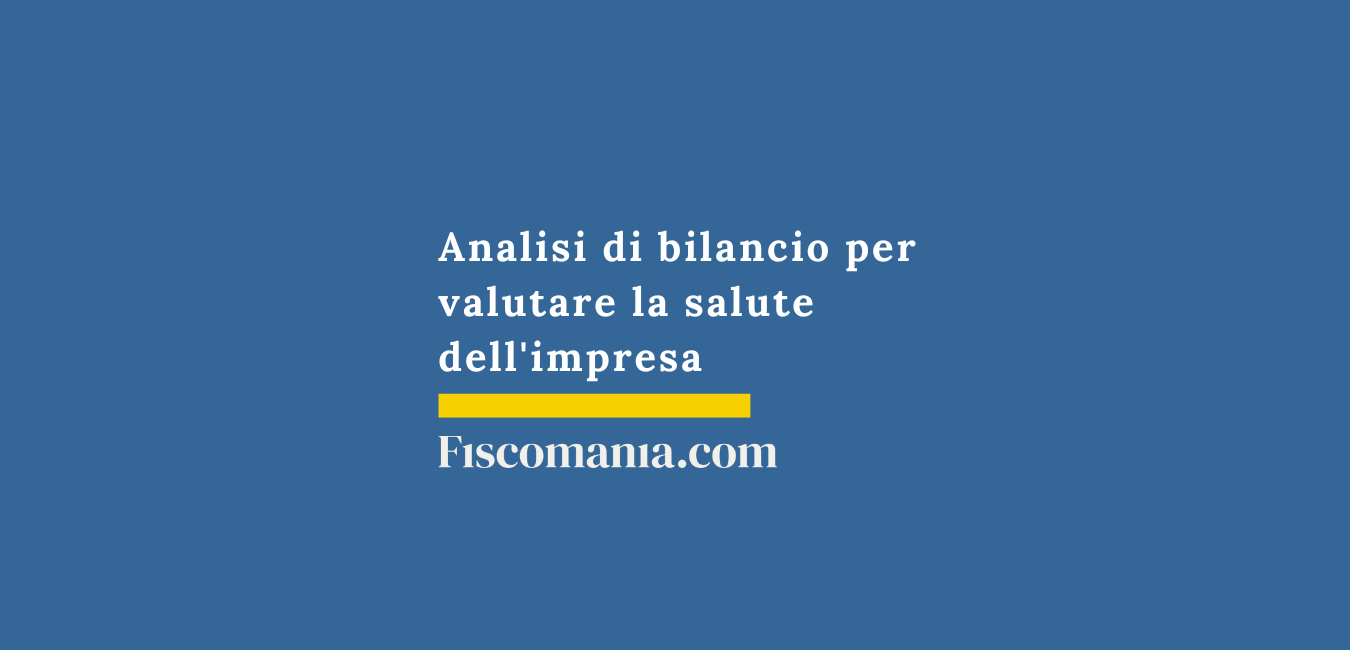Scopri come analizzare correttamente i dati di bilancio per valutare redditività, liquidità e solidità patrimoniale della tua azienda.
L’analisi di bilancio rappresenta lo strumento fondamentale per valutare la reale salute economico-finanziaria di un’impresa. Troppo spesso gli imprenditori si limitano a considerare i valori assoluti del bilancio d’esercizio, perdendo di vista la visione d’insieme necessaria per prendere decisioni strategiche informate.
Un risultato economico positivo di 100.000 euro può sembrare soddisfacente, ma se il capitale investito dai soci ammonta a 50 milioni, la redditività effettiva risulta essere appena dello 0,2% – un rendimento decisamente inadeguato rispetto alle aspettative. Questo esempio evidenzia perché l’analisi di bilancio attraverso indici e flussi finanziari sia indispensabile per una valutazione obiettiva delle performance aziendali.
Negli ultimi anni, il ricorso all’analisi di bilancio si è particolarmente intensificato a seguito del sempre più rilevante ruolo che è venuta ad assumere l’azienda nel contesto economico e sociale, e al rapido susseguirsi di crisi economiche che hanno interessato molti paesi e che ancora oggi, molto più di prima, continuano a minacciare la stabilità delle imprese. Significativa a tale riguardo è la normativa sulla crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019), che impone di effettuare attente analisi periodiche su specifici indicatori di crisi (c.d. “indici di allerta”) per verificare il sussistere delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
Valutare lo stato di salute di un’impresa dai soli dati contabili ed esprimere, sulla base di specifiche analisi, giudizi sui vari aspetti che caratterizzano la sua gestione, non permette però di delineare un quadro attendibile dell’intero complesso aziendale.
Indice degli argomenti
- I tre pilastri dell’equilibrio aziendale
- Le finalità dell’analisi di bilancio
- Le fasi della rielaborazione dei dati contabili
- Le riclassificazioni degli schemi di bilancio
- Le riclassificazioni dello Stato Patrimoniale
- Le riclassificazioni del Conto Economico
- Le riclassificazioni del rendiconto finanziario
- Analisi per margini
- Analisi per indici di bilancio
- Analisi per flussi
- Interpretazione dei risultati: oltre i numeri
- Fonti normative e riferimenti
I tre pilastri dell’equilibrio aziendale
L’analisi di bilancio mira a verificare tre equilibri fondamentali che determinano la sostenibilità dell’impresa nel tempo:
- Equilibrio economico – rappresenta la capacità dell’azienda di generare ricavi sufficienti a coprire tutti i costi della gestione, producendo un reddito adeguato per remunerare il capitale investito dai proprietari.
- Equilibrio finanziario – riguarda la capacità di fronteggiare tempestivamente le uscite monetarie derivanti dalla gestione operativa. L’obiettivo è garantire la continuità aziendale attraverso una corretta gestione della liquidità.
- Equilibrio patrimoniale – concerne il giusto bilanciamento tra capitale proprio e capitale di terzi, assicurando una struttura finanziaria solida e sostenibile nel lungo periodo.
Leggi anche:
Le finalità dell’analisi di bilancio
Il bilancio d’esercizio è una rappresentazione semplificata della dinamica dei valori patrimoniali, finanziari ed economici delle imprese determinati in riferimento ad uno specifico arco temporale (c.d. periodo o esercizio amministrativo). In base all’attuale disciplina, esso si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, e deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico (vale a dire gli utili conseguiti o le perdite subite) realizzato nel periodo considerato.
Le funzioni del bilancio sono fondamentalmente due:
- Contabile, in quanto rappresenta la sintesi numerica periodica del sistema di contabilità generale, che, come noto, si basa sulla logica del conto quale strumento atto a rilevare le dinamiche degli aspetti finanziari ed economici della gestione;
- Informativa, in quanto rappresenta non solo uno strumento puramente contabile, ma anche, e primariamente, un modello in grado di fornire informazioni sull’andamento della gestione a vantaggio di tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle sorti dell’azienda.
Tuttavia tale documento, predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile e delle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali OIC che interpretano ed integrano quanto previsto dalla legge, non sempre è in grado di fornire tutte le necessarie informazioni sulle dinamiche aziendali. Per tale ragione, esso è spesso sottoposto a specifiche analisi mediante l’utilizzo di tecniche e strumenti in grado di aumentarne la portata informativa sia sul piano quantitativo che qualitativo.
Tipologie di analisi
L’analisi di bilancio può essere eseguita per scopi informativi diversi e dipendere da molteplici variabili. A seconda dello scopo per cui viene condotta, ovvero del tipo di informazione che da essa si vuole ricavare, si è soliti distinguere tra:
- Analisi storiche: si tratta di indagini di tipo storico effettuate sui valori di bilancio al fine di poter analizzare come gli stessi siano variati nel tempo.
- Analisi statiche: sono condotte allo scopo di analizzare la struttura di un’impresa, vale a dire la sua consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica.
- Analisi di best practice: consistono in analisi sulle imprese concorrenti relativamente alla struttura dei valori economici e patrimoniali. In sostanza, mediante questo tipo di analisi, l’azienda si limita ad effettuare confronti tra i valori risultanti dai propri bilanci e quelli registrati dalle imprese concorrenti, al fine individuare e valutare le differenze emergenti.
- Analisi previsionali: mediante questa tipologia di analisi ci si pone il fine di proiettare nel tempo gli andamenti della gestione aziendale sulla base di una serie di dati raccolti sia in riferimento a periodi passati che a quelli in corso alla data in cui le analisi sono condotte, simulando i futuri scenari economici che potrebbero delinearsi.
Analisi per margini, indici e flussi
Ciascuna di queste analisi, dunque, risponde a specifiche esigenze informative e possono essere condotte mediante l’utilizzo di diverse tecniche che variano a seconda del tipo di finalità che si vuole raggiungere. Quelle più diffuse riguardano:
- L’analisi per margini, che consiste nell’effettuare delle differenze tra le poste del bilancio, sia in relazione allo Stato Patrimoniale che al Conto Economico;
- L’analisi per indici, che consiste nel trasformare i dati di bilancio in rapporti (ratios), sintetizzando così le informazioni e permettendo un confronto spaziale e temporale tra i dati;
- L’analisi per flussi: che permette di evidenziare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle fonti di finanziamento e negli impieghi al fine di valutare la capacità di un’impresa di generare liquidità e sia conseguentemente in grado di coprire il proprio fabbisogno finanziario
Da precisare che tali metodologie sono di tipo quantitativo, in quanto partono dai valori indicati nel bilancio d’esercizio e sono condotte allo scopo di integrarli e di darne un’interpretazione in una prospettiva puramente contabile. A queste poi, per un’analisi più compiuta, occorre affiancare anche metodologie di tipo qualitativo che permettano di completare le informazioni del bilancio partendo da dati e informazioni non finanziarie.
Le fasi della rielaborazione dei dati contabili
L’applicazione delle tecniche indicate passa attraverso un processo metodologico necessario per la rielaborazione dei dati contabili risultanti dal bilancio, e che deve essere generalmente scandito nelle seguenti fasi:
- Identificazione delle fonti da cui attingere le informazioni e i dati oggetto dell’analisi. Esse possono essere rappresentate non solo dai bilanci ufficiali resi pubblici mediante il deposito presso le competenti Camere di Commercio, ma anche da altri documenti interni che non hanno la stessa ufficialità di quelli depositati, quali ad esempio: i bilanci contabili di verifica e le situazioni contabili intermedie (bilanci infrannuali) elaborati ed estratti dai software gestionali utilizzati; i budget aziendali; i piani strategici ed operativi, ecc.
- Identificazione dei dati da prendere in considerazione ai fini dell’analisi ed analizzarne la struttura in relazione ai documenti dai quali vengono estratti.
- Definizione dei periodi contabili rispetto ai quali effettuare l’analisi, che generalmente abbracciano intervalli di tempo prestabiliti che possono riferirsi ad un unico periodo amministrativo (ad es.: uno, tre, sei, nove, dodici mesi) o estendersi a quelli successivi, per cui si parlerà nel primo caso di analisi periodiche e nell’altro di analisi ultrannuali.
- Definizione degli schemi di riclassificazione dei documenti di bilancio da utilizzare.
- Riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario al fine di rappresentare i dati contabili secondo modalità diverse che ne permettano una migliore comprensione ed interpretazione. La riclassificazione deve essere effettuata sulla base di specifici criteri che dipendono dal tipo di informazione che si vuole ottenere dall’analisi e dai dati disponibili.
Le riclassificazioni degli schemi di bilancio
La fase della riclassificazione degli schemi di bilancio, oltre a fornire indicazioni più dettagliate dei dati contabili consentendo una loro maggiore comprensione ed una prima interpretazione di base, è propedeutica all’applicazione delle tecniche relative all’analisi per margini, per indici e per flussi.
Gli schemi di bilancio, così come delineati dal legislatore, presentano, infatti, strutture molto rigide, articolate sulla base di criteri che non sempre soddisfano le esigenze informative dei loro destinatari. Per rendere i dati contabili più esplicativi, occorre, perciò, ricorrere ad una loro rimodulazione sulla base di specifiche regole che consentano di raggrupparli in aggregati in grado di esprimerne un significato più organico rispetto a quello che si evince dai prospetti civilistici.
Le logiche su cui si fondano le riclassificazioni non sono rigide e possono assumere conformazioni diverse a seconda delle informazioni che si vogliono trarre da un’analisi. Quelle più diffuse nella prassi contabile, sia nazionale che internazionale, si basano sui seguenti modelli:
- Finanziario e funzionale per lo Stato Patrimoniale;
- A valore aggiunto, a margine di contribuzione e a ricavi e costi del venduto per il Conto Economico.
Rispetto ad altri, pure accettati dalla dottrina contabile ed usati nella prassi, tali modelli presentano un maggiore grado di affidabilità e consentono di cogliere in modo più compiuto le informazioni che maggiormente interessano i destinatari del bilancio.
Le riclassificazioni dello Stato Patrimoniale
Lo schema di Stato Patrimoniale delineato dal legislatore all’art. 2424 cod. civ., presenta una struttura a sezioni divise e contrapposte in cui le poste di bilancio sono classificate secondo un criterio misto funzionale e finanziario, in base al quale le voci sono rappresentate principalmente avendo riguardo alla loro funzione e solo in via secondaria vengono articolate secondo un criterio finanziario. Il legislatore, pertanto, ha optato per un sistema di classificazione delle poste di bilancio prediligendone la destinazione rispetto al loro grado di liquidità, il che comporta una forte limitazione del suo potenziale informativo. Per ovviare a tale carenza, partendo dallo schema civilistico dello Stato Patrimoniale, si operano specifiche riclassificazioni dei dati principalmente sulla base dei seguenti modelli:
- Modello finanziario (criterio della liquidità/esigibilità), secondo cui le voci dell’attivo sono classificate in base al loro grado di liquidità e quelle del passivo secondo il loro livello di esigibilità. La classificazione dello Stato Patrimoniale sulla base di questo metodo è utile per valutare l’equilibrio tra gli impieghi (attività o investimenti) e le fonti (passività o finanziamenti) ed il conseguente grado di solvibilità dell’impresa. In sostanza, serve nella valutazione della capacità dell’impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (analisi della liquidità).
- Modello funzionale (criterio della pertinenza gestionale), in base al quale le poste patrimoniali devono essere aggregate a seconda della loro afferenza alle diverse aree gestionali. La riclassificazione dello Stato Patrimoniale effettuata sulla base di questo modello permette di evidenziare la natura degli investimenti effettuati (impieghi) e dei finanziamenti reperiti (fonti) e a verificarne le condizioni di equilibrio (analisi della solidità).
Le riclassificazioni del Conto Economico
L’art. 2425 cod. civ. prescrive uno schema di Conto Economico a forma espositiva scalare con evidenza di risultati intermedi in corrispondenza delle relative aree gestionali, in cui vi è una classificazione dei costi in ragione della loro natura, ovvero sulla base delle cause economiche che li hanno generati. Nonostante possa sembrare molto analitico nella sua composizione, lo schema civilistico tuttavia non consente un’analisi esaustiva della redditività aziendale, in quanto l’indicazione delle classi di costo e ricavo sono spesso sintetiche e l’unico criterio utilizzato per la classificazione dei componenti reddituali è quello basato sulla loro natura e non sulla destinazione, in base cioè alle aree funzionali dell’azienda.
Un’analisi sulla redditività deve evidenziare il contributo offerto da ciascuna gestione alla formazione del risultato d’esercizio, cosa che non permette di fare, almeno a prima vista, lo schema civilistico. Per cui, vista l’importanza che riveste tale informazione per i destinatari del bilancio, compresi gli amministratori che sulla base delle proprie risultanze possono valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, si rende necessario riclassificare il Conto Economico in modo da giungere alla determinazione di una struttura che possa permettere di evidenziare le aggregazioni delle voci, i margini ottenuti e i risultati intermedi realizzati al fine di comprendere la progressiva formazione del risultato economico.
Tra i modelli più utilizzati, si segnalano i seguenti.
Modello di conto economico a valore aggiunto
Nel modello di conto economico a valore aggiunto i costi sono riclassificati per natura e suddivisi tra costi interni ed esterni all’azienda. Tale schema di riclassificazione riflette quello del codice civile, presentando la tipica struttura scalare che giunge alla determinazione del risultato d’esercizio passando attraverso diversi risultati intermedi. Mediante questo modello deve essere evidenziata la capacità dell’impresa di incrementare il valore dei fattori produttivi attraverso i processi aziendali.
Il valore aggiunto, infatti, è l’indicatore che esprime la capacità dell’impresa di produrre reddito in misura tale da riuscire a remunerare tutti i fattori produttivi impiegati. Rispetto agli altri è di più semplice applicazione in quanto si fonda sostanzialmente sui dati dello schema civilistico non richiedendone in aggiunta altri ai fini dell’analisi, per cui può essere utilizzato da ogni tipologia di impresa ed essere applicato anche da soggetti esterni alla stessa (è infatti molto diffuso tra gli istituti di credito per l’analisi di molte istanze di finanziamento presentate dalle imprese).
Modello di conto economico a margine di contribuzione
Il modello di riclassificazione a margine di contribuzione si differenzia in quanto deve essere operata la distinzione tra costi fissi e variabili portando ad evidenza il relativo margine di contribuzione. Questo modello generalmente deve essere utilizzato nelle imprese quando devono valutare se effettuare la produzione internamente oppure procedere ad esternalizzarla, in quanto, applicato a gruppi di prodotti, può riflettere l’apporto di ogni articolo prodotto alla copertura dei costi fissi.
Modello di conto economico a ricavi e costi del venduto
Secondo il modello di riclassificazione a costi e ricavi del venduto, i costi sono distinti per aree funzionali consentendo di misurare quanto ciascuno di essi pesa sui costi totali. I costi sono pertanto riclassificati per destinazione, contrariamente allo schema civilistico, in modo da essere collegati alle diverse aree gestionali. In genere, deve essere utilizzato dalle imprese industriali, mentre ha una diffusione minore nei casi di analisi di bilancio effettuate da imprese di servizi e commerciali.
Le riclassificazioni del rendiconto finanziario
Anche il Rendiconto Finanziario può essere oggetto di riclassificazione, sebbene il ricorso a questo tipo di analisi è molto meno frequente nella pratica contabile. Generalmente viene utilizzato da grandi complessi aziendali al fine di avere un maggior grado dettaglio sulla propria situazione finanziaria. In verità, anche in questi casi non si può parlare di una vera e propria riclassificazione, in quanto, normalmente, le imprese si limitano ad elaborare un nuovo Rendiconto, e non a riclassificarlo, partendo da grandezze diverse (ad esempio, dal margine operativo lordo e non dall’utile netto) e avendo come riferimento risorse finanziarie differenti rispetto alla liquidità (ad esempio, la posizione finanziaria netta).
Analisi per margini
L’analisi per margini, così come quella per indici e flussi, viene effettuata dopo aver proceduto a riclassificare gli schemi di bilancio secondo i criteri analizzati in precedenza, e consiste nel confrontare le voci patrimoniali al fine di valutare la loro incidenza rispetto alla composizione delle attività, delle passività e del capitale netto.
L’analisi viene condotta principalmente partendo dai dati risultanti dallo schema di Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, da cui vengono estratte le grandezze per valutare l’equilibrio patrimoniale e finanziario nonché il grado di solidità delle imprese.
Le principali grandezze oggetto di analisi sono sintetizzate negli schemi seguenti:
Margini di liquidità e di solvibilità
| Margine di disponibilità (o Capitale circolante netto) |
| ATTIVO CORRENTE – PASSIVO CORRENTE |
| Indica la capacità dell’azienda di far fronte alla passività di breve periodo mediante il ricorso alla liquidità e alle disponibilità di magazzino. |
| Margine di tesoreria |
| LIQUIDITA’ IMMEDIATE + LIQUIDITA’ DIFFERITE – PASSIVITA’ CORRENTI |
| Indica il grado di solvibilità dell’azienda in quanto opera il raffronto tra gli impieghi liquidabili e le fonti esigibili nel breve periodo |
Margini di solidità
| Margine primario di struttura |
| CAPITALE NETTO – IMMOBILIZZAZIONI NETTE |
| Evidenzia la capacità dell’azienda di finanziare con mezzi propri le immobilizzazioni nette (vale a dire le immobilizzazioni al netto dei rispettivi fondi di ammortamento). |
| Margine secondario di struttura |
| (CAPITALE NETTO + PASSIVITA’ CONSOLIDATE) – ATTIVO IMMOBILIZZATO |
| Permette di esaminare la solidità dell’impresa attraverso la sua capacità di coprire gli investimenti fissi (attivo immobilizzato) con fonti di capitale permanenti rappresentate dal capitale proprio e dalle passività a medio/lungo termine. |
Analisi per indici di bilancio
L’analisi per indici viene effettuata mediante rapporti (anche detti quozienti o ratios) tra le diverse voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i criteri analizzati in precedenza, e presenta il vantaggio di sintetizzare le informazioni contabili trasformando i dati espressi in valori numerici assoluti, che sono utili ai fini dell’analisi per margini, in valori numerici relativi, in modo da consentire confronti sia con dati riferiti a bilanci precedenti della stessa azienda (confronti intertemporali), sia con dati di altre aziende (confronti di settore, o best practice). Rispetto ai margini, gli indici permettono di avere un’interpretazione dei valori di bilancio più agevolata, nonché di evidenziare con immediatezza le principali grandezze utili a valutare il grado di solidità, di liquidità e di redditività dell’azienda.
I principali indici utilizzati ai fini di un’analisi aziendale sono sintetizzati negli schemi seguenti:
Indici di solidità
L’analisi sulla solidità ha lo scopo di valutare la capacità dell’azienda di adattarsi alle mutevoli condizioni interne ed esterne e perdurare nel tempo, testando quanto la propria struttura finanziaria e patrimoniale sia elastica (flessibile) rispetto al verificarsi di determinati eventi.
Gli indici che vengono utilizzati a tal fine sono i seguenti:
| Indice di elasticità dell’attivo |
| ATTIVITA’ CORRENTI / ATTIVITA’ TOTALI |
| Indice di rigidità dell’attivo |
| ATTIVITA’ FISSE / ATTIVITA’ TOTALI |
| Indice di elasticità del passivo |
| PASSIVITA’ CORRENTI / PASSIVITA’ TOTALI |
| Indice di rigidità del passivo |
| (PASSIVITA’ CONSOLIDATE + PATRIMONIO NETTO) / PASSIVITA’ TOTALI |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio |
| PATRIMONIO NETTO / ATTIVO IMMOBILIZZATO |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli |
| (PATRIMONIO NETTO + PASSIVITA’ CONSOLIDATE)/ ATTIVO IMMOBILIZZATO |
| Indice del grado di indipendenza dai terzi |
| PATRIMONIO NETTO / (PASSIVITA’ CONSOLIDATE + PASSIVITA’ CORRENTI) |
Indici di liquidità
L’analisi della liquidità si pone come obiettivo la valutazione della capacità dell’azienda di fa fronte tempestivamente agli impegni assunti, ovvero verificare se è in grado di coprire i propri debiti mediante l’impiego delle attività a sua disposizione.
Gli indici che vengono utilizzati a tal fine sono i seguenti:
| Indice di liquidità primaria |
| (LIQUIDITA’ IMMEDIATE + LIQUIDITA’ DIFFERITE) / PASSIVO CORRENTE |
| Indice di liquidità secondaria |
| ATTIVO CORRENTE / PASSIVO CORRENTE |
| Indice di rotazione del magazzino |
| COSTO DEL VENDUTO / GIACENZE MEDIE |
| Indice di durata media dei crediti commerciali |
| (CREDITI COMMERCIALI x 360) / (VENDITE + IVA) |
| Indice di durata media dei debiti commerciali |
| (DEBITI COMMERCIALI x 360) / (ACQUISTI + IVA) |
Indici di redditività
L’analisi della redditività mira a testare la capacità dell’azienda a remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi, ovvero il capitale investito, quindi se è in grado o meno di generare valore e produrre reddito.
Gli indici che vengono utilizzati a tal fine sono i seguenti:
| R.O.E. (Return On Equity)– Redditività del capitale proprio – |
| REDDITO NETTO / CAPITALE NETTO |
| R.O.I. (Return On Investment)– Redditività del capitale investito – |
| REDDITO NETTO / CAPITALE INVESTITO |
| R.O.S. (Return On Sale) – Redditività delle vendite – |
| REDDITO OPERATIVO / VENDITE |
Analisi per flussi
L’analisi per flussi viene condotta al fine di misurare l’equilibrio finanziario di un’impresa, attraverso tecniche che permettono di esaminare la gestione aziendale da un punto di vista dinamico, evidenziando il fabbisogno finanziario e le fonti necessarie per la sua copertura. Rispetto a quelle per margini e per indici, l’analisi per flussi fornisce informazioni ulteriori in quanto mira a capire quali sono le cause che hanno determinato variazioni nelle grandezze che vengono osservate in relazione ad un determinato periodo di tempo.
Quando si parla di “flussi” ci si riferisce ai movimenti che subiscono le poste patrimoniali, anche definite “fondi” per designare tutti quegli elementi che sono presenti nel patrimonio aziendale in un dato istante, che generalmente coincide con la data di riferimento del bilancio, ovvero la fine dell’esercizio. I flussi, quindi, indicano le variazioni subite dai fondi in un determinato arco temporale, mentre i fondi rappresentano le grandezze che vengono osservate, che generalmente sono costituite dal capitale circolante netto (vale a dire la differenza tra le attività e le passività correnti) e dalla liquidità (cash flow).
Il rendiconto finanziario
L’analisi per flussi viene condotta attraverso la redazione del Rendiconto Finanziario, che, a partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 139/15 (che ha recepito la Direttiva 2013/31/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati), costituisce uno dei documenti di cui, ai sensi dell’art. 2423, cod. civ., si compone il bilancio d’esercizio.
La sua utilità, al fine di analizzare la misura dell’equilibrio finanziario di un’azienda, la si coglie guardando ai limiti strutturali dello Stato Patrimoniale, che mette in evidenza il valore dei singoli elementi patrimoniali riferiti ad un dato istante (rappresentato dal termine dell’esercizio amministrativo), assumendo, quindi, un contenuto statico, rappresentando una sorta di strumento fotografico della gestione in quanto ne esprime una configurazione istantanea. Se, ad esempio, prendiamo in considerazione la voce “denaro in cassa” presente tra le disponibilità liquide, dallo Stato Patrimoniale si evince il suo valore alla data di chiusura dell’esercizio.
E questa è l’unica informazione che si ricava dal bilancio; un’informazione statica perché, appunto, si riferisce ad un dato istante. Se si vuole ampliare la conoscenza su questo dato, occorre fare ulteriori indagini. Ad esempio, se si vuole conoscere di quanto la liquidità disponibile in cassa sia variata rispetto al precedente esercizio, basta confrontare i due Stati Patrimoniali, cioè quello rispetto al quale si sta analizzando la voce “denaro in cassa” e quello del periodo precedente (tale informazione è già desumibile dal bilancio civilistico in quanto i dati sono riportati su due colonne, di cui una riferita al bilancio in chiusura e l’altra a quello chiuso nel precedente esercizio).
Informazioni in nota integrativa
Questo confronto dice, però, di quanto sia variata la grandezza patrimoniale da un periodo all’altro, ma non evidenzia le cause che hanno determinato tale variazione. È pure vero che alcune informazioni sulle variazioni subite dagli elementi patrimoniali sono riportate nella Nota Integrativa, ma è altrettanto vero che spesso sono molto sintetiche e limitate solo a taluni aspetti. Per tale ragione si rende necessaria la redazione di un altro specifico documento che permetta di avere ulteriori informazioni sulle poste dello Stato Patrimoniale, e dunque sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda. Tale documento è il Rendiconto Finanziario, previsto dall’art. 2425-ter, cod. civ., e dal principio contabile nazionale OIC 10, che fornisce indicazioni operative sulla sua redazione.
Interpretazione dei risultati: oltre i numeri
L’interpretazione degli indici richiede esperienza e attenzione al contesto aziendale. Un indice di liquidità elevato può sembrare positivo, ma potrebbe nascondere un eccesso di capitale improduttivo o difficoltà nel ciclo di incasso crediti.
La comparazione temporale degli indici rivela le tendenze aziendali, mentre il confronto settoriale permette di valutare la posizione competitiva rispetto ai concorrenti.
Limiti dell’analisi di bilancio
È indubbio che, se si vuole testare la capacità di un’azienda a perdurare nel tempo, garantendo l’equilibrio gestionale sul piano finanziario, patrimoniale ed economico, il ricorso all’analisi di bilancio diventa una necessità, in quanto, come visto, i dati contabili risultanti dagli schemi civilistici di Stato Patrimoniale e di Conto Economico offrono a tal fine informazioni non sufficienti. È anche vero, però, che ciascuno dei modelli analizzati fornisce informazioni circoscritte alle grandezze che si prendono in esame e ai dati contabili disponibili.
Dati che, per loro natura, sono quantitativi ed esprimono in valore monetario le dinamiche finanziarie, patrimoniali ed economiche illustrate dal bilancio ed indagate mediante l’utilizzo di specifici strumenti di analisi. Tutte le informazioni che restano fuori da tale ambito non vengono considerare, con il rischio di interpretare in modo non corretto gli andamenti della gestione. Valutare lo stato di salute di un’impresa dai soli dati contabili ed esprimere, sulla base di specifiche analisi, giudizi sui vari aspetti che caratterizzano la sua gestione, non permette di delineare un quadro attendibile dell’intero complesso aziendale. Sarà necessario affiancare all’analisi quantitativa condotta sul bilancio d’esercizio anche altri strumenti che indaghino su aspetti qualitativi, molti dei quali possono emergere da un’attenta analisi delle informazioni riportate nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione.
Questa circostanza costituisce un problema soprattutto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis, cod. civ.) e per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma semplificata (art. 2435-ter, cod. civ.), in quanto molte informazioni potrebbero essere nascoste viste le semplificazioni sulla redazione dei bilanci concesse dalla legge per queste imprese, o addirittura non rese pubbliche stante l’esonero dalla redazione della Nota Integrativa che il codice civile prevede, a determinate condizioni, per le micro-imprese. In tali casi, condurre un’analisi di bilancio potrebbe essere particolarmente arduo.
Fonti normative e riferimenti
- Codice Civile, artt. 2423-2435 (Bilancio d’esercizio)
- D.Lgs. 139/2015 (Riforma della disciplina del bilancio)
- Principi Contabili Nazionali OIC
- Raccomandazioni CONSOB per la redazione delle relazioni finanziarie
Leggi anche: