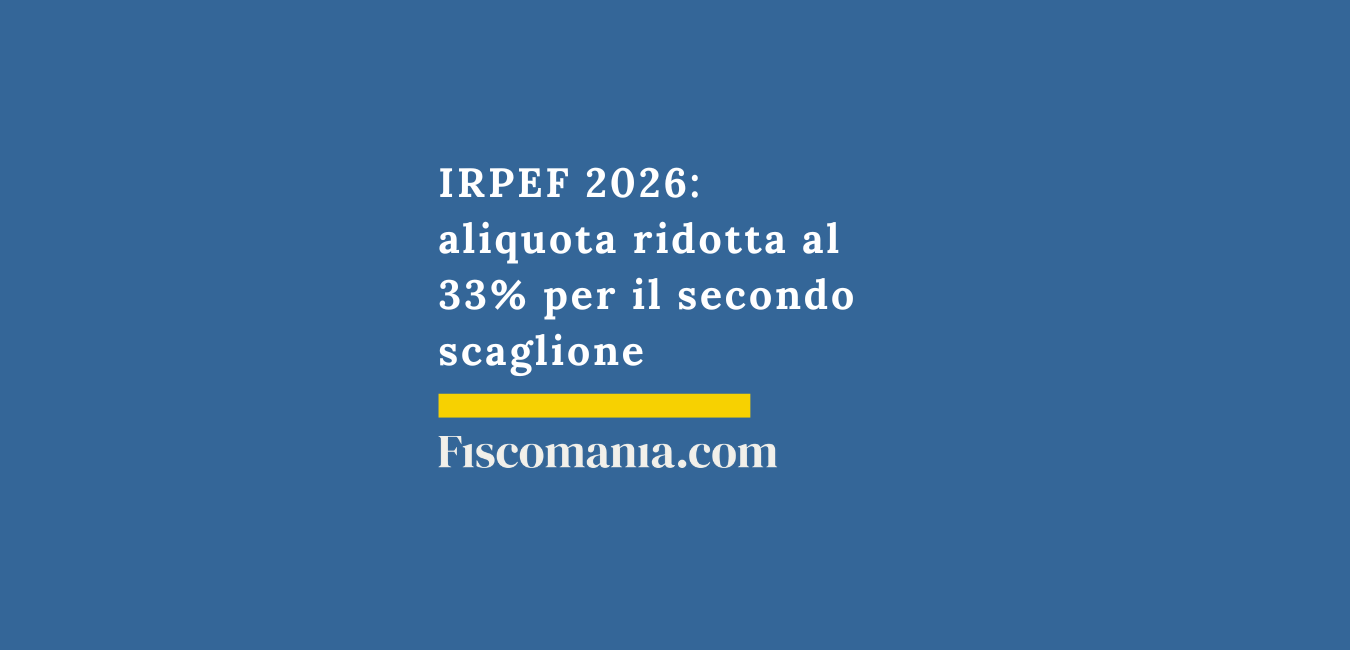Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 riduce dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione IRPEF. Risparmio massimo 440 euro, ma il meccanismo di sterilizzazione per i redditi oltre 200.000 euro aumenta la complessità del sistema fiscale.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 ottobre 2025 il Disegno di Legge di Bilancio 2026 che introduce la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per il secondo scaglione di reddito (28.000-50.000 euro). La misura, con uno stanziamento di 2,8 miliardi di euro annui, promette risparmi fino a 440 euro per circa 9 milioni di contribuenti, ma introduce nuovi meccanismi di sterilizzazione che complicano ulteriormente un sistema già definito “un rebus” dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio.
Il taglio dell’aliquota intermedia rappresenta il terzo intervento strutturale sull’IRPEF in tre anni, dopo l’accorpamento dei primi due scaglioni operato dal Decreto Legislativo n. 216/23 e la conferma della struttura a tre aliquote con la Legge di Bilancio 2025. Ma questa volta, accanto alla riduzione fiscale, arriva un sistema di neutralizzazione dei benefici per i redditi elevati che aggiunge un ulteriore livello di complessità al calcolo dell’imposta.
Indice degli argomenti
- Soggetti beneficiari della riduzione dell’aliquota IRPEF
- Esempi di risparmio
- Il meccanismo di neutralizzazione: quando il risparmio scompare
- La stratificazione delle limitazioni alle detrazioni
- Le criticità operative: dalle ritenute ai modelli dichiarativi
- Le prospettive: iter parlamentare e possibili modifiche
- La questione della semplificazione tradita
Soggetti beneficiari della riduzione dell’aliquota IRPEF
La modifica dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del TUIR porta la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF a regime dal periodo d’imposta 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Il risparmio teorico massimo è pari a 440 euro annui (2% su 22.000 euro, l’ampiezza del secondo scaglione), che si applica integralmente a tutti i contribuenti con reddito complessivo tra 50.000 e 200.000 euro.
Per chi si colloca nella fascia intermedia, il beneficio è proporzionale alla parte di reddito che ricade nel secondo scaglione. Un contribuente con 30.000 euro di reddito risparmia circa 40 euro annui (solo 2.000 euro ricadono nel secondo scaglione), mentre chi dichiara 40.000 euro ottiene un risparmio di circa 240 euro. Il vantaggio massimo si materializza per tutti i redditi superiori a 50.000 euro, almeno fino alla soglia critica dei 200.000 euro.
La platea coinvolta è ampia: si stima che oltre 9 milioni di contribuenti beneficeranno della riduzione, prevalentemente lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati del cosiddetto ceto medio. I sostituti d’imposta dovranno applicare la nuova aliquota già nelle ritenute sulle retribuzioni di gennaio 2026, anche se gli adeguamenti informatici potrebbero richiedere qualche mese per diventare pienamente operativi.
Esempi di risparmio
Di seguito alcuni scenari semplificati a parità di imponibile IRPEF e senza considerare addizionali o altre variabili, utili per stimare l’ordine di grandezza degli effetti.
| Reddito imponibile | Quota nel 2° scaglione (28k–50k) | Riduzione aliquota | Risparmio annuo stimato |
|---|---|---|---|
| 30.000 euro | 2.000 euro | 2% | 40 euro |
| 40.000 euro | 12.000 euro | 2% | 240 euro |
| 50.000 euro | 22.000 euro | 2% | 440 euro |
| 60.000 euro | 22.000 euro | 2% | 440 euro |
| 210.000 euro | 22.000 euro | 2 | 440 euro; possibile neutralizzazione fino a 440 euro via riduzione detrazioni per oneri spettanti |
Gli esempi illustrano che il vantaggio cresce linearmente all’interno del secondo scaglione e si stabilizza a 440 euro oltre 50.000 euro, fatti salvi gli effetti della neutralizzazione oltre 200.000 euro se sono presenti oneri detraibili interessati. Nei casi senza oneri detraibili nelle categorie coinvolte, la neutralizzazione potrebbe non operare integralmente, poiché la riduzione si applica alle detrazioni effettivamente spettanti fino a concorrenza. Viceversa, in presenza di detrazioni capienti tra quelle oggetto di riduzione, l’effetto di 440 euro può essere azzerato, neutralizzando di fatto il beneficio dell’aliquota più bassa per i redditi oltre 200.000 euro.
Il meccanismo di neutralizzazione: quando il risparmio scompare
La vera novità tecnica del DDL Bilancio 2026 sta nell’introduzione del nuovo comma 5-bis all’articolo 16-ter del TUIR, che prevede un meccanismo di sterilizzazione integrale del beneficio fiscale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Il sistema replica quanto già sperimentato nel 2024 con l’accorpamento dei primi due scaglioni, ma con parametri diversi.
Per i redditi oltre la soglia dei 200.000 euro, l’ammontare delle detrazioni d’imposta viene ridotto di 440 euro, esattamente l’importo del risparmio derivante dalla riduzione dell’aliquota. La riduzione si applica alle detrazioni per oneri detraibili al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali ai partiti politici (26%) e ai premi assicurativi per eventi calamitosi (90%).
Il meccanismo opera in modo sequenziale: prima si applicano le altre riduzioni delle detrazioni già previste dalla normativa vigente, poi si sottrae l’importo forfettario di 440 euro. Un contribuente con reddito di 201.000 euro tornerà quindi a pagare esattamente la stessa IRPEF lorda che avrebbe pagato con le aliquote 2025, perdendo completamente il beneficio della riduzione.
La stratificazione delle limitazioni alle detrazioni
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha già segnalato durante i lavori sulla Manovra 2025 che “la complessa interazione tra le diverse componenti del calcolo rende oggettivamente difficile per il contribuente avere una chiara percezione dell’importo da ricevere o versare“. Con il DDL Bilancio 2026, la situazione peggiora ulteriormente.
Dal periodo d’imposta 2026, i professionisti dovranno gestire contemporaneamente tre distinti meccanismi di limitazione delle detrazioni:
Primo livello – Redditi oltre 120.000 euro: Il comma 3-bis dell’articolo 15 del TUIR prevede che le detrazioni per oneri (escluse spese sanitarie e interessi passivi su mutui) non spettino se il reddito supera 240.000 euro. Per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, le detrazioni si riducono progressivamente secondo la formula: detrazione × [(240.000 – reddito) / 120.000].
Secondo livello – Redditi oltre 75.000 euro: L’articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, fissa un ammontare massimo complessivo di detrazioni parametrato al numero di figli a carico. Il tetto base è di 4.000 euro per chi non ha figli, aumenta a 8.000 euro con un figlio, 12.000 euro con due figli e così via. Le spese sanitarie sono escluse da questo limite.
Terzo livello – Redditi oltre 200.000 euro: Il nuovo comma 5-bis sottrae ulteriori 440 euro dall’ammontare delle detrazioni già rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
Questa stratificazione rende il calcolo dell’IRPEF un esercizio di complessità crescente.
Le criticità operative: dalle ritenute ai modelli dichiarativi
L’applicazione della nuova aliquota presenta diverse implicazioni operative per i sostituti d’imposta. Gli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, che regolano le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, vengono modificati con efficacia dal 1° gennaio 2026. A partire da quella data, tali disposizioni saranno sostituite dagli articoli 33 e 34 del Decreto Legislativo n. 33/2025, il Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
I datori di lavoro dovranno aggiornare i software di elaborazione paghe per applicare correttamente la nuova aliquota del 33% già nelle buste paga di gennaio 2026. Tuttavia, considerati i tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, è probabile che l’applicazione effettiva diventi operativa nei mesi successivi, con conguagli retroattivi sulle mensilità precedenti del 2026.
Sul fronte dichiarativo, l’impatto sarà visibile nei modelli 730/2027 e REDDITI Persone Fisiche 2027, relativi al periodo d’imposta 2026. La compilazione richiederà particolare attenzione nella gestione delle detrazioni per oneri, dove i contribuenti con redditi elevati dovranno verificare l’applicazione sequenziale di tutti i meccanismi di limitazione.
Le prospettive: iter parlamentare e possibili modifiche
Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 è stato presentato al Senato e dovrà completare l’iter parlamentare entro il 31 dicembre 2025 per evitare l’esercizio provvisorio. Durante la discussione parlamentare, potrebbero emergere modifiche significative sia sulla struttura degli scaglioni che sui meccanismi di sterilizzazione.
Nelle settimane precedenti all’approvazione del DDL, si era ipotizzato un allargamento dello scaglione intermedio fino a 60.000 euro, soluzione che avrebbe richiesto uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro invece dei 2,8 miliardi previsti. L’ipotesi è stata accantonata per vincoli di bilancio, ma potrebbe riemergere durante l’iter parlamentare qualora si trovassero spazi finanziari aggiuntivi.
La manovra si inserisce in un contesto di rigore fiscale imposto dalle nuove regole europee di governance economica. Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica prevede un percorso di rientro del deficit entro i parametri UE, con un intervento complessivo di circa 18 miliardi medi annui. Le risorse per il taglio IRPEF derivano da rimodulazioni di spesa e interventi sul lato entrate, senza incremento del disavanzo pubblico.
La questione della semplificazione tradita
Il paradosso della riforma IRPEF 2026 sta nel contrasto tra l’obiettivo dichiarato di semplificazione e la realtà di un sistema sempre più articolato. La riduzione da quattro a tre scaglioni, operata nel 2024, aveva l’ambizione di rendere più lineare e comprensibile il prelievo fiscale. L’introduzione di meccanismi di sterilizzazione differenziati per fasce di reddito va esattamente nella direzione opposta.
Il cumulo di regole stratificate negli ultimi tre anni crea incertezza applicativa per i professionisti e scarsa percezione dell’onere fiscale effettivo per i contribuenti. Un sistema fiscale efficiente dovrebbe garantire trasparenza e prevedibilità del carico tributario, caratteristiche sempre più difficili da riconoscere nell’attuale architettura dell’IRPEF.
La scelta di finanziare la riduzione dell’aliquota attraverso tagli alle detrazioni per i redditi elevati risponde a esigenze di sostenibilità finanziaria e progressività del prelievo, ma genera un sistema di calcolo a cascata che moltiplica le variabili da considerare. Per i professionisti fiscali, ogni dichiarazione diventa un esercizio di coordinamento tra norme sovrapposte, con margini di errore che crescono proporzionalmente alla complessità.