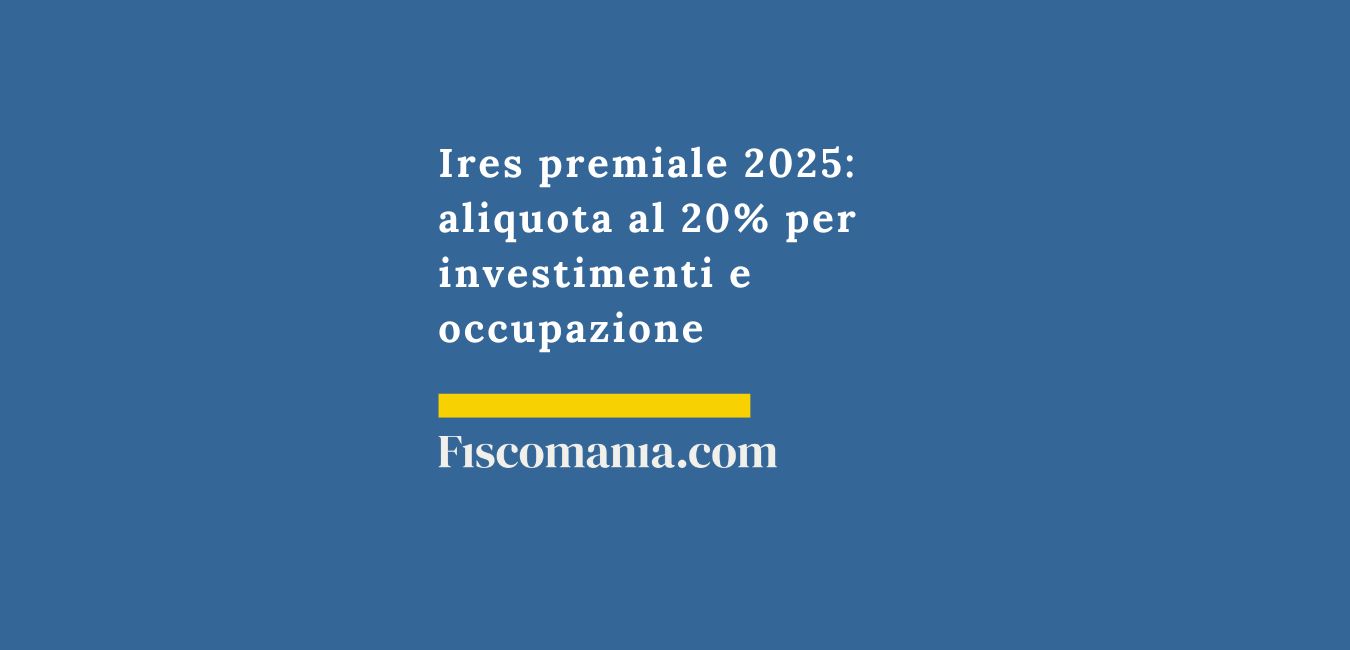IRES premiale 2025: aliquota ridotta al 20%, coordinamento CFC, investimenti sostitutivi e clausole salvaguardia. Decreto Ministeriale dell’8 agosto, chiarisce l’applicazione.
È arrivato il via libera definitivo dell’IRES premiale (mini IRES), il decreto attuativo è stato firmato dal ministero dell’Economia e delle Finanze. È una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 436 ss) per incentivare gli investimenti e l’occupazione e prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le aziende. L’aliquota IRES ridotta è quella legata alla dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al 2025, ad oggi prevista solo per quest’anno). L’obiettivo è quello di premiare chi investe in capitale umano e in capitale fisico qualificato.
Indice degli argomenti
Cos’è l’IRES premiale?
L’IRES premiale consiste nella temporanea riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% al verificarsi di determinati requisiti. Premia le imprese che patrimonializzano gli utili, realizzano investimenti qualificati e incrementano l’occupazione, senza il ricorso ad ammortizzatori sociali.
E’ un intervento sperimentale, volto a stimolare le imprese a investire nell’acquisto di nuovi macchinari, impianti e tecnologie innovative, in nuove assunzioni, in ricerca, sviluppo e innovazione di prodotto e processo, in sostenibilità ambientale, per aiutare le aziende a diventare più “green” e ridurre il loro impatto sull’ambiente.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiarne società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti esteri. E’ rivolta anche agli enti non commerciali, ma solo sul reddito d’impresa derivante da attività commerciale (con obbligo di contabilità separata).
Sono esclusi i soggetti in liquidazione o in procedure concorsuali liquidatorie, le società non operative, quelle in regimi forfetari speciali (tonnage tax, reddito agrario, ecc.) e alcune altre casistiche particolari.
Requisiti
Per poterne beneficiare l’impresa non deve aver utilizzato la cassa integrazione nel biennio 2024-2025, tranne che per la causale prevista dall’articolo 11, lettera a), del D.Lgs. n. 148/15, ovvero in presenza di situazioni dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Stabilità del personale e nuove assunzioni
L’azienda deve dimostrare una stabilità del personale, con un livello di occupazione nel 2025 pari o superiore alla media del triennio 2022-2024.
Occorre che nel 2025 l’impresa assuma nuovi dipendenti o stabilizzi i contratti esistenti, incrementando almeno dell’1% il personale rispetto al 2024 (ex art. 4 del D.Lgs. n. 216/23, legato alla super deduzione del 120% per nuove assunzioni, valida fino al 2027) e comunque pari ad almeno una unità. Questo obbligo garantisce che le aziende mantengano il loro impegno verso i lavoratori, fornendo stabilità al mercato del lavoro e incentivando politiche di crescita interna. Tale incremento può avvenire attraverso nuove assunzioni o stabilizzazioni contrattuali.
In pratica, per questo requisito occorre confrontare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato a fine 2025 con la media del 2024 e che il calcolo va fatto considerando anche i decrementi delle altre società italiane del gruppo.
Per l’esercizio 2024 l’utile deve essere accantonato, per almeno l’80% del suo importo, ad apposita riserva (intestata alla norma agevolativa). Pertanto, l’agevolazione esclude le società che chiudono con un risultato negativo, almeno questo è quello che appare dalla lettura della relazione tecnica che ha preso a riferimento i soli bilanci delle società in utile.
Investimenti con caratteristiche 4.0 e 5.0
L’azienda, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025), deve aver effettuato investimenti, presso strutture ubicate in Italia, in beni materiali ed immateriali con caratteristiche 4.0 e 5.0.
Questi investimenti favoriscono l’adozione di tecnologie innovative e migliorano la competitività sul mercato globale. In particolare, le imprese devono effettuare investimenti per un importo pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2024 (ovvero il 30% dell’80%, il minimo accantonato a riserva) e il 24% dell’utile del 2023. Al momento non vi sono chiarimenti utili per capire gli effetti per le imprese che hanno chiuso il 2023 in perdita.
Incentivi cumulabili
L’IRES premiale può essere cumulato con altri incentivi previsti dai programmi dell’Unione europea e con il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) del Mezzogiorno.
La somma dei benefici non può superare il 100% del costo dell’investimento agevolato. Non è cumulabile, invece, con il credito d’imposta Industria 4.0.
Implicazioni per la fiscalità internazionale
Il decreto affronta anche il coordinamento con altre norme di fiscalità internazionale, come il credito per imposte estere e le regole per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Per queste ultime si applica una logica simile alla branch exemption, considerando distribuzioni le riduzioni del fondo di dotazione dovute ad attribuzioni alla casa madre secondo i criteri OCSE.
Coordinamento con la disciplina CFC
Il Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025 ha chiarito che l’aliquota ridotta non rileva per il calcolo della tassazione virtuale domestica nelle verifiche CFC (Controlled Foreign Companies). Il dubbio normativo nasceva dalla regola “all-in” dell’IRES premiale: una volta verificate le condizioni, l’aliquota del 20% si applica all’intero reddito 2025, quindi anche i redditi delle controllate estere, se “realizzati” in Italia, avrebbero scontato questa aliquota ridotta.
La soluzione adottata esclude tale riduzione dal test ETR (Effective Tax Rate), considerandola irrilevante per il confronto tra imposizione virtuale domestica e tassazione effettiva estera previsto dall’articolo 167 del TUIR. La scelta si giustifica con la natura agevolativa e la mancata stabilità della misura, soggetta a obblighi di recapture che la rendono assimilabile a variazioni non permanenti dal riversamento incerto.
La stessa regola di irrilevanza si estende al test della tassazione nominale (art. 47-bis TUIR) per determinare la natura “black list” degli utili provenienti da soggetti non controllati. Per i redditi imputati per trasparenza secondo la disciplina CFC, invece, continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria del 24% senza possibilità di fruire della riduzione premiale.
Requisiti tecnici per investimenti 5.0
Gli investimenti in tecnologie 5.0 devono garantire una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi specifici interessati. La verifica avviene confrontando l’esercizio successivo all’entrata in funzione con il periodo d’imposta 2024. L’interconnessione deve permanere per più della metà del quinquennio di sorveglianza.
Gestione delle perdite fiscali
Per le società con perdite pregresse, il decreto introduce una deroga all’obbligo di compensazione automatica. Le aziende possono scegliere di non utilizzare le perdite precedenti, facendo emergere un reddito da tassare all’aliquota ridotta del 20%. Nel consolidato fiscale, le perdite delle diverse società vengono compensate prioritariamente con i redditi non agevolati.
Investimenti sostitutivi e clausola di salvaguardia
Il decreto ha introdotto una clausola di salvaguardia assente nella norma primaria: la dismissione di beni nel quinquennio di sorveglianza non comporta decadenza dall’agevolazione se vengono effettuati investimenti sostitutivi con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (4.0 o 5.0). Per mantenere il beneficio, i beni devono rimanere interconnessi per almeno metà del periodo di sorveglianza.
Regole di decadenza e delocalizzazione
Due situazioni determinano il recapture completo dell’agevolazione: la distribuzione dell’80% degli utili accantonati nel biennio successivo e la vendita o delocalizzazione degli investimenti nel quinquennio. Per la delocalizzazione, il decreto stabilisce che i beni si considerano destinati stabilmente all’estero se utilizzati oltrefrontiera per più di 183 giorni in almeno un esercizio del periodo di controllo.