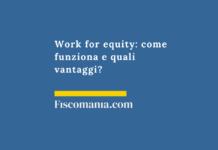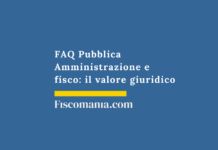Il contratto telematico rappresenta una nuova figura contrattuale, tipica delle transazioni on-line. L'oggetto di questa tipologia negoziale riguarda la prestazione di servizi telematici privati, i quali, in mancanza di specifiche norme legislative, sono disciplinati dalle norme contenute negli accordi che intervengono fra fruitore e fornitore di servizio. I contratti telematici sono contratti atipici, che nascono dall'autonomia negoziale e che proprio nell'autonomia devono trovare la principale fonte di regolamentazione. Nel presente articolo analizzeremo meglio la natura giuridica di questo tipo di contratti, nonché alcuni aspetti peculiari ad essi relativi. Natura giuridica e normativa applicabile La natura giuridica di tale contratto è controversa, tanto che si è ritenuto potesse essere inquadrata nello schema della vendita che ha come oggetto un particolare bene giuridico, ossia l'informazione. Altra parte della dottrina sostiene invece si tratti piuttosto di un appalto di servizi che deve essere svolto dal fornitore del servizio telematico per assicurare all'utente la effettiva realizzazione del valore dell’informazione. In altri casi è stato affermato che si tratti di una particolare figura del contratto di somministrazione. Indipendentemente dall'applicazione a questo tipo di contratto della disciplina di contratto di vendita, appalto o somministrazione, si ritiene applicabile in ogni caso l'art. 1218 c.c. nell'ipotesi di inadempimento, a prescindere dalla tipologia di accordo intercorso tra le parti, fermo restando l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il danno qualora non abbia adempiuto all'obbligazione sorta. A tal proposito si rileva come l'esame delle clausole contrattuali sia rilevante in quanto è in queste che va ricercata la chiave per comprendere il rilievo degli obblighi reciproci delle parti. Infatti, se da un lato non si può mai prescindere dall'accordo tra le parti, dall'altro non è del tutto priva di rilievo l'attività diretta a verificare ogni volta l'analogia con le prestazioni disciplinate dal Legislatore per la risoluzione di casi controversi. Nei contratti telematici, per via del particolare oggetto dell'accordo, la dottrina pone in discussione l'uso delle definizioni tradizionali nel contesto delle transazioni telematiche. Ciò che accomuna e caratterizza questi nuovi contratti è la predisposizione di una parte documentale relativa alle specifiche tecniche del bene o del servizio che si propone all'acquirente. Le specifiche tecniche dei servizi telematici costituiscono un elemento imprescindibile per la determinazione della stessa prestazione contrattuale, tale da giustificare il ricorso a mezzi di tutela giudiziali o stragiudiziali in caso di mancanza dei requisiti tecnici menzionati negli allegati. Nonostante le specifiche tecniche non possano essere considerate elementi secondari che eccezionalmente divengono centrali, a ben considerare si tratta di un'applicazione nel settore informatico del vecchio ...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso