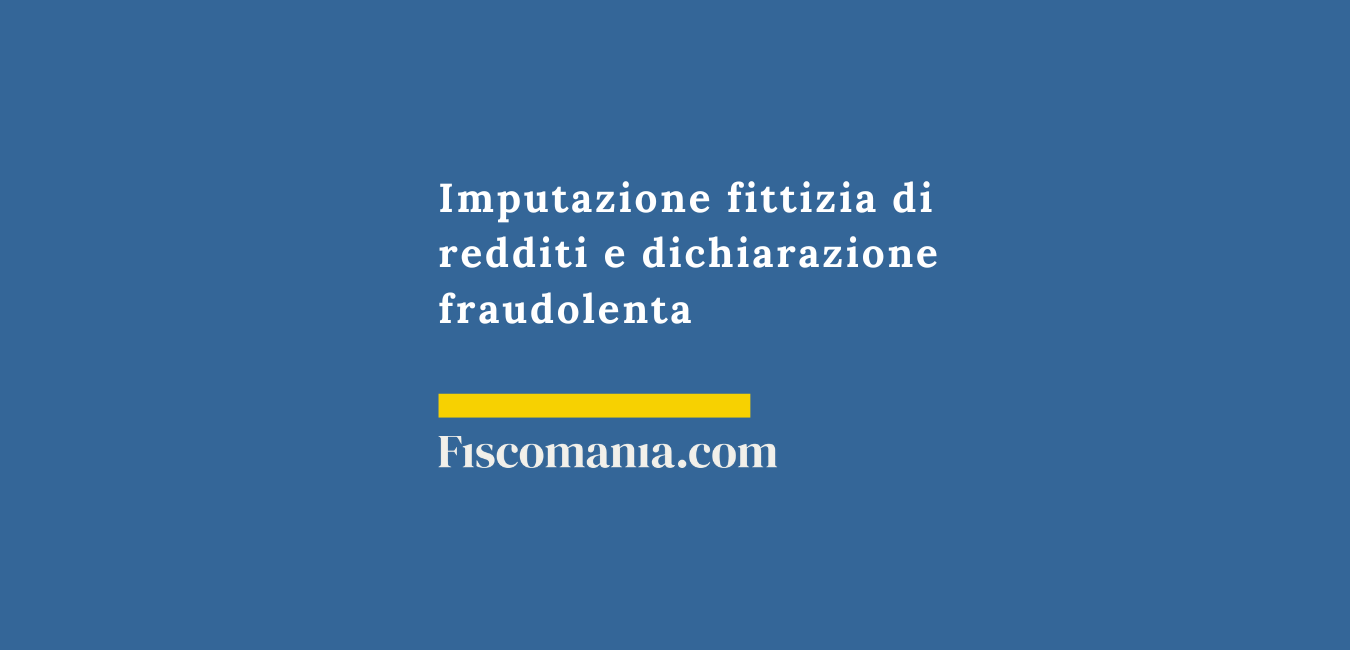La sentenza n. 37939/2025 della Corte di Cassazione chiarisce quando l’interposizione fittizia di redditi ad un soggetto diversi configura reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 37939 depositata il 21 novembre 2025, ha precisato che l’imputazione fittizia di redditi ad un soggetto diverso da quello che e effettivamente li possiede non può configurare abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/00, ma potrebbe integrare la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/00. Questa decisione delimita rilevanti conseguenze sulla punibilità penale delle operazioni fraudolente nel contesto internazionale.
La decisione riveste particolare interesse per i professionisti che assistono gruppi societari con articolazioni internazionali, poiché delinea con precisione quando determinate condotte fuoriescono dall’area della mera pianificazione fiscale aggressiva per entrare nel perimetro della rilevanza penale tributaria.
Indice degli argomenti
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata della sentenza, è necessario richiamare le principali disposizioni normative in gioco:
L’art. 37, comma 3, DPR n. 600/73: interposizione fittizia
La norma stabilisce che: “sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona“.
Si tratta di una specifica disposizione antielusiva che consente all’Amministrazione finanziaria di riattribuire i redditi al soggetto effettivo, disconoscendo l’interposizione fittizia di persone fisiche o giuridiche.
L’art. 10-bis, L. n. 212/00: abuso del diritto
Questa disposizione, introdotta e riformulata dal D.Lgs. n. 128/15, disciplina l’abuso del diritto fiscale, definito come una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Il comma 12 precisa che “l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando le violazioni di specifiche disposizioni tributarie“.
Il comma 13 stabilisce il principio fondamentale: “Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie“.
L’art. 3, D.Lgs. n. 74/00: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La fattispecie penale punisce chi, “fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 4, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria“, indica in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro.
L’art. 1, comma 1, lett. g-bis), D.Lgs. n. 74/00: definizione di operazioni simulate
Questa disposizione, introdotta anch’essa dal D.Lgs. 158/2015, chiarisce che “per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti“.
Il caso esaminato dalla Cassazione
Il caso sottoposto a Cassazione riguarda un complesso schema operativo realizzato da un gruppo internazionale di società (gruppo Alfa):
- Società operativa italiana: Alfa D. s.r.l., produttrice di autovetture;
- Società estere del gruppo: Alfa I. s.a., Alfa P. a.g., Alfa P. g.m.b.h., Alfa P.M. d.m.c.c. ubicate in giurisdizioni a fiscalità più vantaggiosa;
Lo schema contestato prevedeva:
- Imputazione fittizia dei ricavi di vendita alle società estere del gruppo;
- Realizzazione della produzione e effettiva di autovetture presso lo stabilimento italiano di Alfa D. s.r.l.;
- Ricezione da parte di Alfa D. s.r.l. di erogazioni dalle società estere, formalmente a titolo di corrispettivo per cessioni di know-how e brevetti;
- Iscrizione contabile di tali erogazioni nello stato patrimoniale (voce “futuro aumento di capitale sociale“) e non nel conto economico, escludendole dalla determinazione del reddito imponibile.
L’ipotesi accusatoria
Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, il gruppo avrebbe posto in essere una struttura artificiosa finalizzata a sottrarre ricavi alla tassazione italiana, mediante il seguente meccanismo:
- La produzione dei veicoli sarebbe stata effettivamente realizzata in Italia dalla Alfa D. s.r.l.;
- I ricavi delle vendite sarebbero stati imputati alle società estere del gruppo, situate in Stati a fiscalità più vantaggiosa;
- Le somme necessarie per operare venivano erogate dalle società estere ad Alfa D. s.r.l. a titolo di corrispettivo per cessioni di know-how, brevetti e invenzioni brevettabili;
- Tali erogazioni venivano iscritte non nel conto economico ma nello stato patrimoniale, sotto la voce “futuro aumento di capitale sociale”, così da non incidere sulla determinazione del reddito imponibile.
Le contestazioni riguardavano gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, con un sequestro preventivo per oltre 4,4 milioni di euro.
Le difese degli indagati
Gli indagati (D.T.B., amministratore di Alfa D. s.r.l., e G.M., dirigente) hanno contestato l’ipotesi accusatoria producendo documentazione volta a dimostrare:
- La piena operatività delle società estere, preesistenti alla costituzione di Alfa D. s.r.l.;
- L’esistenza di contratti stipulati dalle società estere con fornitori terzi per la produzione di veicoli (2014-2017);
- L’assenza di elementi probatori sul trasporto di veicoli dall’Italia all’estero;
- La limitata capacità produttiva di Alfa D. s.r.l. nel 2017 (5 operai, 363.000 euro di materie prime, operativa solo da settembre).
I principi affermati dalla Suprema Corte
La Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Modena, ma nel farlo ha affermato alcuni principi di diritto.
L’interposizione fittizia non configura abuso del diritto
La Corte chiarisce che l’imputazione fittizia di redditi tramite interposizione di soggetti non può essere ricondotta all’abuso del diritto ex art. 10-bis, L. n. 212/00, per una precisa ragione sistematica:
“L’art. 37, terzo comma, DPR n. 600 del 1973 prevede le fattispecie di interposizione, fittizia e reale […] dettando una disciplina specifica“
Poiché l’art. 10-bis, comma 12, stabilisce che l’abuso del diritto può essere configurato “solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando le violazioni di specifiche disposizioni tributarie“, e poiché esiste una norma specifica (l’art. 37, co. 3, DPR n. 600/73) che disciplina l’interposizione fittizia, ne consegue che:
L’interposizione fittizia non rientra nell’abuso del diritto e, quindi, non beneficia della clausola di non punibilità prevista dall’art. 10-bis, comma 13.
L’interposizione fittizia può configurare dichiarazione fraudolenta
La Corte procede oltre, evidenziando come l’art. 1, comma 1, lett. g-bis), D.Lgs. n. 74/00 ricomprenda espressamente tra le “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” anche “le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti“.
Poiché l’art. 3, D.Lgs. n. 74/00 punisce chi evade le imposte “compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente“, ne deriva che:
L’interposizione fittizia può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ove ricorrano gli ulteriori presupposti (soglia di imposta evasa, mezzi fraudolenti idonei, ecc.).
L’applicazione residuale dell’abuso del diritto rispetto alle fattispecie fraudolente
La sentenza ribadisce un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 38016/2017 e n. 40272/2015):
“L’istituto dell’abuso del diritto […] ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa“
Quindi, l’esclusione della rilevanza penale opera solo per condotte elusive “pure”, non connotate da elementi di frode, simulazione o falsità documentale.
Le criticità rilevate nel caso concreto
Pur affermando i principi sopra esposti, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata per tre ordini di carenze motivazionali:
Mancata individuazione dei veicoli prodotti e trasferiti
La Corte rileva come il Tribunale abbia riconosciuto espressamente “l’incompletezza delle indagini della Guardia di Finanza e l’opportunità di tentare di meglio individuare i veicoli prodotti“, ritenendo tuttavia sufficiente il materiale investigativo acquisito.
Secondo la Cassazione, questa carenza è dirimente:
“Non è possibile comprendere come […] sia avvenuta l’imputazione fittizia a società estere dei ricavi realizzati in Italia da Alfa D. s.r.l., se non è data alcuna indicazione, anche solo parziale, dei beni dai quali deriverebbero questi ricavi“
La mancata individuazione dei veicoli rende le contestazioni “del tutto prive di concretezza“, anche sul profilo del trasferimento dall’Italia all’estero.
Omessa considerazione delle spese operative
Il Tribunale ha calcolato il profitto confiscabile partendo dal bilancio consolidato del gruppo, ma omettendo di considerare le spese operative (Operating Expenses) pari a oltre 6,5 milioni di euro per il 2017.
La Cassazione rileva l’“assenza di motivazione […] su un profilo decisivo per la determinazione del profitto confiscabile”.
Mutamento del fatto contestato (posizione di G.M.)
All’indagato G.M. era stata contestata una condotta commissiva (“realizzazione e attuazione della struttura artificiosa“), mentre il Tribunale ha ritenuto una condotta omissiva (mancato intervento per impedire le irregolarità).
La Corte ribadisce il principio consolidato per cui “il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento […] sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi“.
Inoltre, non è stata individuata alcuna posizione di garanzia che potesse fondare una responsabilità omissiva.
Implicazioni pratiche
La sentenza offre importanti spunti che meritano particolare attenzione. Sul fronte della pianificazione con società estere, occorre innanzitutto evidenziare come l’utilizzo di entità localizzate in giurisdizioni a fiscalità privilegiata per ottimizzare il carico fiscale richieda necessariamente una sostanza economica effettiva. La mera esistenza formale delle società estere, con la relativa iscrizione nei registri societari locali e la nomina di amministratori, non è sufficiente a dimostrare l’effettività della struttura. Diventa invece imprescindibile documentare in modo puntuale l’esistenza di attività operative reali, l’autonomia delle decisioni assunte dagli organi sociali e i rischi effettivamente assunti dalle entità estere nell’ambito della catena del valore del gruppo.
In secondo luogo, emerge con chiarezza la distinzione tra interposizione fittizia e abuso del diritto. La prima è specificamente disciplinata dall’art. 37, co. 3, del DPR n. 600/73 e, proprio in quanto oggetto di una norma antielusiva specifica, non rientra nell’ambito di applicazione dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/00. Questa distinzione assume rilevanza sul piano penale, poiché l’interposizione fittizia può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 74/00, senza che possa operare la clausola di non punibilità prevista per le condotte meramente abusive.
Particolare attenzione deve essere riservata agli elementi probatori essenziali per dimostrare l’effettività delle operazioni. La documentazione da raccogliere e conservare comprende i contratti commerciali stipulati dalle entità estere con fornitori e clienti terzi, le fatture emesse e ricevute, i documenti di trasporto delle merci, le evidenze dei pagamenti effettuati e ricevuti, i bilanci certificati delle società estere che dimostrino la consistenza patrimoniale e la continuità operativa.
Infine, sul tema dell’imputazione dei ricavi, la sentenza ribadisce il principio secondo cui i proventi devono essere attribuiti al soggetto che effettivamente svolge l’attività economica dalla quale derivano, applicando una prospettiva sostanzialistica che prescinde dalla qualificazione formale delle operazioni. Le erogazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo devono necessariamente rispettare il principio di libera concorrenza, garantendo che i prezzi di trasferimento riflettano quelli che sarebbero stati praticati tra parti indipendenti in circostanze comparabili.
Consulenza fiscale online
Hai necessità di analizzare strutture societarie internazionali o verificare potenziali profili di rischio fiscale e penale?
Come commercialista specializzato in fiscalità internazionale, posso supportarti nell’analisi di compliance e nell’ottimizzazione di strutture cross-border nel rispetto della legalità.
Contattami per una consulenza personalizzata su fiscomania.com.
Fonti
- Art. 37, comma 3, DPR 600/1973
- Art. 10-bis, L. 212/2000
- Artt. 1 e 3, D.Lgs. 74/2000
- Cass. pen. n. 37939/2025
- Cass. pen. n. 38016/2017
- Cass. pen. n. 40272/2015