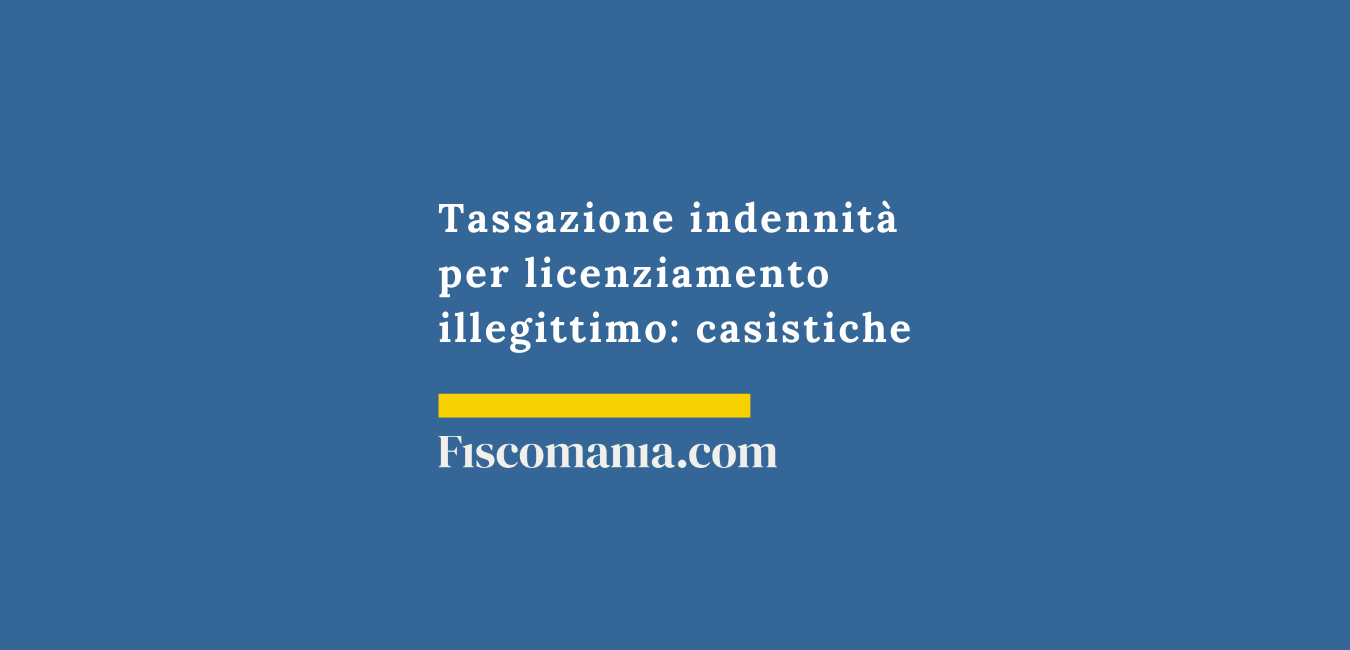Come determinare con certezza il trattamento fiscale delle somme ricevute dopo un licenziamento illegittimo: criteri distintivi tra lucro cessante e danno emergente. Risposte Agenzia Entrate n. 130/2024 e n. 222/2021.
Le indennità corrisposte a seguito di licenziamento “illegittimo” possono seguire tre trattamenti fiscali distinti: ordinaria IRPEF, tassazione separata o esenzione quando ricorre il danno emergente, e la scelta corretta dipende dalla causa giuridico‑economica dell’erogazione e dal suo inquadramento normativo e giurisprudenziale documentabile, non dal solo “nome” attribuito in transazione o sentenza.
Il principio cardine è quello tra lucro cessante (sostituzione di reddito) e danno emergente (reintegrazione patrimoniale), richiamato da TUIR e consolidato da prassi Agenzia Entrate e Corte di Cassazione, con casi specifici come l’indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 39, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015 soggetta a tassazione separata e la conciliazione “Jobs Act” ex art. 6 D.Lgs. n. 23/2015 che prevede una non imponibilità ad hoc. Questo articolo, con taglio operativo e riferimenti puntuali, consente di aiutare ad indentificare le varie casistiche possibili.
Indice degli argomenti
- I principi fondamentali della tassazione dei redditi da lavoro
- Lucro cessante soggetto a tassazione
- Danno emergente esente
- L’indennità risarcitoria onnicomprensiva
- La conciliazione del Jobs Act
- L’onere della prova: aspetto cruciale per il contribuente
- Tabella di riepilogo delle varie casistiche con trattamento fiscale
- Datore estero, lavoratore residente: imponibilità e trattati
- Consulenza fiscale online
- Fonti normative
I principi fondamentali della tassazione dei redditi da lavoro
Il sistema tributario poggia su due pilastri normativi fondamentali per la tassazione delle indennità lavorative. L’articolo 51 del TUIR sancisce il principio di onnicomprensività, stabilendo che costituisce reddito di lavoro dipendente qualsiasi somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dal titolo o dalla denominazione attribuita.
L’articolo 6, comma 2, del TUIR completa il quadro normativo precisando che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi mantengono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti. Questa norma rappresenta la chiave di volta per comprendere quando un’indennità diventa imponibile: se sostituisce retribuzioni non percepite, sarà tassata come se fossero stati percepiti i redditi originari.
Il principio di sostituzione
Il principio di sostituzione opera automaticamente ogni volta che esiste un nesso causale diretto tra la somma percepita e i redditi che il lavoratore avrebbe conseguito se il rapporto fosse proseguito regolarmente. Non rileva la denominazione formale attribuita dalle parti all’indennità, né le modalità di calcolo adottate. L’Amministrazione finanziaria guarda alla sostanza economica dell’operazione.
La Cassazione ha ribadito costantemente che spetta al contribuente fornire la prova che le somme percepite non hanno natura sostitutiva di redditi. In assenza di tale prova, opera una presunzione secondo cui le indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto compensano retribuzioni future non percepite.
Lucro cessante soggetto a tassazione
Il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno futuro derivante dall’interruzione del rapporto di lavoro. Si tratta di una perdita economica proiettata nel tempo, quantificabile in base alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito.
Esistono elementi oggettivi che permettono di identificare quando un’indennità configura lucro cessante. Il primo indicatore è il metodo di calcolo: quando l’indennità viene determinata in base alla retribuzione mensile moltiplicata per un numero di mensilità, si presume che stia compensando redditi futuri. L’Agenzia delle Entrate considera questo criterio di calcolo come prova della natura sostitutiva dell’indennità.
Il secondo indicatore riguarda il periodo di riferimento. Se l’indennità copre un periodo successivo al licenziamento, compensando il tempo necessario per trovare una nuova occupazione o il periodo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, siamo in presenza di lucro cessante.
Il terzo elemento è la correlazione con l’anzianità di servizio. Le indennità parametrate agli anni di servizio prestato riflettono tipicamente una logica di compensazione per la perdita di un’aspettativa consolidata di continuità lavorativa.
Quando l’indennità è imponibile a IRPEF ordinaria
Sono imponibili a IRPEF le somme riconducibili a redditi di lavoro dipendente o assimilati, che compensano direttamente o indirettamente retribuzioni non percepite, anche se liquidate in sede giudiziale o transattiva. La risposta Agenzia delle Entrate n. 222/2021 ha confermato che un indennizzo liquidato dal Tribunale con riferimento al trattamento economico previsto dal CCNL integra arretrati di reddito di lavoro da assoggettare a ritenute IRPEF ex art. 24 DPR n. 600/1973, risultando irrilevante la mera etichetta “risarcitoria” se vi è chiaro collegamento con il rapporto e con retribuzioni dovute. In via pratica, per il sostituto d’imposta ciò comporta l’applicazione delle ritenute alla fonte al momento del pagamento, la certificazione in CU e l’esposizione come redditi di lavoro dipendente o assimilati, secondo la ricostruzione giuridica di sentenza o accordo.
Quando si applica la tassazione separata
Ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. b), TUIR, gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di sentenze, atti o cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione separata con meccanismo di ricalcolo della media storica, riducendo l’effetto di progressività su importi “concentrati”. L’Agenzia Entrate, con risposta n. 130/2024, ha qualificato l’indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 39, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015 come risarcimento per perdita di redditi di lavoro dipendente, di natura sostitutiva, da assoggettare a tassazione separata ex artt. 17 e 21 TUIR. La ragione è che tale indennità “ristora per intero il pregiudizio” includendo conseguenze retributive e contributive sul periodo giudizialmente considerato, con un collegamento diretto alla mancata retribuzione e non a un danno emergente autonomo.
Il calcolo dell’imposta avviene determinando prima il reddito di riferimento, costituito dalla media dei redditi complessivi netti dei due anni precedenti. Su questo importo medio si calcola l’IRPEF con le aliquote ordinarie. L’aliquota media così determinata si applica poi all’indennità percepita.
Danno emergente esente
Il danno emergente rappresenta una diminuzione effettiva del patrimonio del lavoratore, non collegata alla perdita di redditi futuri. Il risarcimento di tale danno ha natura puramente reintegrativa e non genera materia imponibile.
Il danno biologico rappresenta la categoria più consolidata di danno emergente. I danni alla salute fisica o psichica causati dall’ambiente lavorativo, dalle modalità di svolgimento della prestazione o da comportamenti illeciti del datore di lavoro generano sempre diritto a un risarcimento esente da imposizione. La quantificazione segue le tabelle del danno biologico e non ha alcuna correlazione con la retribuzione.
Il danno esistenziale comprende le sofferenze e i disagi che alterano le normali abitudini di vita del lavoratore. Il demansionamento prolungato, il mobbing sistematico, le discriminazioni possono generare questo tipo di danno. L’esenzione fiscale si applica quando il risarcimento compensa specificamente questi pregiudizi non patrimoniali.
Il danno all’immagine e alla reputazione professionale configura danno emergente quando il comportamento illegittimo del datore di lavoro ha compromesso la credibilità del lavoratore nel mercato. Si pensi al licenziamento per giusta causa poi dichiarato illegittimo, accompagnato da comunicazioni diffamatorie nel settore di riferimento.
La perdita di chance, quando correttamente documentata, rappresenta la perdita di un’opportunità concreta e non la mancata percezione di redditi. La Cassazione ha chiarito che deve trattarsi di possibilità attuali, non di mere aspettative. Ad esempio, la perdita di un concorso già bandito a cui il lavoratore non ha potuto partecipare per il licenziamento illegittimo.
L’ordinanza Cass. n. 8031/2021, richiama la non imponibilità delle indennità per danno emergente e ribadisce la tassazione solo in presenza di lucro cessante, con onere di dimostrare l’assenza di nesso col rapporto e con il reddito sostituito
I criteri distintivi fondamentali
La distinzione tra lucro cessante e danno emergente richiede un’analisi che va oltre le apparenze formali. Il primo criterio distintivo riguarda la temporalità: il danno emergente si riferisce a pregiudizi già verificatisi o in corso, mentre il lucro cessante proietta la perdita nel futuro.
Il secondo criterio attiene alla misurabilità: il lucro cessante si quantifica sempre in relazione alla retribuzione (tante mensilità), mentre il danno emergente richiede una valutazione autonoma del pregiudizio subito, spesso attraverso perizie o tabelle specifiche.
Il terzo elemento distintivo è la causalità: nel lucro cessante il nesso causale è con i redditi futuri non percepiti, nel danno emergente è con il pregiudizio effettivamente subito dal patrimonio o dalla persona.
L’indennità risarcitoria onnicomprensiva
L’articolo 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede un’indennità risarcitoria onnicomprensiva per violazioni nell’utilizzo della somministrazione di lavoro. Questa fattispecie offre un esempio perfetto di come l’Amministrazione finanziaria applica i principi generali.
Con la risposta all’interpello n. 130/2024, l’Agenzia ha analizzato dettagliatamente questa indennità. Il caso riguardava una lavoratrice somministrata che aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento dell’illegittimità dei contratti di somministrazione e la condanna dell’azienda al pagamento di 2,5 mensilità.
L’Agenzia ha evidenziato che l’indennità “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive“. Questa formulazione è decisiva: includendo espressamente le conseguenze retributive, la norma qualifica l’indennità come compensativa di redditi non percepiti.
La determinazione dell’indennità in base a un multiplo delle mensilità retributive conferma ulteriormente la natura di lucro cessante. Il parametro retributivo utilizzato per il calcolo dimostra che la somma è commisurata al reddito perduto, non a un danno di altra natura.
La qualificazione come lucro cessante comporta l’obbligo per il sostituto d’imposta di operare le ritenute d’acconto IRPEF. L’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR stabilisce che la tassazione separata si applica obbligatoriamente agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti“.
Il sostituto d’imposta deve:
- Applicare inizialmente le ritenute d’acconto con le aliquote ordinarie IRPEF al momento del pagamento;
- Rilasciare la certificazione (CU) indicando che le somme sono soggette a tassazione separata;
- Il contribuente in sede di dichiarazione dei redditi applicherà il regime di tassazione separata, calcolando l’imposta definitiva e recuperando l’eventuale eccedenza di ritenute subite.
La conciliazione del Jobs Act
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 23/2015 introduce un regime eccezionale per le conciliazioni relative ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. La norma prevede l’esenzione totale da IRPEF e contributi per le somme offerte dal datore di lavoro entro 60 giorni dal licenziamento.
L’esenzione opera solo se sono rispettate condizioni tassative. L’offerta deve provenire esclusivamente dal datore di lavoro, non essendo ammesse proposte del lavoratore. Il termine di 60 giorni dal licenziamento è perentorio: decorso tale termine, qualsiasi accordo segue il regime ordinario.
La somma deve essere compresa tra 2 e 18 mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR. Importi inferiori o superiori non beneficiano dell’esenzione. Il pagamento deve avvenire mediante assegno circolare, modalità che garantisce l’immediata disponibilità della somma.
L’accordo deve essere concluso in una delle sedi protette previste dalla legge: commissioni di conciliazione, direzioni territoriali del lavoro, sedi sindacali. Gli accordi raggiunti in altre sedi non beneficiano del regime agevolato.
Le criticità del sistema
Questa esenzione totale crea una evidente disparità di trattamento. Due lavoratori nella stessa situazione di licenziamento illegittimo subiscono un trattamento fiscale completamente diverso a seconda che accettino la conciliazione o procedano giudizialmente.
La dottrina ha evidenziato possibili profili di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva. Il legislatore ha giustificato la misura con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, ma questo obiettivo di politica giudiziaria difficilmente può giustificare una così marcata disparità fiscale.
L’onere della prova: aspetto cruciale per il contribuente
La corretta qualificazione fiscale dell’indennità dipende dalla capacità del contribuente di fornire prove adeguate sulla natura del danno risarcito. La giurisprudenza ha elaborato principi stringenti in materia di onere probatorio.
La Cassazione ha stabilito che le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto si presumono compensative di redditi futuri. Questa presunzione opera automaticamente quando l’indennità è calcolata in base alla retribuzione e non esistono elementi che dimostrino una diversa natura del risarcimento.
Per superare questa presunzione, il contribuente deve fornire prove specifiche e circostanziate. Non sono sufficienti le qualificazioni formali contenute negli accordi transattivi o le generiche affermazioni sulla natura risarcitoria delle somme.
Gli elementi probatori necessari
Per dimostrare il danno emergente servono prove documentali specifiche. Nel caso di danno biologico, sono necessari certificati medici, referti, perizie medico-legali che attestino le patologie e il nesso causale con l’attività lavorativa. La documentazione deve essere contemporanea o comunque riferibile al periodo in cui il danno si è manifestato.
Per il danno esistenziale, occorre documentare le concrete alterazioni della vita quotidiana: testimonianze, relazioni psicologiche, evidenze delle limitazioni subite. Il demansionamento deve essere provato con ordini di servizio, comunicazioni aziendali, testimonianze colleghi.
Il danno all’immagine professionale richiede la prova della diffusione di notizie lesive e del pregiudizio concreto subito: articoli di stampa, comunicazioni nel settore, mancate opportunità professionali direttamente riconducibili alla lesione reputazionale.
Tabella di riepilogo delle varie casistiche con trattamento fiscale
| Fattispecie | Qualificazione fiscale | Base giuridica | Operatività sostituto |
|---|---|---|---|
| Indennità che sostituisce retribuzioni (mancato reddito) | Imponibile IRPEF come lavoro dipendente/assimilato | Art. 6, c. 2, e 51 TUIR; AE 222/2021 | Ritenute ex art. 24 DPR 600/1973; CU come redditi di lavoro |
| Indennità risarcitoria onnicomprensiva art. 39, c. 2, d.lgs. 81/2015 | Imponibile a tassazione separata | AE 130/2024; art. 17 TUIR | Liquidazione con tassazione separata; conguagli a norma |
| Danno emergente provato (danno alla persona/immagine/chance) | Non imponibile (esente) | Art. 6, c. 2, TUIR; Cass. 8031/2021 (ricostruita) | Nessuna ritenuta; documentazione causale probatoria |
| Conciliazione “Jobs Act” art. 6 d.lgs. 23/2015 | Non imponibile IRPEF e non soggetta a contributi | Art. 6 d.lgs. 23/2015; dottrina e commenti | Pagamento con assegno circolare in sede protetta; esclusione da CU imponibile |
Datore estero, lavoratore residente: imponibilità e trattati
In assenza di trattato, l’indennità corrisposta a un residente italiano è attratta a tassazione in Italia per il principio del worldwide taxation, fermo restando che, sul piano sostanziale, trattandosi di somme sostitutive di reddito da lavoro, seguono il regime dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e non perdono imponibilità per la sola natura “risarcitoria” dell’erogazione.
In ambito convenzionale, l’art. 15 OCSE prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza salvo che il lavoro sia stato esercitato nell’altro Stato, nel qual caso le remunerazioni (inclusi i pagamenti alla cessazione) sono imponibili anche nello Stato della fonte, con eventuale deroga della “183 giorni” ove ricorrano le condizioni del paragrafo 2. La prassi nazionale, in linea con il Commentario OCSE, qualifica i pagamenti da cessazione come redditi di lavoro imponibili ai sensi dell’art. 15 e richiede il riparto in base ai periodi/luoghi di effettivo esercizio dell’attività quando l’impiego si è svolto in più giurisdizioni, applicando il credito d’imposta estero in Italia sul relativo segmento, se tassato all’estero.
Come si applicano le Convenzioni (art. 15 OCSE)
Le somme corrisposte in occasione della cessazione “devono ricevere lo stesso trattamento fiscale dei redditi che vanno a sostituire”, secondo il Commentario art. 15 (par. 2.8), per cui la regola è l’attrazione all’art. 15 e non all’art. 21 “Altri redditi” quando il pagamento è collegato all’attività lavorativa svolta prima della cessazione. Inoltre, il Commentario chiarisce che le remunerazioni post‑cessazione relative al lavoro svolto prima dell’interruzione si considerano derivanti dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata, a supporto del criterio di riparto per luogo di lavoro nei casi multigiurisdizionali (par. 2.4). Fanno eccezione talune ipotesi “non direttamente collegate” al lavoro svolto (es. corrispettivi per patti di non concorrenza), per le quali il Commentario indica di regola la tassazione nello Stato di residenza al momento della percezione, non essendovi un legame sufficientemente diretto con l’attività pregressa svolta in altro Stato (par. 2.9).
Esempio operativo di riparto
Se l’indennità di cessazione riguarda periodi lavorati interamente in Italia, l’importo è imponibile solo in Italia, anche se corrisposto da un datore estero, in quanto reddito di lavoro esercitato in Italia ai sensi dell’art. 15 della Convenzione applicabile. Se parte dell’anzianità cui l’indennità si riferisce è stata svolta in un altro Stato convenzionato (es. Svizzera o Paesi Bassi), la relativa quota può essere imponibile anche nello Stato estero in base al criterio del luogo di esercizio e, in taluni trattati, alla condizione di superamento della “183 giorni”, con l’Italia che riconosce il credito per le imposte pagate all’estero sulla porzione estera. In via sistematica, la soluzione più aderente al Commentario OCSE è la scomposizione dell’indennità in quote imputabili ai diversi periodi/Paesi di svolgimento dell’attività, applicando a ciascuna quota le regole di tassazione della Convenzione pertinente e i meccanismi di eliminazione della doppia imposizione nello Stato di residenza.
Attenzione alle qualificazioni “non retributive”
Le Amministrazioni e i giudici tendono a ricondurre le indennità di licenziamento illegittimo all’art. 15 quando il pagamento sostituisce salari/arretrati o è calcolato su parametri retributivi e anzianità, mentre solo somme realmente “non reddituali” e non collegate al lavoro svolto possono scivolare fuori dall’art. 15, tipicamente verso l’art. 21 o regole specifiche indicate dal Commentario (es. non concorrenza).
Per evitare conflitti di qualificazione tra Stati, è decisivo documentare la natura dell’importo in transazione o in sentenza e, se necessario, concordare criteri di riparto coerenti con il luogo di lavoro effettivo, come più volte ribadito dalla prassi nazionale su cessazioni e TFR transnazionali. In ogni caso, per il residente, l’eventuale tassazione estera su quote riferite a lavoro svolto all’estero è neutralizzata tramite credito d’imposta in Italia, nei limiti e con le modalità previste dalla Convenzione e dalla normativa interna di rinvio al diritto convenzionale.
Consulenza fiscale online
La corretta gestione fiscale delle indennità da licenziamento richiede una comprensione approfondita della distinzione tra lucro cessante e danno emergente. Il contribuente deve essere consapevole che la qualificazione fiscale non dipende dalle denominazioni formali ma dalla sostanza economica dell’operazione.
Se stai affrontando una situazione di cessazione del rapporto di lavoro o hai ricevuto un’indennità di cui non conosci il trattamento fiscale, siamo disposizione per una consulenza personalizzata. Analizzeremo il tuo caso specifico, valuteremo la documentazione disponibile e ti guideremo verso la soluzione fiscalmente più vantaggiosa.
Fonti normative
- D.Lgs. n. 81/2015, art. 39, comma 2
- D.Lgs. n. 23/2015, art. 6 (Jobs Act)
- DPR n. 917/1986 (TUIR), artt. 6, 17, 51
- DPR n. 600/1973, art. 24
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 130/2024
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 222/2021
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 155/E del 2002
- Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8031/2021
- Corte di Cassazione, Sentenza n. 360/2009
- Corte di Cassazione, Sentenza n. 6572/2006 SS.UU.